IMMIGRAZIONE: ACCOGLIENZA O CONTENIMENTO ? UN NUOVO APPROCCIO (I)
di Massimo D’Angelo
UN PIANO MARSHALL PER L’IMMIGRAZIONE: UNA NOVITÀ, UNA SOLUZIONE, UN’ILLUSIONE O COS’ALTRO?
Un Piano Marshall per l’immigrazione è una novità?
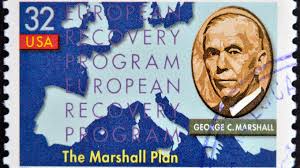 “Facciamo un Piano Marshall per aiutare gli immigranti a casa loro”. Sai che novità? Ho pensato istintivamente. Per me che mi sono sempre occupato professionalmente di aiuto allo sviluppo, questo richiamo al Piano Marshall come soluzione magica all’immigrazione dilagante dal sud del mondo suona come la scoperta dell’acqua calda: niente di nuovo. Sono anche molto perplesso, perché non credo che sia la risposta ai problemi dell’immigrazione. Ma mi rendo conto che debbo giustificare questa reazione. L’alternativa è più misure di respingimento (troppo inumane ed ingenerose per i sostenitori di politiche più aperte, oppure inutili, visto che gli immigrati trovano sempre il modo di penetrare le frontiere) o l’adozione, su vasta scala, di misure di accoglienza e di integrazione, che non sono molto popolari o elettoralmente spendibili. Infatti anche gli elettori più moderati o meno ostili all’immigrazione, che magari rimangono inorriditi di fronte alle tragedie di immigrati affogati, sono reticenti ad estendere l’ accoglienza (“mica possiamo farli entrare tutti!”). Per cui l’idea di un Piano Marshall per l’immigrazione appare una buona alternativa, un escamotage per attenuare le tensioni tra immigranti e cittadini, riducendo la pressione migratoria sempre più intensa, ed evitando il ricorso esclusivo al respingimento diretto. Lo slogan “aiutiamoli a casa loro” costa qualche milione di euro per finanziare programmi che permettano ai migranti di restare “a casa loro”, offrendo prospettive di lavoro nel paese di origine. La tesi è la seguente: meglio un programa di aiuti che affrontare costosi programmi di accoglienza e di integrazione per incontrollabili flussi migratori, anche se nessuno può assicurare che i soldi spesi nei programmi di aiuto produrranno risultati concreti sull’immigrazione, ma vale la pena rischiare, visti i benefici attesi (riduzione dei flussi migratori). Un Piano simile sarebbe un modo per “salvare capre e cavoli”: ridurre le frizioni causate dall’immigrazione dilagante e aiutare i potenziali emigranti (però a casa loro).
“Facciamo un Piano Marshall per aiutare gli immigranti a casa loro”. Sai che novità? Ho pensato istintivamente. Per me che mi sono sempre occupato professionalmente di aiuto allo sviluppo, questo richiamo al Piano Marshall come soluzione magica all’immigrazione dilagante dal sud del mondo suona come la scoperta dell’acqua calda: niente di nuovo. Sono anche molto perplesso, perché non credo che sia la risposta ai problemi dell’immigrazione. Ma mi rendo conto che debbo giustificare questa reazione. L’alternativa è più misure di respingimento (troppo inumane ed ingenerose per i sostenitori di politiche più aperte, oppure inutili, visto che gli immigrati trovano sempre il modo di penetrare le frontiere) o l’adozione, su vasta scala, di misure di accoglienza e di integrazione, che non sono molto popolari o elettoralmente spendibili. Infatti anche gli elettori più moderati o meno ostili all’immigrazione, che magari rimangono inorriditi di fronte alle tragedie di immigrati affogati, sono reticenti ad estendere l’ accoglienza (“mica possiamo farli entrare tutti!”). Per cui l’idea di un Piano Marshall per l’immigrazione appare una buona alternativa, un escamotage per attenuare le tensioni tra immigranti e cittadini, riducendo la pressione migratoria sempre più intensa, ed evitando il ricorso esclusivo al respingimento diretto. Lo slogan “aiutiamoli a casa loro” costa qualche milione di euro per finanziare programmi che permettano ai migranti di restare “a casa loro”, offrendo prospettive di lavoro nel paese di origine. La tesi è la seguente: meglio un programa di aiuti che affrontare costosi programmi di accoglienza e di integrazione per incontrollabili flussi migratori, anche se nessuno può assicurare che i soldi spesi nei programmi di aiuto produrranno risultati concreti sull’immigrazione, ma vale la pena rischiare, visti i benefici attesi (riduzione dei flussi migratori). Un Piano simile sarebbe un modo per “salvare capre e cavoli”: ridurre le frizioni causate dall’immigrazione dilagante e aiutare i potenziali emigranti (però a casa loro).
Il Piano, che non copre tutte le forme di immigrazione, ma solo quelle provenienti da paesi più fragili e con economie più povere, ha certamente un costo finanziario per il paese “donante”, ma la spesa sarebbe inferiore rispetto ai costi finanziari e politici di ondate massicce di immigranti.
Chi propone un Piano Marshall per l’immigrazione?
La proposta di un simile piano viene ripetuta da varie parti dello spettro politico, e riflette le opinioni di una certa parte della stampa[1] e dell’opinione pubblica, ed in particolare di:
(a) Coloro che vogliono “genuinamente” aiutare gli immigranti, ma intendono evitare loro le sofferenze per viaggi disagiati, traversate in imbarcazioni pericolanti e tante vite umane perse in tragici naufragi. La soluzione starebbe nell’affrontare direttamente i fattori che spingono all’emigrazione. Meglio cercare di indurre le persone a non lasciare il proprio paese.
(b) Coloro che, pur proponendo assistenza agli immigranti e ai rifugiati e varie forme di accoglienza e di integrazione, pensano che sia urgente cominciare a risolvere i problemi dell’immigrazione alla fonte, anziché limitarsi a bloccare gli immigrati irregolari alle frontiere, sulle nostre spiagge, mentre varcano passi alpini o attraversano deserti o fiumi, o nascosti in TIR o nei treni, o salvarli dai naufragi.
(c) Coloro che vogliono difendere i confini “patri” dalle invasioni di etnie diverse provenienti da altre regioni geografiche (“bisogna fermare questi flussi, vere e proprie valanghe umane”), ma non se la sentono di enfatizzare solo i respingimenti, considerati spesso violenti e disumani, e politicamente “scorretti” (una cattiva immagine che li sottometterebbe alle critiche di chi difende i diritti umani). Meglio soluzioni più morbide, specialmente se producono lo stesso risultato (la riduzione dei flussi).
(d) O, semplicemente, coloro che non vogliono più essere disturbati dalle immagini degradanti di immigranti onnipresenti che vagolano nel territorio nazionale, che dormono sui marciapiedi, o davanti le nostre chiese, mendicanti all’uscita dei supermercati, valanghe di “voi cumprà” lungo le nostre spiagge o agli angoli delle strade. È molto meglio se spostiamo queste immagini di sofferenze umane altrove, a qualche migliaia di chilometri di distanza. Tutto sommato, “occhio non vede, cuore non duole”.
La proposta di un simile Piano non sostitusce le altre misure ma si aggiunge al ventaglio degli strumenti disponibili. Leggendo su La Repubblica del 19 gennaio 2018 la recensione del libro del sociologo Stefano Allievi, Immigrazione. Cambiare tutto (Edizione Laterza) – che verrà presentato il 9 febbraio (sto scrivendo il 23 gennaio 2018) – ho notato che anche lui suggerisce, tra le varie soluzioni, un Piano Marshall per l’immigrazione, ed il superamento della distinzione tra riflugiati ed immigrati economici. Un simile Piano Marshall può essere visto come un’alternativa all’eccessiva spesa pubblica per assistere gli immigrati in arrivo, ritenuta elettoralmente insostenibile. Alcune forze politiche considerano l’impiego di fondi pubblici per l’accoglienza agli immigrati come una ingiustizia: “Perché aiutare gli altri quando ci sono ancora tanti cittadini bisognosi che non riescono ad essere assistiti?” Ed in una sorta di “guerra tra poveri”, sostengono “prima i nostri cittadini e poi gli altri”. Un Piano Marshall per l’immigrazione sembrerebbe superare questa contrapposizione, per lo meno in parte. Alcune proposte fatte dal Presidente del Consiglio Gentiloni (e prima di lui, da Matteo Renzi) vanno in questa direzione, anche se il Ministro Minniti si è concentrato più sul respingimento e sugli accordi con la Libia ed altri paesi, ed il rafforzamento dei controlli di frontiera, pur appongiando l’accoglienza in vario modo. A dire il vero, le posizioni di Minniti vanno in varie direzioni, appoggiando anche la riforma del c.d. Ius Soli, l’integrazione degli immigrati, e l’avvio di interventi come i “cordoni umanitari”. Peccato che chi propone un simile Piano Marshall non dedichi sufficiente spazio alla sua fattibilità, ai tempi necessari, alle sue difficoltà, e alla necessità di accettare che i flussi migratori continueranno ad arrivare con frequenze sostenute e con volumi elevati ancora per molti anni, se non per decenni.
Obiettivo finale: riduzione dei flussi migratori
 Se un Piano Marshall per l’immigrazione funzionasse, sostiene la teoria, si ridurrebbero gli arrivi degli immigranti irregolari, ma questa riduzione avverrebbe agendo alla fonte, nei paesi d’origine, grazie a grandiosi piani di sviluppo, che creerebbero nuovi sbocchi produttivi e occupazionali, o con investimenti mirati a rimuovere (o attenuare) le cause strutturali o contingenti che determinano l’emigrazione. Una versione diversa di questa proposta – a dire il vero meno pubblicizzata, forse volutamente, perché più ambigua (e l’ambiguità non sembra essere casuale) – potrebbe essere l’uso della cooperazione allo sviluppo solo come mezzo di scambio, sia con i paesi da cui provengono gli immigranti che con paesi “terzi” ove essi siano in transito, affinché le autorità di questi paesi adottino misure disincentivanti o repressive che riducano le fila degli immigranti irregolari che affollano i nostri paesi. L’effetto dei programmi di aiuto in tal caso non sarebbe una modifica della propensione ad emigrare, ma un incentivo per il paese che riceve gli aiuti a ostacolare l’emigrazione o a reprimerla. L’obiettivo finale, comunque, sarebbe sempre quello di diminuire il flusso quantitativo di immigranti irregolari. Questo sarebbe il criterio di successo del nuovo Piano Marshall, lo stesso obiettivo delle misure di contenimento ed in particolare del respingimento alle frontiere, sia nel caso che questo avvenga lungo i nostri confini o in acque internazionali o in paesi terzi.
Se un Piano Marshall per l’immigrazione funzionasse, sostiene la teoria, si ridurrebbero gli arrivi degli immigranti irregolari, ma questa riduzione avverrebbe agendo alla fonte, nei paesi d’origine, grazie a grandiosi piani di sviluppo, che creerebbero nuovi sbocchi produttivi e occupazionali, o con investimenti mirati a rimuovere (o attenuare) le cause strutturali o contingenti che determinano l’emigrazione. Una versione diversa di questa proposta – a dire il vero meno pubblicizzata, forse volutamente, perché più ambigua (e l’ambiguità non sembra essere casuale) – potrebbe essere l’uso della cooperazione allo sviluppo solo come mezzo di scambio, sia con i paesi da cui provengono gli immigranti che con paesi “terzi” ove essi siano in transito, affinché le autorità di questi paesi adottino misure disincentivanti o repressive che riducano le fila degli immigranti irregolari che affollano i nostri paesi. L’effetto dei programmi di aiuto in tal caso non sarebbe una modifica della propensione ad emigrare, ma un incentivo per il paese che riceve gli aiuti a ostacolare l’emigrazione o a reprimerla. L’obiettivo finale, comunque, sarebbe sempre quello di diminuire il flusso quantitativo di immigranti irregolari. Questo sarebbe il criterio di successo del nuovo Piano Marshall, lo stesso obiettivo delle misure di contenimento ed in particolare del respingimento alle frontiere, sia nel caso che questo avvenga lungo i nostri confini o in acque internazionali o in paesi terzi.
Quando si potrebbe introdurre un Piano Marshall per l’immigrazione?
La proposta di un Piano Marshall per l’immigrazione potrebbe essere il leitmotif di nuove politiche d’immigrazione per territori come l’Unione Europea o gli Stati Uniti, anche se non ho visto proposte serie su questo, salvo menzioni en passant fatte da Macron, Gentiloni e Merkel. Potrebbe essere l’oggetto di convenzioni o di riunioni internazionali come quella del novembre 2017 ad Abidjan tra l’Europa e l’Africa che ha affrontato il rimpatrio di migliaia di migranti che affollano i campi libici. Ma finora un simile Piano non è stato messo all’ordine del giorno di nessun tavolo di lavoro internazionale. È vero che ad Abidjan si è parlato di stanziamenti di decine di milioni di euro, ma nell’incontro non è stato concordato alcun piano globale, e solo Paolo Gentiloni si è espresso nettamente per una intensificazione dei programmi di aiuto. In contrasto, il dibattito si è concentrato su misure contingenti per il rimpatrio più o meno volontario degli emigranti o per la loro ridistribuzione dai campi libici ritenuti non idonei verso altri campi garantiti dall’UNHCR o altre organizzazioni, per il rispetto dei diritti umani dei migranti.
Abidjan poteva essere l’occasione per lanciare un Piano Marshall per l’immigrazione, ma non lo è stato. I paesi europei non hanno raggiunto una posizione comune per un’accoglienza sistematica e condivisa, né c’è accordo per una cooperazione massiccia con l’Africa per risolvere i problemi dell’immigrazione. Non so quanto realistica sia la possibilità di varare un simile Piano Marshall, specialmente dopo la decisione del dicembre 2017 dell’amministrazione Trump di tirarsi fuori dal patto delle Nazioni Unite sulla gestione della migrazione internazionale, il c.d. “Global Compact”. Quel patto, lanciato nel 2016 al summit straordinario sui rifugiati e sui migranti con lo scopo di concordare politiche di accoglienza degli emigranti e dei rifugiati e permettere “una migrazione sicura, ordinata e regolare”, dovrebbe produrre un programma entro il 2018. Potrà il “Global Compact” essere la base di un Piano Marshall per l’immigrazione? O solo l’occasione per concordare obiettivi più o meno scontati, ripetendo affermazioni retoriche? È difficile fare previsioni nel presente clima politico internazionale.
Ogni tanto c’è qualcuno che chiede un Piano Marshall per l’aiuto ai paesi più poveri
Perché ho reagito con l’espressione “sai che novità!” sentendo parlare di un Piano Marshall per l’immigrazione? Perché nella storia di più di mezzo secolo della “cooperazione internazionale allo sviluppo” c’è sempre qualcuno che, insoddisfatto dei risultati ottenuti, rilancia l’idea di lanciare un Piano Marshall per risolvere i problemi dei paesi emergenti, sostenendo che gli aiuti sono pochi o frammentati in rivoli insignificanti, incapaci di produrre un impatto decisivo. L’unica alternativa sarebbe un’iniezione massiccia di nuovi finanziamenti in grado di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi con un salto di qualità. L’idea perciò non è nuova. La novità semmai consisterebbe nel legare gli aiuti agli effetti auspicati sui flussi migratori, aspetto che finora non è stato di certo al centro di tali programmi. “Facciamo un nuovo Piano Marshall!” mi diceva un collega quando lavoravo in Mozambico negli anni ’80. Lui era insoddisfatto di come stessero andando le cose in Africa, con l’esplosione di guerre civili e con una povertà dilagante, e sosteneva che paradossalmente ci fosse sola un’alternativa: “either a Marshall Plan or the martial law” (o un Piano Marshall o la legge marziale), probabilmente pensando alle molte operazioni di peace-keeping necessarie per confrontare i conflitti sempre più frequenti. Ricordo che gli risposi allo stesso modo: guarda che non stai proponendo proprio niente di nuovo.
Quando l’aiuto allo sviluppo fu inventato negli anni ’50, tutti facevano riferimento ai precedenti del Piano Marshall lanciato dal Presidente Truman alla fine della seconda guerra mondiale per ricostruire i paesi dell’Europa occidentale. Quella fu la scusa per mobilitare ingenti stanziamenti di bilancio nei paesi ad economia più avanzata per aiutare i paesi emergenti, molti dei quali avrebbero acquisito la propria indipendenza nel corso degli anni ’60. Ma presto ci si rese conto che un meccanismo come il Piano Marshall non avrebbe funzionato con i paesi in via di sviluppo nello stesso modo in cui cui aveva prodotto risultati ragguardevoli in Europa, per le differenze sostanziali tra i due gruppi di paesi. La storia della cooperazione internazionale allo sviluppo ha mantenuto, però, un aspetto del Piano Marshall, stabilendo obiettivi quantitativi ambiziosi per garantire massicci flussi di aiuto ed esercitare, in tal modo, un impatto decisivo. Si cominciò a parlare dell’1% del PIL da dedicare all’ “aiuto” sin dalla prima UNCTAD negli anni ’60. L’Assemblea Generale dell’ONU lanciò i “decenni dello sviluppo” e identificò “obiettivi” quantitativi come lo 0,7% del PIL per l’Aiuto Pubblico allo Sviluppo. Meccanismi di controllo come il DAC furono varati affinché i paesi “donatori” mantenessero i loro impegni.
Questi obiettivi quantitativi sono stati per lo più disattesi. Tuttavia, con l’arrivo del nuovo millennio, nuovi appelli li hanno riecheggiati, sottolineando la necessità di un “Big Push” nell’aiuto allo sviluppo per i paesi più poveri, invece di continuare a proporre modesti incrementi annuali. Frasi come “duplichiamo gli aiuti per l’Africa!” (raccomandati dalla Commissione Regionale per l’Africa delle Nazioni Unite all’inizio di questo millennio) o “produciamo un aumento massiccio di aiuti per miliardi di dollari per raggiungere gli obiettivi del Millennio”, son divenute frequenti. Per fare uscire i paesi a basso reddito dalla “trappola della povertà”, personaggi come Jeffrey Sachs[2] hanno proposto con insistenza un salto quantitativo degli investimenti necessari per migliorare la qualità del capitale umano (con interventi massicci nei settori della nutrizione, della sanità e dell’istruzione), o le infrastrutture di base (trasporti, servizi sanitari e reti idriche, equilibrio ambientale, politiche abitative) nei paesi più poveri, con miglioramenti sostanziali nella gestione della pubblica amministrazione. Tutto ciò richiede la combinazione di flussi massicci di risorse esterne ed incrementi significativi degli investimenti nazionali. Queste proposte richiamano l’idea di un nuovo Piano Marshall, e si basano sulla convinzione che solo attraverso un aumento sostanziale del volume di aiuti pubblici allo sviluppo si potrà fare un salto di qualità nel raggiungimento degli obiettivi ambiziosi di sviluppo stabiliti per i paesi più poveri. Quindi la novità di un Piano Marshall per l’immigrazione non sarebbe tanto nel proporre un salto quantitativo negli aiuti ai paesi più poveri quanto nel legarlo ai suoi possibili effetti sui flussi migratori da quei paesi. Spesso, quando si parla di un Piano Marshall per l’immigrazione, si pensa ad un sostegno specialmente per i paesi africani, anche se l’immigrazione rilevante non proviene soltanto da quel continente. Ma, di nuovo, pensare ad un Piano Marshall per l’Africa non risulta di per sé una grande novità, anche se chi lo sta proponendo oggi sta pensando ai barconi dalla Libia o alle traversate nel Sahara. Ma il continente africano non è nuovo a massicci flussi di aiuto, specialmente di provenienza europea (tra gli altri “donatori” ci sono Stati Uniti, Giappone, Canada e, più di recente, la Cina). Gli aiuti europei verso l’Africa assunsero una ruolo significativo nelle convenzioni di Yaoundé e di Lomé a partire dal 1963 e si estesero fin oltre il secolo XX,[3] accompagnando inizialmente la decolonizzazione con ingenti risorse, ma i risultati non furono sempre soddisfacenti. Riusciranno questi nuovi interventi a superare le inefficienze dei passati programmi di aiuto verso l’Africa? Siamo sicuri che questo Piano Marshall per l’immigrazione non sia un modo per reagire a fenomeni di aid fatigue, o un modo per riproporre, sotto nuove vesti, vecchi schemi?
necessità di un “Big Push” nell’aiuto allo sviluppo per i paesi più poveri, invece di continuare a proporre modesti incrementi annuali. Frasi come “duplichiamo gli aiuti per l’Africa!” (raccomandati dalla Commissione Regionale per l’Africa delle Nazioni Unite all’inizio di questo millennio) o “produciamo un aumento massiccio di aiuti per miliardi di dollari per raggiungere gli obiettivi del Millennio”, son divenute frequenti. Per fare uscire i paesi a basso reddito dalla “trappola della povertà”, personaggi come Jeffrey Sachs[2] hanno proposto con insistenza un salto quantitativo degli investimenti necessari per migliorare la qualità del capitale umano (con interventi massicci nei settori della nutrizione, della sanità e dell’istruzione), o le infrastrutture di base (trasporti, servizi sanitari e reti idriche, equilibrio ambientale, politiche abitative) nei paesi più poveri, con miglioramenti sostanziali nella gestione della pubblica amministrazione. Tutto ciò richiede la combinazione di flussi massicci di risorse esterne ed incrementi significativi degli investimenti nazionali. Queste proposte richiamano l’idea di un nuovo Piano Marshall, e si basano sulla convinzione che solo attraverso un aumento sostanziale del volume di aiuti pubblici allo sviluppo si potrà fare un salto di qualità nel raggiungimento degli obiettivi ambiziosi di sviluppo stabiliti per i paesi più poveri. Quindi la novità di un Piano Marshall per l’immigrazione non sarebbe tanto nel proporre un salto quantitativo negli aiuti ai paesi più poveri quanto nel legarlo ai suoi possibili effetti sui flussi migratori da quei paesi. Spesso, quando si parla di un Piano Marshall per l’immigrazione, si pensa ad un sostegno specialmente per i paesi africani, anche se l’immigrazione rilevante non proviene soltanto da quel continente. Ma, di nuovo, pensare ad un Piano Marshall per l’Africa non risulta di per sé una grande novità, anche se chi lo sta proponendo oggi sta pensando ai barconi dalla Libia o alle traversate nel Sahara. Ma il continente africano non è nuovo a massicci flussi di aiuto, specialmente di provenienza europea (tra gli altri “donatori” ci sono Stati Uniti, Giappone, Canada e, più di recente, la Cina). Gli aiuti europei verso l’Africa assunsero una ruolo significativo nelle convenzioni di Yaoundé e di Lomé a partire dal 1963 e si estesero fin oltre il secolo XX,[3] accompagnando inizialmente la decolonizzazione con ingenti risorse, ma i risultati non furono sempre soddisfacenti. Riusciranno questi nuovi interventi a superare le inefficienze dei passati programmi di aiuto verso l’Africa? Siamo sicuri che questo Piano Marshall per l’immigrazione non sia un modo per reagire a fenomeni di aid fatigue, o un modo per riproporre, sotto nuove vesti, vecchi schemi?
Cosa significa veramente proporre un Piano Marshall per l’immigrazione?
Non dimentichiamo che l’esperienza della cooperazione allo sviluppo finora ha trascurato i processi migratori nei paesi in cui interviene, considerandoli marginalmente. Spesso ci si è limitati a dare un contentino all’analisi dei flussi migratori con una nota a piè di pagina negli studi preliminari per paese. Quali speranze abbiamo che i paradigmi, le modalità ed i meccanismi della cooperazione internazionale saranno in grado di produrre effetti che incidano sui flussi migratori? C’è qualcuno, tra i proponenti del Piano Marshall per l’immigrazione, che ha speso un po’ di tempo per verificare se ed in che modo i programmi di cooperazione allo sviluppo sono collegati alla dinamica dell’emigrazione dai paesi riceventi aiuto? Altrimenti, c’è il rischio di trovarsi di fronte a qualche sopresa e a qualche delusione. C’è chi sostiene che un Piano Marshall per l’immigrazione non dovrebbe assomigliare ai tradizionali programmi di cooperazione (forse ha sentito dire che a volte non funzionano), e propone qualcosa di diverso, con risultati più rapidi: nuovi piani di investimento che generino immediatamente posti di lavoro. Ma sostenere che ciò non abbia nulla a che vedere con la cooperazione internazionale allo sviluppo significa non sapere di cosa si stia parlando.
Queste nuove azioni, che si parli di investimenti produttivi o infrastrutturali, di generazione di nuovi posti di lavoro o di creazione di nuove condizioni strutturali che incidano sull’emigrazione, richiedono sempre operazioni tipiche della cooperazione internazionale allo sviluppo. Richiedono infatti notevoli mezzi finanziari e risorse umane, adequata programmazione, analisi preliminari, studi di settore, soluzioni tecniche ed organizzative, lo sviluppo di capacità istituzionali, attività formative e addestramento professionale, migliori infrastrutture, maggiore accesso a servizi sociali essenziali, meccanismi di monitoraggio e di valutazione. È facile dire che per disincentivare l’emigrazione occorre superare gli ostacoli burocratici della cooperazione internazionale per produrre risultati più rapidi, ma la qualità dei risultati ottenuti dipende anche dall’aver compiuto queste attività con il dovuto rigore: lo sviluppo non è il risultato della bacchetta magica o della decisione miracolosa di qualche manager più sveglio che “mette su una fabbrichetta” in due giorni creando posti di lavoro dal nulla. Investimenti che producano risultati che incidano sulla propensione ad emigrare non si improvvisano, ma sono il risultato di un lavoro di concertazione e di dialogo, nonché di programmazione dello sviluppo. È questo ciò che fa la cooperazione allo sviluppo. Ma sono le tecniche di formulazione dei programmi d’aiuto attualmente in uso veramente in grado di garantire la “creazione di posti di lavoro” incidendo sulla propensione ad emigrare? L’effetto “job creation” non è nuovo nel vocabolario dell’aiuto, ma finora è stato trattato in modo probabilmente inadeguato per assicurarne le implicazioni desiderate sulla propensione ad emigrare. Inoltre, può la riduzione dei flussi migratori essere un nuovo obiettivo per la cooperazione allo sviluppo? È questo obiettivo compatibile con gli obiettivi tradizionali che mirano alla crescita del benessere nei paesi beneficiari, tenendo conto della complessità dei processi di sviluppo e delle dinamiche migratorie (sia interne che internazionali)? Chi propone un Piano Marshall per l’immigrazione è consapevole di tutto ciò? Ha fatto queste verifiche con le agenzie di cooperazione prima di proporre un nuovo Piano?
Alcune domande di fondo
Ma pur ammettendo che sia plausibile aggiungere ai programmi di aiuto un requisito quale la riduzione della propensione ad emigrare, ci dobbiamo porre altre domande prima di abbracciare con ottimismo la prospettiva di un Piano Marshall per l’immigrazione:
- Quali sono i tempi di gestazione dei nuovi investimenti per incidere significativamente sulla propensione ad emigrare? Quanto tempo sarà necessario affinché essi producano un incremento significativo della domanda di lavoro o incidano sulle cause strutturali delle spinte migratorie? Qualche anno? E quanti anni?
- Sono le persone potenzialmente interessate ai nuovi posti di lavoro le stesse che stanno dibattendo se emigrare o restare, oppure si tratta di gruppi sociali diversi? Che succede se i nuovi posti di lavoro sono creati in settori produttivi o in regioni geografiche diversi da quelli ove si concentrano i lavoratori che poi decidono di emigrare?
- Le cause di fondo che generano flussi migratori non sono attribuibili solo all’andamento del mercato del lavoro, per cui la creazione di nuovi posti di lavoro non è l’unica variabile rilevante per decidere di non abbandonare il proprio paese. Ci sono altri fattori non legati alla congiuntura economica che spingono ad emigrare:
- ragioni strutturali dello sviluppo (quali le distorzioni di una struttura dualistica dell’economia, trasformazioni di lungo periodo dell’economia, povertà dilagante),
- fattori legati a motivi di sicurezza nazionale o personale;
- fattori ambientali o climatici (cambiamenti climatici, siccità protratte, altre catastrofi naturali);
- situazione politica interna, conflitti locali, guerre civili, criminalità e violenza diffusa, modo in cui la giustizia è amministrata e grado in cui lo stato di diritto è garantito;
- tensioni tribali, oppressione etnica, contrasti religiosi o altre dinamiche politiche;
- dinamiche familiari.[4]
- Sarà il nuovo Piano Marshall per l’immigrazione in grado di incidere su tutti questi fattori per alterare le dinamiche migratorie? Quali garanzie abbiamo di poter raggiungere questi risultati in tempi ragionevolmente ridotti? E come misurare l’impatto di interventi su questi fattori in termini di emigrazione?
- Più semplicemente, saranno i programmi di sviluppo che comporrebbero questo nuovo Piano Marshall per l’immigrazione in grado di dare risposte adeguate alle ansie di chi sta per decidere di partire? Non c’è forse il rischio che, mentre cerchiamo di varare un massiccio piano di interventi per lo sviluppo, l’emigrazione continui a manifestarsi in modo tutto sommato inalterato, nonostante le dimensioni dei nuovi programmi di aiuto? E a quel punto, cosa andremo a raccontare al grande pubblico? Che ci siamo sbagliati? Ed in tal caso, quale alternativa ci resta? Bloccare gli immigranti alla frontiera?
 C’è poi un’altra questione tutt’altro che marginale. La cooperazione allo sviluppo, così come le politiche nazionali di sviluppo dei paesi che ne beneficiano, intendono in primo luogo promuovere crescita economica e progresso sociale. Nella misura in cui questi obiettivi fondamentali siano raggiunti, non è detto che il loro effetto netto sia una riduzione della propensione ad emigrare. Lo sviluppo non necessariamente riduce i flussi migratori, ma può addirittura aumentarli. Lo sviluppo spesso avviene attraverso ristrutturazioni economiche profonde e cambiamenti strutturali, che possono favorire, anziché ridurre, le spinte migratorie. Modificando, ad esempio, gli equilibri tra mondo rurale ed aree urbane, lo sviluppo può intensificare l’urbanizzazione e promuovere la crescita di nuovi settori produttivi, mentre altri settori vengono ridimensionati, così incentivando uno “spirito migratorio”. In fatti, questi cambiamenti possono favorire il rafforzamento del “desiderio di mobilità” di alcuni, incentivandoli a cercare nuove opportunità lavorative, o costringendoli verso altri settori produttivi, spingendoli in tal modo a cercare altre mete geografiche (interne o all’estero). Queste questioni sono centrali. Purtroppo non possiamo contare su esperienze pilota lanciate in passato per avere qualche lume in materia. Navighiamo un po’ nel buio quando proponiamo disincentivi all’emigrazione nei paesi d’origine. Ne siamo consapevoli quando sosteniamo un Piano Marshall per l’immigrazione?
C’è poi un’altra questione tutt’altro che marginale. La cooperazione allo sviluppo, così come le politiche nazionali di sviluppo dei paesi che ne beneficiano, intendono in primo luogo promuovere crescita economica e progresso sociale. Nella misura in cui questi obiettivi fondamentali siano raggiunti, non è detto che il loro effetto netto sia una riduzione della propensione ad emigrare. Lo sviluppo non necessariamente riduce i flussi migratori, ma può addirittura aumentarli. Lo sviluppo spesso avviene attraverso ristrutturazioni economiche profonde e cambiamenti strutturali, che possono favorire, anziché ridurre, le spinte migratorie. Modificando, ad esempio, gli equilibri tra mondo rurale ed aree urbane, lo sviluppo può intensificare l’urbanizzazione e promuovere la crescita di nuovi settori produttivi, mentre altri settori vengono ridimensionati, così incentivando uno “spirito migratorio”. In fatti, questi cambiamenti possono favorire il rafforzamento del “desiderio di mobilità” di alcuni, incentivandoli a cercare nuove opportunità lavorative, o costringendoli verso altri settori produttivi, spingendoli in tal modo a cercare altre mete geografiche (interne o all’estero). Queste questioni sono centrali. Purtroppo non possiamo contare su esperienze pilota lanciate in passato per avere qualche lume in materia. Navighiamo un po’ nel buio quando proponiamo disincentivi all’emigrazione nei paesi d’origine. Ne siamo consapevoli quando sosteniamo un Piano Marshall per l’immigrazione?
Chi si è occupato di cooperazione allo sviluppo sa che gli aiuti non producono risultati tangibili rapidamente, ma richiedono una presenza prolungata e persistente, una grande varietà di sforzi, larga partecipazione degli stakeholders, concomitanze di tanti fattori, rimozione di tanti ostacoli culturali e sociali, innovazioni istituzionali, sviluppo infrastrutturale, e accesso a servizi sociali. Il che ha lunghi tempi di maturazione, con orizzonti temporali spesso incompatibili con quelli troppo brevi imposti dalla finanza pubblica dell’aiuto. Né basta una pioggia di interventi a lunga durata per garantire buoni risultati. Lo sviluppo non è facile da raggiungere e non si improvvisa. Lo sviluppo è lento e complesso, e spesso contraddittorio: mentre riduce l’interesse ad emigrare di alcuni individui, può generare spinte migratorie in altri. Decidere a Bruxelles, a Roma o a Berlino di stanziare milioni di euro per lanciare programmi di aiuto non è poi tanto difficile. Produrre risultati nei paesi destinatari dell’aiuto con quegli stessi programmi e incidere sulle dinamiche migratorie, è tutto un altro discorso.
Infine, se l’aiuto allo sviluppo è utilizzato non per produrre un impatto diretto sull’emigrazione, modificando la dinamica sociale ed economica del paese ricevente, ma solo come merce di scambio per ricevere la collaborazione delle autorità nel contenimento dell’emigrazione con misure repressive, non credo che si possa più parlare di un Piano Marshall per l’immigrazione. Si tratta piuttosto di un espediente per avviare a distanza misure di contenimento dei flussi migratori, spesso repressive, da realizzare nei paesi d’origine degli emigranti o in paesi “terzi” ove gli emigranti sono in transito. La collaborazione richiesta può consistere nel sostenere misure di polizia più intense contro i “trafficanti” di migranti, maggiori controlli di frontiera, introduzione di modalità che limitino o rendano più difficile la concessione di passaporti d’espatrio, o elargizione di incentivi a non emigrare (offerte di lavoro, incentivi monetari, offerte di riqualifazione educativa o lavorativa, ecc.). Come puro mezzo di scambio, queste operazioni hanno scarsa possibilità di essere accettate nei paesi di origine, anche perché il diritto ad emigrare è ormai quasi universalmente riconosciuto, e non vedo come un governo sia facilmente disposto ad interferire sulle intenzioni di un suo cittadino a lasciare il proprio paese con metodi repressivi, se non compremettendo il rapporto fiduciario (se esiste, in un paese fragile) tra stato e cittadino. Né l’elargizione di eventuali incentivi a non emigrare è una misura che possa essere improvvisata per essere efficace e duratura. Pertanto, ci sarà ben poco interesse da parte delle autorità dei paesi di origine a intraprendere rapporti di collaborazione con il paese donante utilizzando gli aiuti come puro mezzo di scambio per contenere l’emigrazione. Quelle autorità potrebbero ancora essere interessate a ricevere gli aiuti, ma non a condizionarli alla riduzione drastica dell’emigrazione con misure di contenimento. Il do ut des potrebbe non funzionare. Nel caso di paesi “terzi”, ove forse questo scambio potrebbe aver maggior senso, l’utilizzazione della cooperazione allo sviluppo come “merce di scambio” per ottenere la collaborazione delle autorità per accelerare operazioni di repressione dei traffici di migranti clandestini in transito si presta, però, a molte ambiguità, anche se può essere sostenuta da accordi bilaterali. Mi chiedo infatti per quale motivo si debba ricorrere all’uso della cooperazione allo sviluppo come merce di scambio, invece di utilizzare altri metodi: per esempio un contributo finanziario (come è stato fatto con la Turchia), o un accordo per sviluppare scambi commerciali, o la realizzazione di qualche progetto specifico di investimenti. Scomodare la cooperazione allo sviluppo per queste forme di baratto ne declassa la natura, e si presta a molte controversie per il fatto di utilizzare gli aiuti per scopi diversi dai loro obiettivi fondamentali. In ogni caso, non sembra che le autorità dei paesi “terzi” abbiano mostrato finora particolare interesse a questo tipo di “scambio”.
I problemi di efficacia e di impatto dell’aiuto e un Piano Marshall per l’immigrazione
Se fossimo onesti, dovremmo riconoscere che un Piano Marshall non è la soluzione magica ai problemi dell’immigrazione, né quella più facile, anche se i programmi di cooperazione potenzialmente potrebbero migliorare le condizioni di vita nei paesi che la ricevono. Questi miglioramenti potrebbero forse (ma non necessariamente) contribuire ad una qualche riduzione della pressione migratoria. L’adozione di un Piano Marshall per l’immigrazione potrebbe anche  essere l’occasione per raffinare le modalità dei programmi di aiuto per renderli più “efficaci” e “rilevanti”, e così facendo attenuare i fattori strutturali che spingono ad emigrare. Pertanto vale la pena incoraggiare o non ostacolare le proposte per un simile Piano Marshall. Però, dobbiamo essere allo stesso tempo consapevoli che tali programmi potrebbero produrre effetti nulli o negativi sui processi migratori. Chi propone la soluzione magica del Piano Marshall per l’immigrazione spesso ignora che per decenni c’è stata una polemica accanita[5] tra chi chiedeva un aumento sostanziale degli aiuti allo sviluppo e chi lo criticava perché non era la quantità ma la qualità della performance dell’aiuto che contava, o chi addirittura sosteneva una critica radicale all’aiuto allo sviluppo, che produrrebbe solamente sprechi, corruzione e distorzioni. Questo vale per l’aiuto allo sviluppo in generale, e ancor più per quello volto a scoraggiare la propensione ad emigrare, che complica ulteriormente il quadro del foreign aid. Non entriamo qui nel merito del dibattito sull’efficacia dell’aiuto. Tuttavia, possiamo facilmente ammettere, in ogni caso, che disporre di un incremento di mezzi finanziari per l’aiuto non garantisce in alcun modo il raggiungimento dei suoi obiettivi, se non siamo in grado di assicurare, allo stesso tempo, una più elevata qualità dei suoi programmi. La necessità di aumentare l’efficacia della cooperazione internazionale allo sviluppo ed il suo impatto economico e sociale è ormai riconosciuta a livello universale, ma è una lotta immane, che deve superare ostacoli di ogni natura, e richiede sforzi persistenti, determinatezza, e nuovi approcci. Tali problemi saranno ancora più seri se i programmi di aiuto saranno orientati a produrre effetti sulla variabile “emigrazione”.
essere l’occasione per raffinare le modalità dei programmi di aiuto per renderli più “efficaci” e “rilevanti”, e così facendo attenuare i fattori strutturali che spingono ad emigrare. Pertanto vale la pena incoraggiare o non ostacolare le proposte per un simile Piano Marshall. Però, dobbiamo essere allo stesso tempo consapevoli che tali programmi potrebbero produrre effetti nulli o negativi sui processi migratori. Chi propone la soluzione magica del Piano Marshall per l’immigrazione spesso ignora che per decenni c’è stata una polemica accanita[5] tra chi chiedeva un aumento sostanziale degli aiuti allo sviluppo e chi lo criticava perché non era la quantità ma la qualità della performance dell’aiuto che contava, o chi addirittura sosteneva una critica radicale all’aiuto allo sviluppo, che produrrebbe solamente sprechi, corruzione e distorzioni. Questo vale per l’aiuto allo sviluppo in generale, e ancor più per quello volto a scoraggiare la propensione ad emigrare, che complica ulteriormente il quadro del foreign aid. Non entriamo qui nel merito del dibattito sull’efficacia dell’aiuto. Tuttavia, possiamo facilmente ammettere, in ogni caso, che disporre di un incremento di mezzi finanziari per l’aiuto non garantisce in alcun modo il raggiungimento dei suoi obiettivi, se non siamo in grado di assicurare, allo stesso tempo, una più elevata qualità dei suoi programmi. La necessità di aumentare l’efficacia della cooperazione internazionale allo sviluppo ed il suo impatto economico e sociale è ormai riconosciuta a livello universale, ma è una lotta immane, che deve superare ostacoli di ogni natura, e richiede sforzi persistenti, determinatezza, e nuovi approcci. Tali problemi saranno ancora più seri se i programmi di aiuto saranno orientati a produrre effetti sulla variabile “emigrazione”.
Una parola di realismo ci suggerisce dunque che non dovremmo mettere tutte le nostre speranze nell’effetto “diretto” di questi programmi d’aiuto per incidere sulla dinamica migratoria. Coloro che vantano i pregi di questi programmi dovrebbero guardarsi dal fare discorsi puramente retorici, millantando un credito basato su risultati difficilmente dimostrabili, non disponendo ancora di sufficienti dati concreti che evidenzino la capacità dell’aiuto allo sviluppo di incidere sull’emigrazione. Se non altro, dovremmo per lo meno ammettere che i tempi di realizzazione di risultati tangibili sull’emigrazione sono probabilmente troppo lunghi per sperare di raggiungerli in tempi ragionevoli. Inoltre, potremmo scoprire (dopo aver speso ingenti risorse finanziarie) che gli effetti sull’emigrazione siano tutto sommato molto modesti, o addirittura irrilevanti o, peggio ancora, addirittua contraddittori. Inoltre, un impegno massiccio per utilizzare la cooperazione internazionale allo sviluppo per alleviare la pressione migratoria non potrà avere alcun effetto significativo se non si associerà a riforme sistematiche volte ad aumentarne l’efficacia e l’impatto. Sono consapevoli di tutto ciò i sostenitori di un Piano Marshall per l’immigrazione? O si limitano a fare dichiarazioni generiche sugli intenti di un simile Piano? Sono gli stessi governi impegnati a migliorare la qualità dell’ aiuto?[6]
Posso perciò concludere che l’idea di un Piano Marshall per l’immigrazione non sembra essere sostanzialmente in grado di produrre facilmente risultati soddisfacenti in termini di riduzione dei flussi migratori. Nella migliore delle ipotesi, il risultato, anche se positivo, sarà con ogni probabilità insufficiente a modificare la dinamica migratoria. Inoltre, conoscendo i tempi con cui i meccanismi di cooperazione internazionale allo sviluppo operano, c’è da aspettarsi risultati molto tardivi rispetto all’impellenza delle necessità. Pertanto, non credo sia prudente formulare una strategia per l’immigrazione puntando soltanto sui benefici di un tale Piano Marshall, anche se non escludo che possa essere utile vararlo per i suoi meriti intrinseci. In ogni caso, il suo apporto sarà soltanto un complemento ad altre iniziative, siano esse orientate al diretto contenimento dei flussi migratori o volte a persegure una migliore accoglienza e integrazione degli immigranti. Farò un’analisi di queste altre iniziative nelle sezioni successive di questo saggio. Nel frattempo mi limito a sottolineare che sperare di ridurre i flussi migratori (per ora l’unico criterio di successo che ho qui richamato, e vedremo che non è l’unico) con massicci programmi di sviluppo nel paesi d’origine degli immigrati può produrre risultati fortemente deludenti.
______________________________________________________________________
[1] Su La Repubblica del novembre del 2017 sono apparsi un paio di articoli che menzionavano esplicitamente l’idea di lanciare un ‘Piano Marshall’ per l’immigrazione.
[2] Vedi ad esempio, Jeffrey D. Sachs (2005), The End of Poverty – Economic Possibilities for Our Time, Penguins Books, New York/London.
[3] Nel 2000, la cooperazione europea delle convenzioni di Yaouné e di Lomé è stata proseguita con l’accordo di Cotonou, che ha tuttavia registrato una riduzione dell’entusiasmo iniziale delle prime convenzioni. Le aspettative di grandi risultati associate alle prime convenzioni si sono gradualmente affievolite.
[4] La rete di legami familiari tra chi è in procinto di emigrare e chi è già emigrato da lunga data o in data più recente, da un lato, e il proprio nucleo familiare d’origine, dall’altro, è essenziale per capire la dinamica delle emigrazioni.
[5] Basta ricordare tra i tanti i due ottimi volumi pubblicati rispettivamente nel 1987 e nel 2007 da Roger C. Riddell, il primo Foreign Aid Reconsidered, ed il secondo col titolo Does Foreign Aid Really Work?, che sintetizzano l’evoluzione della cooperazione internazionale allo sviluppo ed il dibatto sulla sua efficacia.
[6] Ricordiamo che l’Italia è attualmente uno degli ultimi donatori in termini di percentuale del PIL. C’è stato nel nostro paese uno sforzo sistematico per riformare il nostro aiuto e migliorarne l’efficacia? Sappiamo che in questi ultimi anni, con i problemi finanziari del fisco italiano, l’attenzione si è concentrata su tagli decisivi all’aiuto pubblico, anche se la cooperazione italiana può vantare qualche buon risultato aneddottico.
