La società competitiva al bivio tra concorrenza e solidarietà
VINCA IL MIGLIORE ! MA PERCHE' ?
di Paolo Basurto
 Alternativa al conflitto
Alternativa al conflitto
C’è una storiella che, per quanto non molto originale, è sempre buona per introdurre l’argomento della solidarietà. E' quella dei due asinelli che rischiano di morir di fame perché il padrone li ha legati l'uno all'altro ma la corda è insufficiente per raggiungere contemporaneamente ciascuno la propria mangiatoia. Ma c'è una soluzione: collaborare fidandosi reciprocamente: mangeranno assieme prima ad una mangiatoia poi all'altra.Forse la storiella è un tantino elementare, però mi pare che introduca bene il tema.
L’alternativa al conflitto, alla legge del più forte, è la cooperazione. In realtà non si sa mai chi sia veramente il più forte e quali saranno le conseguenze di un conflitto. La storiella dice anche che per trovare una via d’uscita solidale che convenga a tutti, bisogna pure che qualcuno faccia il primo passo e si fidi dell’altro. Questo significa, ovviamente prendere un rischio. Ma correre questo rischio può valere la pena quando l'alternativa può significare perdere tutto tutti. Normalmente chi decide che vale la pena, non è necessariamente il più buono o il più generoso ma il più intelligente. Quello che meglio sa valutare dov’è la convenienza vera.
Sul piano sociale, il ragionamento è lo stesso. Quando gli operai erano costretti a scioperare duro per tentare di ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro, se non perdevano addirittura il posto perdevano spesso il salario unica fonte di sostegno delle loro famiglie. Allora, attraverso le prime organizzazioni sindacali, crearono dei fondi alimentati da una piccola tassa che ciascun lavoratore, in sciopero o no, pagava. Questi fondi servivano a sostenere le famiglie dei lavoratori quando erano costretti allo sciopero. Oggi questi fondi esistono per legge nei paesi socialmente avanzati. Si chiamano “assicurazioni sociali”. Le cosiddette ‘mutue’ sono nate sugli stessi principi di solidarietà e mutuo appoggio. Un gruppo di persone, sufficientemente numeroso, paga una tassa e crea un fondo per aiutare quelli che si ammalano e non avrebbero mai avuto i soldi per sostenere le spese delle cure. Chi non si ammala aiuta chi si ammala. Nell’ipotesi che un domani (fatti i dovuti scongiuri) se si ammala lui, chi sta bene lo aiuti a sua volta. Si dirà che non sono poche le prove che questi sistemi si siano spesso allontanati dal loro spirito originario e siano divenuti business corrotto e corrompente. E’ vero. Ma questo è un altro discorso e fa parte del contesto nel quale queste esperienze si sono costruite. Un contesto certo non di solidarietà ma di conflitto sociale. Gli operai che si aiutavano tra loro non riuscivano a vedere che la lotta di classe che cercavano allo stesso tempo di attuare, era contraddittoria allo spirito di solidarietà generale. Se l’intera comunità non si basa sulla solidarietà, ma si basa sul conflitto, è difficile che le esperienze più ristrette di solidarietà, in quelle stesse comunità, siano immuni dal contagio dello spirito dominante, sia esso capitalista o socialista.
 L'ambiguità dell'aiuto umanitario
L'ambiguità dell'aiuto umanitario
A questo punto è opportuna una piccola diversione. Spesso il concetto di solidarietà si confonde con quello di aiuto umanitario; di assistenza benefica e volontaria. Per es. si parla molto di ‘solidarietà con il Terzo Mondo’; ‘solidarietà con i più poveri’; ‘solidarietà con gli emarginati e gli oppressi’; ecc.. Nel linguaggio comune, questa terminologia suona come un invito ad aiutare tutte le persone che il destino ha fatto sì che appartenessero a quelle sfortunate categorie, e che senza il nostro buon cuore sarebbero destinate a soffrire sempre di più. Insomma è una questione di misterioso destino, che rende tutta questa gente sfortunata. Ma noi siamo buoni e li aiutiamo. Naturalmente non siamo tenuti a farlo. Ma volontariamente e gratuitamente (o quasi…) lo facciamo lo stesso. Anche quelli, ormai numerosi, che dicono che questo amaro destino è in realtà la tragica conseguenza di politiche e di interessi particolari, che trovano profondamente coinvolti i nostri stessi Paesi, le nostre classi politiche e imprenditoriali, poi, alla fin fine, prendono le distanze sia dalle colpe che dalle conseguenze e si auto-dichiarano missionari, volontari della solidarietà. Insomma gli unici buoni della storia, perché fanno tutto per un altruistico ideale senza che nessuno li abbia mai obbligati.
Ma la solidarietà non si basa su questo falso concetto di gratuità che non ha cambiato e non cambierà mai il mondo. Si basa invece sulla convenienza generale e comune che in una collettività, non ci siano poveri, emarginati od oppressi. La collettività che riconosce questa solidarietà una convenienza di tutti, riconosce a tutti il diritto a non essere povero, emarginato, oppresso. Il concetto di benessere sociale (oggi tutti lo chiamano welfare) si basa su questa visione. Gran parte delle tasse che paghiamo dovrebbero servire proprio a questo, a salvare i diritti minimi fondamentali, che tutti hanno, di poter vivere una vita, se non felice, sicuramente dignitosa. A questo punto aiutare i poveri non è più un gesto gratuito di buona volontà, ma un preciso dovere che si trasforma in un obbligo politico. Ecco perché chi davvero vuole aiutare poveri, emarginati ecc. non può che farlo facendo politica. Una politica che orienti la società a regolarsi sulla solidarietà piuttosto che sulla competitività. Questa visione non si poggia su dogmi di bontà e altruismo, su ideali romantici di riscatto e amore per i derelitti, ma su una molto più pacata convinzione che il principio della solidarietà permette alla collettività di vivere molto meglio, cioè più felice. Che è lo scopo che tutti inseguiamo. Insomma non si tratta di un’ideologia, di una religione, di un’ideale appassionato. Si tratta di una proposta pratica e razionale, certamente non immune da rischi nella sua effettiva applicazione.
 La dimensione trascendente
La dimensione trascendente
Riprendiamo il filo principale del discorso e domandiamoci perché la solidarietà si fa strada con tanta difficoltà da sembrare oggi più un’utopia che una cammino effettivamente percorribile. Anticipo subito la risposta e poi cercherò di spiegare.
In una comunità basata sulla solidarietà c’è assoluto bisogno di una dimensione trascendente. Cioè, che trascenda, superi, vada al di là dei limiti dell’individuo. Per es. in una famiglia la dimensione trascendente è costituita dai figli. L’appartenenza familiare, il cosiddetto vincolo di sangue, che lega non solo i genitori ai figli ma tutti i membri della famiglia, è un altro modo per esprimere questa dimensione. Questa dimensione è un valore istintivo che permette al singolo individuo di andare al di là dei confini dei propri interessi immediati, della propria vita fisica individuale, e trovare soddisfazione anche in un sacrificio doloroso, se si è convinti che questo sacrificio serva ai membri della famiglia. I genitori sono pronti a morire per i propri figli e non si aspettano minimamente che ci debba essere reciprocità. Ma si aspettano sì che i propri figli, una volta genitori, siano pronti anch’essi a morire per i loro figli. E così via. Esiste una dimensione così fatta in una collettività grande; in una società di milioni di persone ?
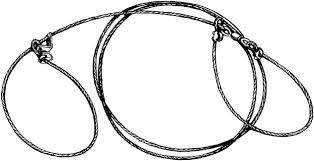 Trappole comunitarie
Trappole comunitarie
Qui comincia la parte più difficile del discorso. Se in mancanza di questa dimensione non c’è verso di costruire una comunità veramente solidale, e la solidarietà non potrà che rimanere un’esperienza limitata ad interessi di categoria o di settore (e perciò continuamente esposta a deterioramento per manipolazione, corruzione o tradimento della fiducia che è alla base del sistema), è vero anche che è proprio la ricerca di questa dimensione che può portare alla scoperta di un nuovo modo di interpretare la finalità e la natura di una società. Siamo abituati a pensare che l’appartenenza a una comunità sia un dato di fatto. Uno nasce in un certo posto, e questo è sufficiente perché si senta obbligato ad essere di quel posto. Ad appartenere a quella famiglia, a quell’etnia, a quella tribù, popolo, patria, nazione, o come quella comunità la si voglia chiamare. Invece l’appartenenza funziona solo se è la conseguenza di un’adesione libera; di un riconoscimento che quella comunità è tua e ti sta bene e sei pronto a sentire i suoi problemi come tuoi. Questo dovrebbe valere per tutto. Anche per la famiglia, che i Papi si scaldano tanto a chiamare ‘la comunità naturale per eccellenza’. La famiglia, spesso e volentieri si dimostra essere piuttosto che una comunità libera basata sul piacere di stare assieme, un vincolo, una catena, una struttura fortemente gerarchica basata sul dominio del padre-padrone. E il famoso vincolo di sangue, più di una volta, lo abbiamo visto trasformarsi in omertà e complicità, invece che in patto di solidarietà e cioè di fiducia reciprocamente vantaggiosa e sempre libera. Senza questo elemento di adesione libera, la dimensione trascendente non potrà nascere istintivamente e tutto potrà trasformarsi in un pericoloso intreccio di sensi di colpa e di affetto frustrato e persino di odio. Insomma, non è raro il caso di un genitore che rifiuta il proprio figlio (altro che essere disposto anche a morire per lui…); di un figlio talmente oppresso dalla gelosia al punto da odiare il proprio fratello, ecc.. Quindi anche per la famiglia è valido il principio che non c’è appartenenza se non c’è adesione libera.
Per la società è forse ancora più chiaro. Se l’appartenenza ad una società significa un mero fatto burocratico ed anagrafico, in conseguenza del quale non solo ti si chiede di pagare le tasse ma anche di arruolarti nell’esercito ed essere pronto a morire per la cosiddetta ‘Patria’, ebbene solo un apparato oppressivo e repressivo potrà ottenere che queste richieste vengano soddisfatte. E comunque i disertori saranno sempre più numerosi.
Tutto questo per dire che non si può avere una comunità solidale senza una dimensione capace di trascendere, di andare al di là dell’individuo. E che non si può riconoscere questa dimensione trascendente senza che l’appartenenza a quella comunità sia un’adesione libera non condizionata da nessun tipo di ricatti (giuridici, affettivi, spirituali).
 Equità e meritocrazia
Equità e meritocrazia
Vengo adesso ad un altro elemento assai caratterizzante di una comunità solidale: l’equità.
Usualmente si parla di uguaglianza piuttosto che di equità. L’uguaglianza ha rappresentato un grande progresso storico, grazie alla rivoluzione francese e, prima ancora, all’indipendenza nordamericana. Gli uomini sono tutti uguali e hanno tutti gli stessi diritti. Dunque, niente più caste e privilegi. Certo, rispetto al medioevo è stato un gran risultato affermare questo concetto. Ma il fatto è che gli uomini non sono per niente tutti uguali. Non sono capaci delle stesse prestazioni; non hanno gli stessi desideri e le stesse esigenze.
In una società come quelle più avanzate, basate sul capitalismo e quindi sulla competitività sfrenata, si parla costantemente di meritocrazia. Il migliore (cioè il più bravo, il più intelligente, il più ricco, il più forte, quello che mena di più o che spaventa, terrorizza di più); il migliore insomma merita di più. Ha più diritti. Ha vinto. E’ il più forte. Altro che uguaglianza. C’è chi reagisce a questo stato di cose dicendo che l’uguaglianza deve essere almeno nel livello di partenza. Tutti partono dagli stessi blocchi, poi chi arriva primo quello sì, è il migliore.
Ma le trappole del concetto di uguaglianza sono ancora più sottili. Per sintetizzare: c’è una torta e dieci bambini. Per non dispiacere nessuno, tutti avranno parti uguali. E chi non ha fame mangerà la sua parte lo stesso. Chi ha fame il doppio, pazienza… Uguale, è un concetto astratto ed esprime una totale identità. Se la giornata lavorativa è di otto ore, tutti devono lavorare in modo uguale; il piccolo mingherlino che dopo sei ore non si regge in piedi, e il fortaccione che può tranquillamente fare anche altre tre ore di straordinario.
L’equità, invece, vuole che diritti e doveri siano rapportati alle capacità di ciascuno e, per rifarci all’esempio lavorativo, a parità di salario, il mingherlino potrà lavorare meno del fortaccione. Se si spartisce un’eredità, per fare un altro esempio, non si farà come con la torta, tutto in parti uguali. Ma chi ha più bisogno avrà di più. In una società solidale l’equità sostituisce l’uguaglianza (e di conseguenza anche la meritocrazia).
Ma non ci sarà il rischio che il mingherlino ci giobbi e in fondo faccia fessi tutti quanti passandosi per mingherlino quando non lo è ?? Certo che c’è il rischio. L’ho detto sin dall’inizio. La solidarietà è rischiosa. Ma bisogna pure dire che il rischio non sarà mai così dannoso quanto la certezza che abbiamo oggi che una società come la nostra, basata sull’egoismo del più forte, ci conduca alla generale catastrofe. Inoltre si devono aggiungere alcune considerazioni. Il rischio in una comunità solidale è soprattutto nel tradimento della fiducia. Ora, la solidarietà non significa stupidità. Si possono instaurare dei controlli che diminuiscano il rischio, ma soprattutto si può produrre una cultura della solidarietà e della fiducia che aiuti il ragionamento della convenienza e che aiuti a rendere tutti più consapevoli dell’utilità della solidarietà. Più la solidarietà diventerà una pratica generalizzata più il rischio delle trasgressioni si ridurrà.
Naturalmente tutto questo è stato un riflettere per grandi linee. Molte cose andrebbero approfondite: il concetto di comunità e quello di benessere; la difesa dalle aggressioni e dai raggiri; il tipo di dialogo e di compromesso necessario per stabilire un patto di solidarietà e tante cose ancora. Andrebbe inoltre conosciuto meglio il fatto, ormai ben risaputo da biologi e etnologi, che nella lotta per la sopravvivenza delle specie, non vince il più forte come spesso si pensa, ma chi meglio si organizza in un sistema di cooperazione e mutuo appoggio. A cominciare dalle cellule.{jcomments on}
