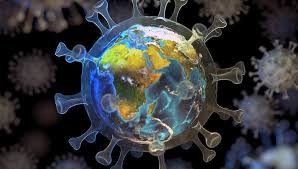|
|
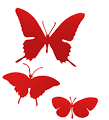 Capitolo 4. Un treno per Innsbruck
Capitolo 4. Un treno per Innsbruck
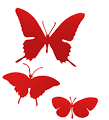 Capitolo 5. La tovaglia ricamata coi pappagalli
Capitolo 5. La tovaglia ricamata coi pappagalli
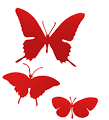 Capitolo 7. Angelo azzurro
Capitolo 7. Angelo azzurro
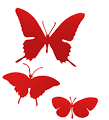 Capitolo 9. Casa, dolce casa
Capitolo 9. Casa, dolce casa
Sí, é ora. Lo sguardo intenso di Amadeus mi sta inchiodando alla parete come una schiava egizia. Amadeus, regalo degli dei per me, in questo turbolento ‘68.
Il suo sorriso, i suoi grandi occhi espressivi, i suoi capelli semilunghi e mossi come quelli di Beethoven, m’invadono di nuovo. Navigo nel mare dolceamaro della nostalgia di lui, con una lacerante coscienza di quanto ho perduto.
Ha quindici o venti anni meno di me, e la stessa curiositá verso la vita, quando compare a casa mia in una di quelle riunioni che organizzo tra studenti per scambiare dati e conoscenze. Lui vuole praticare con me l’italiano perché d’estate dovrá andare a Roma a fare teatro di strada con degli amici, mentre io posso approfondire con lui certi aspetti delle teorie sociali del ventesimo secolo, in cui è molto preparato. A volte ci immergiamo in interminabili discussioni politiche, sulle necessarie riforme del sistema capitalista, sulle necessarie riforme del sistema socialista, per un uso ottimale del plusvalore..., mentre il suo sguardo si sofferma sulla curva del mio collo, e su quella dei seni che si affacciano sul mio golfino viola (il riscaldamento non é troppo alto?), navigando con la mente sul plusvalore della mia pelle morbida.
Io mi sciolgo nel suo sguardo, percorrendo mentalmente le sue labbra e scendendo scendendo sulla sua pelle liscia e calda, finché, é vero, il capitale dovrebbe servire a..., ci isoliamo in una campana di silenzio, i suoi occhi persi nei miei, in un mondo senza denaro né sfruttamento. È un amore ancora virtuosamente virtuale.
Intanto, nell’universitá circolano come panini copie del famoso “libretto rosso” di Mao, la guida ideologica dei giovani cinesi lanciati nella (disastrosa, come si seppe poi) campagna di rinnovamento del loro immenso paese, con nomi fantasiosi come la Campagna dei Cento Fiori, che copre abusi e orrori ancora sconosciuti. Io lo trovo semplicemente indigesto. A me e Amadeus affascina il fatto che in Cina “i medici dai piedi scalzi” siano disponibili a percorrere lande sperdute, per curare umili contadini, ma quelle grandi cerimonie con migliaia di persone ridotte a formichine cariche di gigantesche bandiere rosse, illuminate dal pensiero- guida del Leader Massimo… MAMMA MIA, è davvero qualcosa a cui aspiriamo? Devo dire che qualsiasi cerimonia con grandi bandiere e una massa in adorazione di un Grande Capo, a me e a questi giovani tedeschi nati dalle rovine del nazi-fascismo, ci fa venire letteralmente la pelle d’oca.
Non avrei mai immaginato che mi sarebbe toccato conoscere dal vivo questi ruvidi ragazzi andini, seguaci fuori porta di Mao. Tocco con mano la mia impotenza di fronte a chi cancella sfumature e individualità costruite nel complesso cammino che ha percorso durante secoli l’Occidente, per superare una visione unilaterale del mondo, che vuole giudicare invece di capire…Un processo che in Europa ha visto spaventosi passi indietro e ha lasciato al suo passaggio milioni di morti…E continua ancora senza fine, avanzando verso la conquista del privilegio del dubbio, il “cogito ergo sum”, “penso quindi esisto”, essenza della persona umana. Perché è piú facile dividere il mondo in due: seguaci e nemici, bene e male, kametza e tekametza.
Impotenza. Sudore.
No. Non mi convince quest’adorazione del leader massimo, chiunque sia- riconosce Amadeus- Mi attrae molto di piú la rivoluzione pacifica di Gandhi, che ha liberato l’India senza colpo ferire, ma per strada gridano piú forte quelli che vogliono uno scontro duro con lo stato borghese. In una maniera o nell’altra, la costante è la parola “rivoluzione”. Quelli che stanno sopra devono andare sotto, e viceversa. Il dritto, il rovescio: dalla politica alle relazioni umane.
Ed io, mi decido o no ad applicare i sottili suggerimenti del dottor Weber? Anche Amadeus mi spinge a scendere dalle nubi. “Dai Marianna!” mi dice con la respirazione accelerata, mentre le mie orecchie si infiammano...Sí sí, domani, te lo prometto Amadeus...
-Ma é OGGI domani... anzi, domani era ieri! -mi risponde la sua impazienza. Ma no ma no ma ni... Accidenti, quanto mi costa darmi una mossa! Il fatto é che Markus é tornato ieri sera in piena notte, zitto zitto, a soffocarmi di baci. Forse per chiudermi la bocca. E io non ho saputo respingerlo. Intanto i baci di Amadeus si fanno sempre piú lunghi e sempre piú dolci, sulla mia porta... scivolando poco a poco verso un finale previstissimo.
E invece no! Mi arriva una comunicazione a sorpresa, che interrompe l’inevitabile sequenza, e dá una svolta alla storia. Leggo e rileggo il messaggio con gioia, poi ripongo la mia collana di perle nell’astuccio e preparo in fretta una grossa valigia. Non sia mai che cambino idea! No, meglio una valigia media e un borsone, per i viaggi interni. Fará caldo? Fará freddo? Ci sará, lá, lo sciampo per capelli secchi? Le calze di nylon, forse lá non servono…
-Tesoro- mi dice Markus salutandomi con un lungo bacio - anche se te ne vai al Polo nord, io saró sempre qui, per te.- Sempre cosí romantico, il mio principe di Turingia and Saxonia.
Bene, per un po’ ti lascio alle cure del Comitato Dame della tua agenda, penso, camicie a righe incluse.
- Sentiró la tua mancanza, -mi sussurra invece con uno sguardo triste Amadeus- e ti penseró ogni minuto di ogni giorno, finché non sarai di nuovo qui.
“Parole, parole…”mi dico. Parto per sei mesi. E alla fine, fate un po’ quel che vi pare, miei cari Markus e Amadeus (in ordine d’entrata) coi vostri milioni di spermatozoi che la natura vi regala ogni giorno. Il problema è vostro. Io, Marianna Dori in Weiser, stavolta ho qualcosa di meglio a cui pensare.
Per un po’ di tempo posso distanziarmi dal mio ombelico, e andare a conoscere qualcosa di ció che vibra nel mondo, fuori dalle strade ordinate della Germania, dove i negozi si sono di nuovo riempiti di wurstel e pane di cereali.
Salgo emozionata sulla scaletta di un Boeing Lufthansa, per attraversare per la prima volta l’enorme pozza d’acqua che chiamano Oceano Atlantico, e sbarcare all’altro capo del mondo con una valigia piena di libri, e uno sciampo per capelli secchi.
La Facoltá di Antropologia dell’Universitá di Berlino mi ha concesso una borsa di studio di sei mesi per fare una ricerca educativa in Perú. Proprio in Perú, lá in fondo ai nostri due mondi conosciuti: il confortevole Primo mondo, dove ci troviamo, e il severo Secondo, dall’altra parte del Muro. Raggiungeró il cosiddetto Terzo Mondo, lá sotto l’equatore, col suo carico di ingiustizia e povertá, con gli occhi spalancati, per captare tutto il suo splendore.
12. Verso il Tahuantinsuyo
Sono tremendamente sconcertata. Mi sembra di essere atterrata su un altro pianeta, quando scendo all’aeroporto Jorge Chavez di Lima nel 1971. L’antica capitale del vicereame del Perú possiede in quel momento un aeroporto diviso in due parti: quella internazionale, con code di gente ordinata da cordoni rossi, e quella nazionale, dove arrivare al banco del check in é un’impresa anche di carattere fisico. “Lo vedrá coi suoi occhi, Marianna”, mi spiega un funzionario dell’ambasciata tedesca con cui converso in aereo. Perché anche se una massa di gente ha prenotato o pagato il biglietto verso una determinata destinazione (ecco qua il biglietto per Juliaca, volo PB432, vede signore?), puó succedere che nel volo i posti reali risultino quasi la metá, o forse i due terzi di quelli assegnati, secondo misteriose contingenze. Allora, riesce a raggiungere l’aereo chi si mette a testa bassa a sgomitare in mezzo alla gente, buttando giú qualche rivale come un birillo, saltando sacchi di patate, casse di latte Gloria e fagotti di yuta cuciti con l’ago a mo´ di chiusura, con tanto di indirizzo scritto a mano sulla tela. Insomma, un circo. E puó anche succedere, che una volta che i vincitori del torneo possono accomodarsi nei sedili dell’aereo, (ancora col respiro affannoso per lo sforzo), il capitano ordini a 14 passeggeri di scendere, per lasciare il posto a qualche papavero in cravatta e panciotto col suo seguito di scagnozzi. E quindi qualcuno deve scendere smadonnando e tornare domani per un’altra sessione di lotta libera. Non è finita. Quando esce dall’aeroporto, il viaggiatore frustrato si trova circondato da un gruppo di tassisti che lo stordiscono gridando: Taxi!, Taxi!. Il piú veloce di loro gli prende la valigia senza tanti complimenti e spingendolo al suo taxi gli chiede: È andato bene il viaggio, signore?
Esco da quella confusione e cerco un taxi nero ufficiale, come mi ha raccomandato il funzionario, per andare sul sicuro. Eccone uno in arrivo.
-Mi chiamo Onorio, per servirla, signora- L’autista che mi accoglie è un tipo alto e magro, con un gran sorriso e un vestito a giacca dignitoso, dalla tela quasi lucida per un uso a dir poco decennale. Chiudo con sollievo una portiera ferruginosa. L’auto imbocca una lunga avenida che va dal Callao a Lima, piena di bus rumorosi e sgangherati, che lasciano dietro di sé una scia pestilenziale di fumo. La capitale cresce di giorno in giorno, mi spiega il signor Onorio, che un tempo era stato professore, (ma lo stipendio non bastava a mantenere i suoi quattro figli), per cui eccolo qui, adesso, in un taxi affittato a un altro signore che a sua volta lo affitta a lui per qualche ora al giorno. Lo spagnolo studiato all’universitá mi permette di parlare fluidamente col signor Onorio, e in caso di necessità, porto con me un piccolo dizionario.
Ogni notte, si legge sui giornali, scendono dalla sierra decine di andini dalla pelle color cannella (i disprezzati cholos), per cercare la fortuna sotto questo cielo quasi sempre grigio-lattiginoso di Lima. Ma la fertile vallata dei tre fiumi dove cinque secoli fa entrarono le tenaci truppe (piene di pulci) di Pizarro, é da qualche decennio completamente urbanizzata, e restano, per sistemarsi, solo le pendici desertiche lungo la costa. E allora le nuove bande di macilenti conquistatori devono salire su su, fino ad arrivare alla cima delle colline di sabbia, dove batte il vento che viene dall’oceano. Piantano le loro capanne di stuoia con l’immaginetta della Virgen di Candelaria alla parete, e poi si fermano un po’ storditi, la notte, a guardare sotto di sé l’immenso manto di luci della cittá, a cui si aggiunge, giorno dopo giorno, qualche altro punto luminoso.
Cammino a volte senza una meta precisa, per conoscere la cittá e osservare i volti della gente. La maggioranza ha l’aria preoccupata di chi cerca lavoro, un qualsiasi lavoro per sopravvivere un giorno, una settimana, un mese. Ci sono i tipi rumorosi, che assaltano i timpani del prossimo offrendo i loro servizi: Le sorveglio l’auto! Il giornale d’oggi! Pare che vinca chi si agita di piú. Poi ci sono i tipi silenziosi, che invitano solo con occhiate penetranti, o i rassegnati, come le mamitas con trecce e gonnelle colorate di lana pesante, allo stile andino, e il bambino caricato sulla spalla, che vendono ad altri il biglietto della fortuna, perché la loro é giá segnata.
Bambini malridotti offrono caramelle ai semafori, uomini dallo sguardo sfuggente vendono pezzi di motore usati su teli di plastica tesi sul marciapiede. Alcuni hanno il lavoro portatile, esposto in bella mostra su un carretto cigolante: idraulici, trasportatori di sacchi e casse di frutta, riparatori istantanei di ingranaggi svitati, o cuoche capaci di inventarsi un menú, giusto all’angolo tra la Abancay e Nicolas de Pierola, per offrire qualcosa di commestibile ai passanti.
Una di loro, una donna grassotta e sorridente, Teodora, mi racconta che scende ogni mattina dalla cima di una collina nel deserto con un carretto, un fornellino portatile, due padelle per fritti (con olio usato mille volte, non ho altra scelta, signori clienti), sette piatti e quattordici posate, due secchi d’acqua e un po’ di macinato di carne imprecisata, comprato per strada, con cui prepara salchipapas... ossia patate fritte ripiene: un piatto che per qualche ora ti fa credere di averti riempito lo stomaco, ma che allo stesso tempo ti assesta una tal bastonata al fegato, che te la ricorderai a lungo. Peró i suoi bambini hanno qualcosa da mettere sotto i denti, e Teodora non puó fare la schizzinosa. E un giorno, magari, potranno diventare professionisti, se Teodora nel frattempo non si scoraggia. Per questo é scesa da sola dalle montagne dell’Apurimac tanto tempo fa, con quattordici anni, due trecce in spalla, e due pannocchie di granoturco in tasca.
La capitale include e nasconde le sue differenze, mettendole in scatole cinesi isolate una dall’altra. C’é tutto, e il contrario di tutto, a Lima. Nei marciapiedi ricoperti di aiuole di Miraflores, si vedono chalet tipo svizzero, villette similbarocche, decorazioni quasi rococó che sembrano illustrazioni di racconti di fate. Dietro i muri coperti d’ibisco e gelsomini, possono vivere le zie Ernestine, professoresse in pensione tra rosari e pettegolezzi, i notai Belaunde con segretarie dai tacchi altissimi, o i commercianti di tessuti Fernandez, che si passano il negozio di padre in figlio da generazioni. Piú avanti, verso il centro, comincia a vedersi qualche edificio piú alto, con silenziosi manichini, immersi nella luce azzurrina dei negozi per spose, con indosso i vestiti inamidati, primizie di Miami. Dietro le strade strette del centro, nel quartiere cinese, i discendenti dei coolies cucinano anatra all’agrodolce, infilano aghi nei corpi docili ed estraggono molari, come facevano i loro antenati a Shangai. Piú in lá, giá fuori dal rumore e dagli ingorghi, cominciano i barrios con ville piú grandi, giardini piú esuberanti, muri piú alti.
Lá si nascondono alla vista della gente (serviti dai cholos) gli eredi di patrimoni accumulati da antichi latifondisti (vedi sopra) e alcuni industriali dalla fortuna incerta (idem). Ragazzi e ragazze dalle divise impeccabili (lavate e stirate dalle domestiche cholas) escono da prestigiosi collegi, attesi lá fuori dagli autisti che gli aprono le porte dei vetri fumé.
Velocitá e lentezza, grida e silenzio. Tra le voci estreme della cittá, a volte ondeggia un fiume di manifestanti, mettendo sossopra le strade del centro. NO AI SALARI DA FAME! gridano operai, medici e maestri. Gli risponde il fumo di gas lacrimogeni tra botte e striscioni calpestati (gli autisti hanno giá portato le Volvo al sicuro nei garages protetti dai guachimanes). Di sera la manifestazione si é giá dispersa, si chiudono le notarie Belaunde e le finestre coi gelsomini delle zie Ernestine. Teodora trascina il suo carretto fino alla punta della collina, guardando la cittá assopita nella nebbiolina grigia. La nebbia trattiene nelle sue mani umide odori, lacrime e sogni. Fumo e odore di bus, salchipapas, lacrimogeni, orina, mare e gelsomini, continuano a apparire e scomparire fra muri e giardini. Sará per questo, forse, che le lacrime non si possono piangere davvero, e le risa non si possono ridere davvero, in questa cittá. Tutto pare vivere o vegliare sospeso, nel grigio irreale, triste e soave di Lima. C´é solo qualcosa di certo. Ogni mattina qualche capanna in piú di stuoia, é stata piantata nelle colline pelate, da altri ostinati andini. I disprezzati cholos, esercito della speranza, circondano in silenzio il cuore torpe della cittá. Come cavalli di Troia, aspettando.
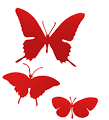 13. Il fiume lá in fondo
13. Il fiume lá in fondoAlcuni giorni dopo, salgo su un bus che s’inerpica su per le pendici ripide delle Ande. Un fiume brilla in fondo al precipizio, osservo con raccapriccio. Meglio guardare in alto, penso. Dio, quanto cielo. Le nubi cavalcano sovrane in un campo immenso di luce, che si sfa al tramonto in fili di rosso, porpora e violetto, prima di spengersi dietro le montagne. Chissá come sará stato davvero, fuori dalla retorica e le celebrazioni, il famoso Tahuantinsuyo, l’impero in cui gli Incas, per pochi decenni, organizzarono abilmente la vita di tanti popoli differenti, dall’Equador all’Argentina.
Ricordo di aver visto immagini di magazzini di grano e tambos fin nei luoghi piú impervi, o incassati in una rocca. Immensi greggi di lama e alpache nella puna, e coltivazioni agricole nella serra, erano riusciti a mantenere, secondo alcuni storici, una popolazione di circa 14 milioni di persone in tutto l’impero.
Cos’era rimasto di quest’organizzazione minuziosa e apparentemente efficiente? Mi chiedo.
Il bus adesso attraversa un paesaggio scosceso, tutto valli e dirupi, con migliaia di fazzoletti di terra dalle infinite sfumature di ocra, verde e giallo. Alcuni puntini neri in mezzo al giallo stanno raccogliendo grano, quiwicha, quinua. E patate, sempre patate. Con un’abilitá da certosini, certamente. Perché alcuni campi sono quasi verticali. Qua e lá si vedono case di fango con tetto di paglia, e asini macilenti. È chiaro che la terra non é sufficiente per tutti. I bus che scendono a valle viaggiano pieni di bambini assonnati e famiglie con fagotti, che sfuggono alla penuria di questa terra luminosa e dura.
Secondo gli andini, mi spiega Hilario, un professore di cultura quechua nell’universtá di San Marcos, ogni cinquecento anni il mondo va al rovescio, e chi sta sopra va sotto. Adesso é arrivato questo momento, dicono: sembra che il Perú sia in pieno pachacuti, solo che qui la rivoluzione non la stanno facendo studenti dalle capigliature ribelli o casalinghe esasperate, come in Europa, ma un generale con uniforme e stellette, Juan Velasco Alvarado, soprannominato “Il Cinese”.
Velasco si é proposto di combattere lo strapotere dei latifondisti distribuendo le terre delle grandi proprietá ai contadini organizzati in cooperative. Inoltre, vuole migliorare l’educazione, e valorizzare l’idioma del Tahuantinsuyo, il disprezzato quechua. Un vero pachacuti culturale, per dare dignitá a quelli che ricevono piú frustate che pane. I contadini sembrano contenti, ma le cose si complicano. I padroni, per esempio, all’andarsene si portano via macchinari e conoscenze tecniche, e quindi non é affatto facile mantenere i livelli abituali di produzione.
Le haciendas piú produttive vengono trasformate in SAIS, organizzazioni autonome di soci, dei quali peró solo pochi vivono nella zona occupandosi attivamente delle terre: ergo, ancora una volta finisce con l’essere beneficiato solo un piccolo gruppo, si lamentano i contadini. E poi, soprattutto, i contadini non ricevono nessuna preparazione per imparare ad organizzare loro stessi la produzione, e non piú solo a ubbidire e chinare la testa, come hanno sempre fatto. Io guardo e ascolto, attenta, i dettagli di questo difficile Pachacuti.
In nessun posto del mondo una rivoluzione è un giro di valzer.
Sierra, camion, don Chisciotte…mi viene in mente, adesso, la figura di un cavaliere allampanato, con gli occhi che brillano febbrili inseguendo miraggi.
Per arrivare a Huanta, nel dipartimento di Ayacucho, devo scendere dal bus e alle prime luci dell’alba salire sul retro di un camion che, mi dicono, é l’unico mezzo che trasporta esseri umani, merci ed animali in quelle lande sperdute. Sogno di raggiungere entro la notte la benedetta hacienda di don Lucho La Torre, dove potró finalmente distendere le mie ossa indolenzite, rattrappite e sballottate da un’infinitá di buche di quella carretera interminabile.
L’hacienda di don Lucho é l’unica istituzione che puó ospitare gli scarsi visitanti che per qualche peregrino motivo viaggino fino a Iribamba. So che si tratta di una fattoria non molto grande, per cui non é stata toccata dalla riforma agraria. Mi aspetto di trovare una casa rustica ma confortevole, circondata da verdi prati dove pascolano vacche e cavalli. Anzi, spero ardentemente di trovare un buon cavallo, con cui visitare le comunitá inserite nella mia ricerca educativa, assaporando la bellezza del paesaggio.
Sí sí, un buon cavallo é il meglio che mi possa capitare.
Ma quando scendo dal camion a Iribamba, piú polverosa di una vecchia scopa, é giá caduta una notte senza luna, che ha inghiottito una dopo l’altra le strisce rossa, arancioni e viola di un tramonto sfolgorante. Davanti all’unica costruzione della zona, vedo avanzare debolmente verso di me la luce smorta di una candela, che oscilla nel buio rivelando pezzi di pareti scalcinate. Ah, é cosí, allora. Altro che chalet svizzero e floride vacche al pascolo. Mi pare di essere stata catapultata indietro nel tempo, finendo nelle pagine di un’edizione stinta del Don Chisciotte. Infatti, dondolandosi su una vecchia poltrona di cuoio di Castiglia, mi sta aspettando un uomo ossuto dallo sguardo febbrile, che insegue dietro il fumo del suo sigaro l’idea geniale che porterá fuori la sua gente dal pantano della povertá: Don Lucho.
Possiede solo cento ettari di terra dura coltivata da peones allampanati, ma per Dio, giura e spergiura che prima o poi riuscirá a cavare da quei sassi benessere e abbondanza per tutti. Come base, possiede solo un consunto manuale di agricoltura lasciatogli da qualche antenato in una vecchia cassa. Dopo averlo consultato per un bel po’, leggendo e rileggendo le sue pagine consunte, l’austero cavaliere decide un giorno di intraprendere la coltivazione dell’uva malvasia, per produrre un vino degno degli dei. Lo venderó a prezzo d’oro, cazzo, e correranno tutti a comprarmelo, lo giuro su mia madre.
I peones devono rimuovere la terra, togliere le pietre, strappare le erbacce, e finalmente piantare le viti, maledicendo in silenzio don Lucho per tutta quella fretta e quel lavoro in piú. Quando sui filari cominciano a spuntare piccoli grappoli d’uva, don Lucho, dondolandosi sulla sua poltrona di cuoio di Castiglia, si mette a calcolare con pazienza quanti litri di questo vino degli dei si puó produrre, quanto denaro intascare, quanto distribuire. Manca solo un dettaglio. Nella maledetta pagina 13 del manuale, una macchia copre la cifra che specifica a quale altezza massima puó maturare l’uva malvasia. Don Lucho non ci ha fatto caso. Solo dopo aver tirato fuori, come risultato del lavoro di una quadriglia di peones in ettari ed ettari di sudatissime pendici, quattro bottiglie 4 di un vino acidulato, il cavaliere si rende conto che coltivare malvasia a piú di tremila metri é proprio roba da pazzi.
Beh, ormai é fatta. La festa é stata programmata e non c’é motivo di sospenderla. Dalla nonna Josefina ai peones allampanati, tutti sono stati invitati a brindare con quel dannato vino acido. Alla salute di don Lucho, e doña Josefina! Tutti devono fingere entusiasmo. La doña peró approfitta di un accesso di tosse per sputare il suo bicchiere. I peones no, loro devono trangugiarselo tutto, facendo di nascosto smorfie di disgusto.
Sconfitto, il nostro cavaliere? Macché, don Lucho, perché si sappia, è tutto d’un pezzo. Si tratta solo di cercare un’altra idea, no? Aguzzando un altro po’ l’ingegno, di sicuro scenderá dal cielo l’idea giusta per trionfare una buona volta sulla povertá. L’illuminazione giunge il giorno dopo, insieme a una nube che poco a poco oscura tutto il cielo, nera come i draghi dell’Apocalisse. Da non credere….sono cavallette! Stavolta, siamo finiti direttamente nelle pagine della Bibbia, alla piaga tal dei tali. Ma don Lucho non si deprime, anzi, al contrari osi frega le mani dalla contentezza. Cavallette uguale proteine, no? e magari dal sapore simile a quello dei gamberi, provare per credere. Quindi ordina ai suoi peones stralunati, che lo guardano come se fosse un ufo: “Preparate i pentoloni, svelti! E niente “se” e “ma”!” Poco dopo, sui fornelli borbotta una minestra dal colore incerto. E dal sapore orribile. Stavolta, anche i suoi cani Manco Capac e Mama Ocllo si allontanano dalla tavola, per vomitarla lontano, con dignitá.
Passeggio con la nipote di don Lucho, Augusta La Torre, per un sentierino di cactus e alberelli di huaranguay, prima del tramonto. È una ragazza gentile, sposata con un professore di filosofia dell’Universitá di Ayacucho. Ho bisogno di sfogarmi.
-Stamattina ho visto una scena terribile, Augusta. In un’hacienda stavano frustando a sangue dei peones, per aver rubato un pugno di riso. E gli altri salutavano inginocchiati ai loro padroni, Buenos días Papacito, buenos días Mamacita…, come se fosse il Sommo Pontefice, con una profusione di diminutivi, anche se l’affetto, è chiaro che non c’entra per niente. Mi sembrava di rivivere scene del Medio Evo. Gli uomini continuano ad esser trattati come bestie da soma, le donne dormono sulla nuda terra, o esposte al freddo di un capannone. Il corpo delle giovani serve é territorio di godimento gratuito per i maschi della famiglia privilegiata. Ad saecula saeculorum, amen. È stato sempre cosí, mi dicono. Ma chi avrá cominciato, all’inizio? insisto. Amadeus ha ragione, penso. C’é una radice marcia all’origine di molti patrimoni.
Viaggiando per la sierra annoto sul mio quaderno, ormai un cahier de doléance, anche i dati desolanti di un sistema educativo che ha ben poco del suo nome. La letra con la sangre entra. “S’ impara a frustate”: questo il principio piú utilizzato nei paraggi. I maestri possono picchiare i bambini quando si distraggono dal copiare lavagnate intere di scritte incomprensibili. I bambini non possono esprimersi, i maestri sanno solo gridare. È una scuola che serve a poco o niente. La gente non protesta, perché ha altro a cui pensare. Per esempio, a come riuscire a sopravvivere.
-Sí, il Perú avrebbe bisogno non di uno ma molti pachacuti...-risponde lei.- A proposito, Marianna, dovresti conoscere mio marito. È un uomo che puó sembrare anche troppo serio a chi non lo conosce, ma per me é un genio.
Ha visitato la Cina e sta preparando programma politico di grande respiro per costruire una societá nuova in Perú. Vuole chiamarlo Sentiero Luminoso.
Molti studenti lo seguirebbero fino alla morte, ti giuro, per vendicare tante ingiustizie e sofferenze che si vivono ogni giorno nel paese.. Anche lui ha sofferto parecchie umiliazioni.
Augusta tace, per discrezione, i dettagli della vita personale di questo grigio e carismatico professore. Li conoscerò tempo dopo.
Figlio illegittimo di un amministratore di haciendas, abbandonato da sua madre a otto anni, ma accolto da una madrina compassionevole, Abimael s’innamoró di una ragazza ma fu ostacolato dalla sua famiglia, che l’allontanó anche dalla figlioletta avuta da lei. Fin qui, niente di nuovo: uno dei tanti amori frustrati da pregiudizi sociali, profondi come gli abissi di questi scoscesi paesaggi andini. Ma questo giovane non piegó la testa, e forse in una notte insonne giuró a se stesso, esasperato, che avrebbe mostrato al mondo quello che sapeva fare, nel bene e nel male. Migliaia, milioni di giovani, i suoi veri “figli”, lo avrebbero seguito senza batter ciglio, attraversando fiumi di sangue, per costruire il mondo che sognava.
E intanto noi, ignare, camminiamo fra cactus e alberelli di huaranguay, commentando ció che succede nel nostro piccolo mondo.
Una lieve brezza gioca con le foglie argentate degli eucaliptus, nel cielo splendido del Tahuantinsuyo. La tempesta è ancora lontana.
Nessuno poteva prevedere che alcuni dei seguaci di Abimael Guzmán mi avrebbero cercato e catturato trattandomi da gringa, straniera pericolosa, sfruttatrice del popolo, marcandomi a fuoco con etichette grossolane: un meccanismo come il razzismo al contrario, per compattare l’unitá del gruppo contro gli “stranieri”, i diversi. Gringa. Pericolosa gringa. Non è la prima volta che mi tocca quest’odiosa etichetta. La prima fu quando conobbi da vicino la durezza della vita nelle Ande.
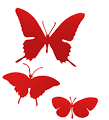 14. Zelinda
14. ZelindaNella scuoletta dei servi di Iribamba, sto prendendo note nel mio taccuino sull’infausto sistema educativo ivi praticato, quando un grido mi fa correre alla porta. Una donna cerca gesticolando di scacciare una tarantola che le ha punto una gamba. I suoi due bambini, che ha accompagnato alla scuola, la guardano spaventati, senza sapere che fare.
Corro ad assisterla, e ricordando qualche modesta nozione d’infermeria appresa durante la guerra, mi metto subito a succhiarle il veleno dalla gamba.
Grazie, warmi, mi risponde lei con gratitudine, cercando di baciarmi la mano.
E mi regala un sorriso che si apre come un arcobaleno tra le rughe. Di niente, rispondo emozionata.
Zelinda è una donna magra d’etá indefinita, carica di figli come tante donne andine, con una gonna rossa scolorita e un cappello marrone sulle trecce. Cosí va vestita la maggioranza delle donne in questi paraggi. Conosceró la sua forza qualche giorno dopo, arrivando con una vecchia mula in una comunità vicina, oggetto della mia ricerca.
Questa mula testarda non ha nessuna voglia di andare al galoppo, come i magnifici cavalli di Emma Malaspina. Povera me! Al contrario, procede ostinatamente sul filo dell’abisso, anche se cerco di spingerla con tutte le mie forze verso il fianco della montagna…. Alla fine mi rassegno, e scopro che cavalcare in un incerto equilibrio su un sentirono scosceso, con la visione costante del vuoto che mi affianca, alla fine rende ancor piú eccitante il viaggio. Anzi, che meraviglia! Respiro a pieni polmoni e ammiro l’azzurro intenso del cielo, la corona delle montagne in lontananza, le pendici vertiginose. Ma quando arrivo alla comunitá tutto il mio entusiasmo per la grandiosa magnificenza della natura si trasforma in sconcerto di fronte allo strano comportamento dei comuneros. Perché i bambini vengono tirati uno dietro l’altro dentro le case da mani nodose? Perché tutte le porte mi vengono chiuse in faccia, e i pochi passanti in circolazione mi guardano con ostilità? Gringa,… pishtaca, ….pishtaca! Sento sussurrare qua e lá. Povera me, se è questo che credono! Perché il pishtaco è un personaggio mitico, odiato e temuto allo stesso tempo, che ricorda i terribili tempi della Colonia. Dicono che a volte, di notte, in certi paraggi solitari, si vede sbucare dalle rocce la figura di uno spagnolo che dá la caccia agli indios per estrargli il grasso e ungere con esso i ferri dei suoi cavalli e le campane delle sue cattedrali…(qualcosa di simile era certamente successo nei secoli bui della Conquista).
I Quechua andini hanno ragioni storiche da vendere per odiare il pisthaco spagnolo, ma io che c’entro, se sono arrivata lí da Berlino con le mie migliori intenzioni?
Quando entro nella scuola, la maestra mi avvisa allarmata: -Corra via, signora, i comuneros potrebbero linciarla! Donna Josefa, la proprietaria terriera della zona, sta facendo correre la voce che lei é venuta per estrarre gli occhi ai bambini per venderli ai paesi ricchi!
La ringrazio dell’avviso, ma al tempo stesso osservo che anche il suo sguardo é inquieto. “E se fosse vero?” sembra chiedersi la maestra.
Dio, che momentaccio. So che a volte, in certi periodi di crisi politica e sociale, la psicosí del pishtaco o dello “strappaocchi” puó diffondersi in una zona carica di problemi, e la gente puó cercare un capro espiatorio per farlo fuori a bastonate, e liberarsi dell’ansia. Se c´é uno straniero nei paraggi, (che raccoglie su di sé invidie e rancori secolari), meglio ancora. Via libera al massacro.
E adesso che faccio? Mi appoggio allo stipite di una porta, cercando di pensare a come diavolo uscire da quell’imbroglio. Non mi vengono idee geniali: non sono Batman né lady Jane, per nascondermi saltando sul tetto. E intanto uno scalpiccio di passi pesanti mi avvisa che qualcuno si sta avvicinando alla scuola... chiudo gli occhi, immaginandomi giá il peggio, e mi preparo a difendere la porta. Ma i miei rivali sono piú forti! Adesso si apre con violenza, con uno spintone che mi fa vacillare.
-Come?! Sei tu, Zelinda? Accidenti, mi hai fatto spaventare! Tu da sola, hai piú forza di un toro che scappa dal recinto…
-Proprio vero! – Zelinda adesso fa uno dei suoi sorrisi come arcobaleni, e mi prende decisamente per il braccio, per portarmi di corsa nella piazzetta della comunità.
-Marianna é una brava persona, comuneros! -proclama ai suoi vicini, rompendo quel silenzio denso e duro, che circonda le case come una muraglia.
-Non dovete aver paura, non vi fará niente di male! – conclude, abbracciandomi con un gesto appena un po’ teatrale. Solo in quel momento le porte delle case cominciano ad aprirsi, prima con cautela, poi con decisione. Ne escono, uno dopo l’altro, vari uomini e donne che mi vengono intorno formando un circolo. Non mi posso muovere. Sono nelle loro mani. E se qualcuno afferra il primo palo, e…?
-Cosa sei venuta a fare, qui, gringa?- mi apostrofano alcuni, diffidenti. Sta per cadere la notte, e un vento freddo arriva sibilando dai picchi acuti delle montagne. Mi accorgo che la mia frangetta é bagnata di sudore.
Per qualche secondo, mi concentro pensando cosa sará meglio rispondergli.
E poi cerco di spiegargli come posso, nel mio quechua elementare, perché sono venuta qui, e come desidero di tutto cuore che le cose vadano meglio per loro.
Forse, piú che le parole, parlano i miei gesti, i miei occhi. Cosí, un po’ per volta, il cerchio ostile comincia ad aprirsi, e la gente comincia a disperdersi, con brevi cenni di approvazione. Respiro sollevata.
-Adesso c’é da preparare il “corta monte”, mi dice Zelinda.
Il “corta monte”? Sí, bisogna piantare nel suolo un albero, simbolo della fertilitá, spogliarlo della maggior parte dei rami, e decorare il resto con nastri colorati, qualche pezzo di carne di lama, un’arancia, qualche caramella. Una specie di albero della cuccagna, con modesti premi per i giovani piú coraggiosi che vi saliranno sopra, per afferrare i regali e distribuirli a tutti tra gli evviva.
Ore dopo, vedo quei rudi contadini passarsi l’un l’altro la bottiglia di aguardiente, commentando le prodezze dei giovani, e dopo un po’, scoppiare a ridere a crepapelle. I piedi cominciano a pestare forte il suolo intorno all’albero, al ritmo di bombos e flauti, le trecce e le gonne a volare nel ballo. Una donna m’invita a bere un goccio di aguardiente. Allora esisto! Bevo un sorso che mi cade nello stomaco come dinamite, ed entro saltando nella ronda.
Non ci sono bicchierini di aguardiente, adesso, solo un sole cocente. Da quali montagne saranno scesi questi ragazzi dallo sguardo sfuggente? Cuzco, Apurimac, Puno? Gli avró preso una manina in un gesto affettuoso, mentre stavano caricati in una manta sulle spalle della loro mamma, magari in uno di quei vivaci mercati andini, o in una delle loro fantasmagoriche feste? Ci sará, tra di loro, un figlio di Zelinda?
Guardo le loro facce sudate sotto il sole spietato della selva. Sono adolescenti, son solo ragazzi. I loro occhi allucinati sanno ancora ridere, per qualche istante. Di sicuro, sognano un mondo piú giusto. Quante volte saranno stati umiliati? E qualcuno li ha convinti che con una mitragliatrice in mano potranno costruire un mondo differente, e si libereranno di quella miseria acida che mangiano tutti i giorni. Potranno essere finalmente qualcuno. Ma sangue chiama sangue, e ancor piú odio, e piú dolore. Questo, non gliel’hanno detto.
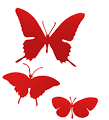 15. Stelle e tamburi
15. Stelle e tamburiQuando torno a Berlino, posso parlare solo con poche persone di quanto mi ha emozionato in Perú. Si tratta dei miei giovani amici: Ingrid, una vulcanica femminista dalle lunghe gonne a fiori; Dieter, minuto, acuto e logico come un cristallo; Amadeus, dalla capigliatura espressionista, mente brillante e cuore caldo. Con loro possiamo farci tutte le domande del mondo, anche senza riuscire a trovare tutte le risposte.
Ho salutato i primi due, non ho ancora visto Amadeus.
Mi avrá ricordato davvero ogni giorno, mentre ero lontana? mi scopro a chiedermi, come una ragazzetta.
D’improvviso, scorgo la sua testa inconfondibile nel cortile della facoltá. E’ girato di schiena, e sta leggendo gli avvisi della bacheca. Il mio cuore comincia a saltare come un cavallo imbizzarrito. Lui si gira, mi riconosce, comincia a venire verso di me, come al rallentatore. Forse è solo questione di qualche secondo, ma a me sembra che duri un tempo infinito, quel suo scivolare fra gruppetti rumorosi di studenti. Dopo, mi sento avvolgere in un abbraccio silenzioso, profumato di sandalo e menta.
-Raccontami tutto, Marianna. Quanto ti ho aspettato.
-Come ti è andata in Perú?
-Intenso, intenso. Ausangate, la selva, don Lucho, Zelinda.
Zelinda! Guardo la sua pancia gonfia.
-Cuanto ti manca?- Le chiedo.
-Poco: una settimana, forse due.
-Sará un parto complicato- sentenzia la vecchia ostetrica consultata, masticando il suo mucchietto di foglie di coca-Speriamo che Dio ci protegga.
Zelinda si stringe nelle spalle e va al torrente con la sua cesta di panni da lavare. Quelli di suo marito e dei suoi cinque figli piccoli, piú quelli del vecchio padre e di uno zio invalido. La seguo con lo sguardo, vedendola avanzare a fatica fra le pietre del torrente, fermandosi ogni tanto per una fitta di dolore che le attraversa il corpo.
-Ehi, Zelinda, fermati!- Corro verso il torrente per raggiungerla. Stavolta, non riuscirá a uscirne viva- mi viene da pensare come in un lampo.
Zelinda si gira.
-Che ti succede, Marianna?
-A me niente. Piuttosto, se non ti offendi, potrei accompagnarti all’ospedale di Huanta, e con un po’ di denaro, sai, potrai avere un’attenzione migliore, piú sicura.
Lei mi guarda scuotendo la testa.
-Perché no? Non ti meriti anche tu di essere ben assistita una buona volta, quando passi la vita assistendo gli altri?
-Non vale la pena, visto che lá mi tratterebbero come un’india sudicia e ignorante. Meglio comprare scarpe ai bambini.
E Zelinda riprende a camminare fra le pietre del torrente, con la sua cesta di panni.
Adesso, si è fatto scuro. Zelinda si alza da terra, toglie dal fuoco una pentola di patate, le rimuove, le serve alla famiglia. I dolori si sono fatti piú forti. Come spade affilate che attraversano il suo corpo, dall’alto in basso, silenziose.
Poi, piano piano, senza interrompere la loro cena, apre la porta ed esce. Nessuno deve vederla. Solo la luna e le stelle. Il silenzio è profondo. Latrati di cani in lontananza. Ma Zelinda deve andare fino alla falda della montagna, dove la terra è piú dura e la notte piú nera.
Lá c’è l’unica persona che sa darle protezione e affetto. L’unica di cui si puó fidare veramente. Il vento l’accompagna, sibilando fra le croci.
Questa è la sua. Quella di ferro ossidato. Zelinda si stende sulla terra e apre le gambe. La tomba di sua madre riceve il suo sangue.
Restiamo un attimo in silenzio. Intorno a noi, i volti, le risate, le parole, si allontanano in una nube vaga.
-Dio…- dice Amadeus chiudendo gli occhi. Quando li riapre, siamo piú vicini.
Mi cerca la bocca, me la accarezza con le labbra, le esplora, me le ricorre come fiumi di lava. Mi lascio fluire in questa vertigine calda.
Presi per mano, andiamo correndo alla sua stanza in affitto nel Kreuzberg, il quartiere turco. La metropolitana, le facce, le risate, le parole. Tutto fluttua indistintamente dietro un fondo di bottiglia, come delfini lontani in un mare d’estate. Ci sono solo i suoi occhi, le sue labbra, il suo riso. La sua dolcezza.
Amadeus, ha mani che mi fanno vibrare come un’arpa. I suoi capelli da Beethoven spettinano la mia frangetta perfetta. I nostri corpi disegnano soavi adagio di carezze, allegro successione di baci, andanti cavalli nelle praterie, pastorali armonie di pace.
Amadeus, violini, tamburi e stelle. Anche a Berlino c’é un Koyllur R’iti.
Mi sento un’altra.
Non appartengo piú a questa foto di gruppo che è stata finora la mia vita. È la foto che si sta ingiallendo, o è la mia immagine a farsi sfocata? Camminando nelle frenetiche strade del centro, penso con nostalgia alle notti stellate delle Ande. In una vetrina scintillante, vedo il sorriso della donna asháninka che mi regala una collana di semi. Markus mi sembra un fantasma, che entra ed esce distratto dalla casa dai pavimenti lucidi. Parliamo il meno possibile, per non aumentare il solco che si sta aprendo tra noi, giorno dopo giorno.
Un’altra foto festosa: la mia laurea in antropologia. Metteró ancora una volta in fondo a un cassetto il mio titolo?
E Amadeus.
-Vieni con me, Marianna. Separati una buona volta. Non sei piú felice con Markus, non lo vedi?
-Ma la differenza d’etá, i miei figli, e un giorno vorrai un figlio tuo, e il matrimonio per sempre…
-Non preoccuparti cosí tanto per il futuro, Marianna. Il futuro nasce oggi. E l’amore, c´è o non c’é. Non è questione d’etá. E quando finisce, bisogna accettarlo. Miser Catulle, desinas ineptire… ricordi?
-Questa frase di duemila anni fa, non l’hanno scritta per me.
No e no. Solo al pensiero di separarmi da Markus, mi sento cadere in uno strapiombo.
É passata una settimana, e …
-Markus, che ti sembra l’idea di fare una buona terapia di coppia?
-Questo mese ho due congressi. Se mai., dopo.
-Dopo quando?
-Dopo quando.
E Markus sparisce con la sua valigetta.
È arrivato il “dopo” di molti “quando”, ed eccoci finalmente seduti, composti, e un po’ rigidi, di fronte alla famosa psicologa Karla Kupfer, che dicono abbia una grande esperienza in paturnie e paranoie varie, di singles o coppie.
È una bella donna slanciata, sui cinquant’anni, coi capelli cortissimi, lo sguardo diretto e franco, dietro un paio di occhiali dalla montatura colorata (design italiano). Siede su una poltrona di pelle dietro a un tavolo di cristallo e ha in mano ha un lapis e un quaderno (marca tedesca), dove prende note veloci. La ricorderemo come il Bulldozer, piú potente ed efficace, da solo, nel dare la mazzata finale alla nostra traballante relazione, dell’ intero Comitato Dame.
-Bene, signori, raccontatemi di quando e perché avete deciso di mettervi insieme, vent’anni fa -chiede aprendo la sessione.
Io porto la mia famosa collana di perle (regalo di Markus nel giorno delle nozze, in cui mi dette tanti baci quante erano le perle), Markus con uno dei suoi soliti completi sportivo-eleganti, con camicia a righe (naturalmente). E un sorriso un po’ imbarazzato. Che finisca presto... queste cose da donne sono una palla totale, gli si puó leggere nello sguardo. Comunque, vediamo dove ci porta, la signora design.
-Cominci lei, Marianna- mi fa cenno Karla.
E io racconto di quel ragazzo fantastico che conobbi piú di vent’anni fa, in un bosco bellissimo delle Alpi austriache, che sembrava un bosco di fate... e lui mi chiese di aspettarlo... Infatti, ancora adesso continuo ad aspettarlo, tante notti senza dormire, ma lui mi pare che la prenda sempre piú larga, la strada di casa. Adesso mi abbraccia cosí poco! E anche se il dottor Weber mi ha dato qualche pista, non capisco perché continua ad innamorarsi di altre donne. Tutte le volte credo, e spero che sia l’ultima, e invece…Tanto che alla fine, solo da qualche tempo, che questo sia ben chiaro, ho accettato l’amore di un ragazzo che... (Markus alza gli occhi al cielo: anche un cieco se ne sarebbe accorto!), ma io sono disposta a...
-ALT!- mi interrompe la psicologa, per evitare che scopra le mie carte. Bisogna negoziare un po’, no? signora tonta!, mi dicono severamente i suoi occhi, dietro la montatura design. -Adesso tocca a lei, Markus.
- Sí, mi ero innamorato di un’altra ragazza, all’inizio. Ma dopo, mi resi conto che Marianna era la moglie perfetta per me, e per questo feci mille acrobazie per comprarle il benedetto anello di fidanzamento, un vero brillante certificato... Ossia comprai, trasportai e vendetti alcuni mobili antichi di ex proprietari terrieri polacchi, o ebrei, o tedeschi rovinati... E poi, per portarglielo a Firenze, presi in affitto una moto di seconda mano che in viaggio si riveló un rottame... E per strada, verso il Brennero, rischiai la vita con un camion che uscí di corsia sfiorandomi per un pelo... Finii fuori strada ma non mi feci un graffio, un vero miracolo vi giuro, solo la moto perse qualche bullone. Ma quando vidi Marianna, cosí bella e disperata...- la voce di Markus si rompe improvvisamente per l’emozione. Sogno o son desta? Lo ascolto che dice: -Tante volte sono stato una bestia con lei...
Mi prende la mano. Ci guardiamo. E ci abbracciamo commossi.
-Ecco qua i fazzoletti. Bene, bene- conclude la psicologa che d’un tratto sembra essersi ricordata di avere un altro appuntamento. La aspettano altri clienti, o deve andare a pattinare sul ghiaccio?
-Per finire, signori miei, vi dó un consiglio, anche se in teoria dovreste arrivarci da soli, ma é solo per accelerare un pochino. Lei, Marianna rompa con quel caro ragazzo, il giovane Amadeus (vero?), lei Markus con la sua ultima amante. Provate a sentirvi di nuovo come quei due trentenni in una moto sbullonata. Perché non fare di nuovo un viaggio a Firenze, per ritrovare l’emozione di quel periodo meraviglioso? Stavolta magari con una moto potente! Coraggio, potete ricominciare da capo!
Karla ci sorride aprendo le mani. Voilá.
Geniale! Ci asciughiamo le lacrime e usciamo abbracciati, inciampando nello scalino per l’emozione.
Che tremendo diluvio, quel giorno. Adesso devo andare al Kreuzenberg, a riprendere dei libri sul Perú prestai ad Amadeus. Vive vicino alla Sebastianstrasse, dove passa serpeggiando quell’orribile muro di Berlino, che divide in due la cittá e il mondo. Suono il campanello ed entro, senza togliermi il cappotto.
-Ti vedo strana Marianna, c’é qualcosa?
-C’é che... Amadeus, non me la sento piú di tenerti come fossi il mio giocattolo. Sai, io non posso lasciare Markus, non ce la faccio. Ti voglio dannatamente bene, e per questo voglio che ti senta libero, senza condizionamenti da parte mia che...
Amadeus dá una sberla ai libri ben disposti sul tavolino, e li fa volare in aria tutti quanti, insieme a una scatola di fiammiferi che si spargono a terra. Non l’ho mai visto cosí infuriato.
-Ma che bello! I piccioncini sono tornati insieme, no? Ascoltami una buona volta, Marianna. Ti parlo al di lá del mio ego, di quello che vorrei con te -guardo i suoi occhi, accesi da un amore furibondo-. STAI FACENDO LA SCEMENZA DEL SECOLO!- mi grida. -Credi che Markus possa cambiare per una frasetta buttata lí da una psicologa design? Se le scene drammatiche, i “perdono Marianna” sono la sua especialitá!
Touchée. Ha ragione. Quante volte ho vissuto drammi e riconciliazioni?
Inghiotto.
- Eppure, non so come spiegarti, Amadeus. È che se non l’hai vissuto, non puoi saperlo. Il matrimonio ti fa con un’altra persona, come la farina e l’acqua. Tu distingui nel pane la farina dall’acqua, no, vero? È come... come...
-Anche quando non ti ama piú, non ti abbraccia piú, se ne va con tutte le donne meno che con te? Scusa la mia brutalitá Marianna... È ancora matrimonio perché gli servi quasi solo per trovare una minestra in tavola, quando gli gira, e le sue camicie stirate... Perché non si paga una cameriera?
-Adesso non esagerare, Amadeus! Una volta mi ha detto: Qualsiasi cosa io faccia, sappi che ...
-Ahaha che ridere. Ti ha detto, vero? Ma guarda ai fatti, una buona volta, non alle parole al vento! “Marianna, la donna della mia vita”. “Il viaggio della tua vita”. “Una lavatrice per la vita”. Le stesse formule magiche per le lavatrici germaniche e gli amori sbiaditi. Non hai studiato in Mc Luhan come si usa il linguaggio pubblicitario? Solo per rincitrullire pensionati, bambinetti e casalinghe.
Resto zitta, con gli occhi chiusi. Forse ha ragione, ma non posso dargliela. Non so piú niente. Non so piú niente di niente.
-È solo paura di restar sola, Marianna! RESTI CON LUI PERCHE´ HAI PAURA DI VIVERE! Apri gli occhi, una buona volta.
Apro gli occhi. Il suo viso mi é vicinissimo. Questi occhi grandi, disperati, pieni d’amore.
-Stai vivendo gli anni forse piú interessanti del secolo... gli anni Settanta. Milioni di persone si stanno chiedendo come migliorare la loro realtá e l’intero mondo, hai a disposizione le migliori biblioteche dell’Occidente, e questi sono i risultati: paura della libertá. Rinunci a vivere per paura che un giorno, magari, chissá, resti sola. E allora? Non ti sei accorta che nasciamo e moriamo soli? Bisogna accettare il nostro essere “uno”: accompagnati, ma “uno”. Ma tu vuoi restare attaccata alla tua sciapa minestra quotidiana, anche se ormai é piena di muffa.
Amadeus prende il suo cappotto.
-D’accordo, Marianna, ti lascio alla tua minestra ammuffita. E tanti auguri. Non mi vedrai piú, se é questo che vuoi. Grazie per aver messo sossopra la mia vita in questi ultimi due anni…. ubriacandomi di gioia. È stato un privilegio conoscerti.
E poi si gira per mettersi la sciarpa, senza guardarmi.
Io prendo il mio zaino e i miei guanti, leggermente stordita, ah, l’ombrello, mentre lui apre la porta e mi lascia passare. Poi la chiude con un colpo secco.
Non ci resta che scendere le scale, in silenzio. Le sue scarpe con le suole di gomma fanno strada, i miei stivaletti le seguono. Il mio zaino pieno di libri, lo sento piú pesante di una bara.
Siamo giá in strada: Nel cielo plumbeo alcuni lampi accoltellano le nubi che si stanno accumulando, senza riuscire a disperderle. Tra poco verrá giú un diluvio.
-E ricordati una cosa, Marianna. - Amadeus si ferma un attimo prima di svoltare per la Eisebahnstrasse, con gli occhi lucidi, lucidi.
-Sí?
-Che quello che piú temiamo, quello a cui sfuggiamo, prima o poi, ci toccherá viverlo. Addio, e buona fortuna.
Un tuono, e comincia a scrosciare.
Amadeus se ne va senza un bacio, in fretta, quasi correndo. Spariscono sotto pioggia la sua bella testa espressionista, e il suo cuore di stelle e tamburi.
L’ho perso, l’ho perso. Mi sento pervadere, all’improvviso, da un brivido gelato. Giro per la Sebastianstrasse, e scoppio in pianto.
Gli eventi cominciano a rotolare giú, sempre piú veloci, come una valanga. Mentre rinuncio ingenuamente a Amadeus, Markus non cambia di una virgola le sue abitudini, continuando beatamente con le sue manovre clandestine. Clandestine é tutto dire, ormai non c’é piú niente di segreto. Io mi sento crescere dentro una rabbia infinita, come una lava che fará saltare la casa, prima o poi. Siamo agli ultimi giorni di Pompei.
A Firenze come due colombi? Certo, è un’idea magnifica, quella della famosa Karla. Ci andiamo in auto, per visitare brevemente un terreno di famiglia e tornare. Millecinquecento km di pura tensione: il viaggio piú triste della mia vita. Neanche una parola mentre sfilano i boschi, i campi, le montagne, le cittá della nostra bella Europa. Nell’auto c´é un silenzio cosí tossico, che basterebbe accendere un fiammifero per far saltare tutto. Nel sedile posteriore c’é nostro figlio, Alexander, di diciassette anni. Non é mai stato un chiacchierone, ma quando finalmente (oh finalmente!) arriviamo alle scale della bella casa di Berlino, pronuncia una frase chiara e definitiva, come poche:
-Basta cosí, genitori miei. Papá: o te ne vai tu, o me ne vado io.
Se ne va Markus, il giorno dopo, senza una parola. Lo vedo scendere le scale con le sue pesanti valigie, piene di camicie a righe, di completi sportivi, di scarpe italiane, di vestiti blu per le cene sociali. Io salgo per riordinare le camere. Ci scambiamo una rapida occhiata senza espressione. Di tutto questo trambusto, resta appena una striscia sui pavimenti lucidi. Sento solo, di lontano, il fragore della valanga annunciata.
Poi, mi sento risucchiare in un vortice oscuro. Sono cosí dolorosamente, e maledettamente vere le parole di Amadeus. Ció che piú temo e piú evito, mi sta cadendo in testa col peso di una tonnellata. La solitudine. Ho perso in una sola mossa i due uomini che amo. Geniale davvero, Marianna. Il tuo Grande Amore é risultato poco piú che un topolino, forse partorito dalla montagna della tua fantasia. E il Piccolo, che hai respinto, ha lasciato dietro di sé un alone di luce e polvere di stelle, come una cometa.
I pavimenti di casa sono piú lucidi che mai, visto che nessuno ci cammina sopra.
Ricordo l’occhiata tenera e ironica del dottor Weber, quella notte in cui inizió la movida. Un po’ di Bailey’s, Marianna?
Un pochino, dottore, avevo risposto. Adesso, perché no? Posso berne quanto mi pare. Un giorno mi scolo una bottiglia intera, fino a vedere sfumare i contorni delle cose. Porte, mobili, tende, tutto comincia a fluttuare nel vuoto, perdendo le sue connessioni. Tutto ció che ho cercato di mantenere unito, ordinato, sotto controllo, adesso ondeggia liberamente, non si sa verso dove. E in questo caos, si aprono delle bocche orrende che gridano al silenzio, come nei quadri di Munch.
Come posso sentirmi, dottor Weber, quando all’improvviso sparisce quella che è stata per venti anni la fonte principale delle mie emozioni…felicitá e rabbia, adrenalina e ossitocina…. Markus forever, cosí credevo. O forse era solo un attaccamento malato? Ma senza queste emozioni, c´é solo la nebbia anonima, insopportabile del mio Non-Essere.
Parlo sola allo specchio. Finché giorno, nel mio torpore, sento la voce chiara e nitida di Alexander (ah, allora è qui con me, mi dico) che mi grida:
- Mamma svegliati! Voglio che tu viva!
Per la terza volta, qualcuno che mi vuole bene mi dice:
- Svegliati, se vuoi vivere!
Amadeus, Amadeus,... penso con una fitta dolorosa. Dove sarai finito, con il plusvalore del tuo sguardo caldo, delle tue mani di violini? Si é trasferito a Malmo, in Svezia, mi dicono gli amici. Fuori campo, fuori pericolo.
“Mi sono stancato di aspettare Marianna. Quando tutto andava a meraviglia fra noi, mi ha tradito”, ha confessato a un amico. E quindi.
Intanto arrivano le fatture, le tasse, le scadenze delle assicurazioni. Dove diavolo si pagano? E’ sempre stato Markus a occuparsi della gestione del denaro. Ma soprattutto, COME si pagano? Sono rimasta con un armadio pieno di vestiti, e duecento marchi in tasca. Muovi il culo, Marianna!
Grazie, belle vacche di razze selezionate, frisone e svizzere dagli occhi mansueti. Mi avete salvato dalla vergogna di chiedere soldi all’ex Uomo della mia Vita.
Appena fuori Berlino, mi avvisa Ingrid, hanno impiantato una grande feria di bestiame, e cercano commesse. Perché non tentare? I miei studi di Cambridge sui sonetti di Shakespeare non sono incompatibili col maneggiare una cassa, o preparare e offrire succhi di frutta tra vacche di razza selezionata. In futuro, vedremo. Per ora, sono contenta di mettere insieme un po’ per volta tanti piccoli biglietti, e ogni settimana un biglietto piú grande. Per ora.
“Ma dov`é la stella di neve del mio destino, apu Ausangate?”, penso guardando fuori, notte dopo notte. Una cappa di nubi copre case e fabbriche. Silenzio. Dove hai sentito le stelle piú vicine... sento risuonarmi dentro queste parole. Sará in Perú, allora?
Il giorno dopo scrivo alla cooperazione tedesca, rendendomi disponibile come antropologa per progetti educativi con i popoli indigeni. Sono passate settantadue ore dalla mia offerta, e sto guidando la mia Wolswagen nella Clay Allee, quando provo una sensazione strana e forte. Anche Zambo, il mio cane, fiuta qualcosa di strano e mi salta addosso, come in un abbraccio. E cosí, cane e padrona abbracciati, proseguiamo nel frenetico traffico della Clay Allee. In casa trovo la velocissima risposta della cooperazione tedesca. Sí, mi accettano per occuparmi dell’educazione elementare dei bambini indigeni nelle Ande. E mi accludono il biglietto, con data aperta, e la frase: Destino: Lima, Perú. Solo andata.
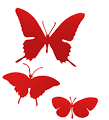 19. Messaggi e simboli
19. Messaggi e simboliMi muovo in punta di piedi, nei primi tempi a Lima. In ogni paese esistono codici specifici e dettagli differenti nel gestire la vita quotidiana, e gli stranieri devono stare in campana per non fare gaffes, non offendere nessuno, capire cosa vuol dire veramente l’altro, anche senza dirlo, eccetera. Ci vorrá del tempo, immagino, per imparare a destreggiarsi. Questo succede dappertutto. Ma è soprattutto a Lima dove banali pratiche di vita quotidiana possono tradursi in pezzi di teatro surreale.
Prendiamo la dogana, per esempio: un kafkiano Labirinto del Fauno.
Puoi perderci giorni o mesi, prima di poter ritirare un pacchetto con cassette di Listz che ti hanno mandato dalla Germania. Che meraviglia, eccolo lí, il mio pacchetto, a meno di cinquanta cm. di distanza dalle mie mani, appoggiato con altri .sulla scrivania dove regna l’Impiegato numero 1! Glielo segnalo e chiedo: “Posso ritirarlo? La mittente è la mia amica Cristine Kruger, Eisebhanstrasse 25, Berlino. Sono un paio di cassette della mia musica preferita”, dichiaro con un gran sorriso all’Impiegato n.1, e gli mostro uno, no, due documenti di identitá perfettamente in regola.
-NON LO TOCCHI, NON SI PUÓ! Risponde allarmato l’Impiegato numero 1.
-Perché no?
-Perché adesso deve passare all’Impiegato n.2, per un timbro, e poi al 3 e al 4 per altri timbri, e poi tornare al 2 per la revisione dei timbri...
L’Impiegato numero 2, anche lui mi guarda come se fossi una ritardata mentale.
-Che strano... Beh, allora quando potró ritirarlo?
-Provi domattina presto, en la mañanita... -risponde l’Impiegato n.1. Adesso comincio a familiarizzarmi con questi diminutivi. Un mañanita é un domani nebulizzato fino all’evaporazione. Infatti passano varie mañanitas e sono ancora lí, sulle tracce di un pacchetto sempre piú inconsistente, e con scuse sempre piú volatili. Stanno controllando timbri e controtimbri, continuano a ripetermi. E io continuo a protestare: Ma insomma, quante storie…se non contiene uranio arricchito! Si tratta SOLO di due banalissime cassette di Listz, come devo dirvelo?
Ma poi, improvvisamente, ecco l’illuminazione. Anzi, che tonta, come ho fatto a non pensarci prima? I dis-funzionari dei tavoli 23, 24 e 82, tra i quali vai peregrinando una o mille volte, in cerca del tuo pacchetto, non te lo consegneranno MAI se non ti rivolgi a quei tizi appostati lá fuori, per sbrogliare le pratiche che i loro amici, all’interno, si danno da fare per imbrogliare. E te lo faranno a un prezzo assolutamente conveniente, señorita. Solo il doppio del valore delle due cassette. Comunque. Con questa logica dis-funzionale, si creano il doppio dei posti di lavoro. Así es mi Perú, prendere o lasciare.
Un giorno cerco un bus che va a Ica, un piccolo centro a 200 km a sud di Lima, una bella oasi in mezzo al deserto costiero. Ne vedo uno con una scritta sul vetro: “ICA”, che va in direzione della Panamericana Sud. Ottimo. Comunque, salendovi sopra, chiedo: “Questo bus va a Ica?” “Sí”, conferma l’autista. Pago il corrispondente biglietto, ma dopo solo un’ora di viaggio, il bus inverte la marcia e torna a Lima.
-Scusi, perché sta tornando indietro?- chiedo sorpresa all’autista- Non stavamo andando a Ica?
-Certo, ma questo bus lo devo riportare al garage dell’impresa alle 19 - e mi guarda come se fossi una ragazzetta un po’ ritardata.
-Ma almeno, dopo averlo riconsegnato puó ripartire per Ica?
-No, questo no, ma sicuramente ce n’é un altro. Ce ne sono tanti (sí, certo, magari con la scritta “Cajamarca”, per andare ad Arequipa, dall’altra parte del Perú).
Naturalmente, alla stazione dei bus, nemmeno l’ombra di qualcuno che va a Ica.
-Provi mañanita, signora: torni domattina prestissimo...-mi suggerisce un’impiegata.
- Grazie, lei é troppo gentile.- Senza ironia, davvero.
Altre volte, c´è meno da ridere.
Lima continua ad esser agitata da tumultuose manifestazioni, mentre i giornali riportano notizie allarmanti. La riforma agraria di Velasco Alvarado, con il suo sogno di abbondanza per i contadini allampanati, è risultata un fiasco. E´stata distribuita la terra, ma non l’abbondanza. Solo alcune cooperative hanno raggiunto una produzione soddisfacente. Cosí “il Cinese” viene destituito da un altro militare, Moralez Bermudez, che alleggerisce lo stato di migliaia di funzionari, per equilibrare il bilancio pubblico. La gente scende in strada a protestare. Si moltiplicano le manifestazioni. In questo panorama agitato, le elezioni presidenziali dell’’80 dovrebbero restituire una parvenza di democrazia al paese.
Nella sierra peró non arrivano i politici incravattati della capitale, e questo vuoto viene riempito dai seguaci del carismatico professore-profeta Abimael Guzman, sí, il marito di quella ragazza gentile, Augusta La Torre, con cui facevo lunghe passeggiate. Abimael ha giá aperto la diga della rivoluzione contro il marcio stato borghese, facendo bruciare le anfore elettorali in un paesino vicino ad Ayacucho, Chuschi, in spregio alla farsa delle elezioni.
A Lima intanto i suoi seguaci mandano un sinistro messaggio alle autoritá corrotte, impiccando dei cani e lasciandoli penzolare tristemente dai pali della luce. “Vi ammazzeremo come cani”. Lo stesso linguaggio usato dai maoisti nella rivoluzione cinese. (Senza contare il massacro di cani, ufficialmente organizzato, che decretó la fine della frustrata rivoluzione democratica di Praga del ‘68). . Nell’82, oltre alla torta di compleanno preparata dalla sua cara Augusta, Abimael Guzmán riceve un regalo veramente impressionante. Nel monte La Picota di Ayaucho vengono accese centinaia di torce di latta, come candeline di una torta, formando il disegno di una gigantesca falce e martello, mentre un coro di i voci inneggia alla rivoluzione. Siamo entrati, senza rendercene conto, nel decennio in cui scorreranno fiumi di sangue, il prezzo che deve pagare il paese per rinascere nuovo. Lo dice e lo comanda il Camarada Gonzalo, leader della rivoluzione peruviana, che un giorno, está cierto compañeros, se dará a conocer en todo el mundo.
Ma non avrei mai pensato che mi sarei trovata io, sporca gringa borghese, di fronte alle canne fredde dei loro fucili.
“Hai una missione importante, e hai perso molto tempo!”. Mi risuonano adesso nella mente queste parole. Me le sta dicendo, all’inizio della mia permanenza a Lima, una donna tranquilla, dai capelli castani, orecchini di fantasia, e un camice bianco. “Centro di Riflessologia”, dice il cartello sul muro di cinta di una delle tante case che danno su una strada dai marciapiedi pieni di gerani di Miraflores. Entro? Entro.
So vagamente che si tratta di un tipo di massaggio che, dicono, serve a ripulire i canali energetici che vanno da un punto determinato del piede a un determinato organo: il fegato, i reni, lo stomaco e cosí via. Lo praticavano anche gli antichi Egizi. Un po’ per volta, i massaggi rivitalizzano l’organo. Ma il mio problema é un altro: ci sará un modo, di ripulirmi l’organo che s’incarica di riempire le mie notti di sogni agitati? Oggi é una giornata di porte aperte, il centro di riflessologia dá trattamenti gratuiti alla gente, e solo con una mancia alle operatrici in camice bianco, puoi dare un’occhiata alle linee di energia che si incrociano dentro di te. Una di loro mi prende con soave decisione un piede e lo percorre con le sue dita, facendomi saltare dal dolore. E poi mi sorprende con le sue parole, nitide e serene:
-Si ripulisca l’aorta, signora. E´ piena di colesterolo e di rabbia. Metta un’enorme pietra incaica su quello che é successo con suo marito, e apra bene le finestre... Per questo é venuta qui, no?
Accidenti... come fa a conoscere, questa donna dal viso anonimo, i capelli corti e gli orecchini di plastica, i miei drammi segreti? Se è la prima volta che metto piede (é il caso di dirlo) in questo centro, e a Lima non ho nessuna amica che possa spifferare in giro i fatti miei.
-Scusi se entro nella sua vita, ma ho qualcosa d’importante da dirle - aggiunge, mentre si toglie il camice per uscire, e saluta un uomo che apre la porta per riceverla. –Peró, meglio che torni domani mattina, stasera é il nostro anniversario e mio marito é venuto a sequestrarmi...
Il giorno dopo, perché no? mi fiondo a conoscere questa strana donna.
Un donna normalissima, questa Sylvania, che piú normale non si puó. Taglia media, statura media, etá media, occhi marrone.
-D’accordo, ti daró del tu. Non devi pagarmi. Solo ogni tanto, mentre tocco i punti dolorosi delle persone, vedo qualche frammento del loro passato o del loro futuro. Di te, vedo che hai una missione importante, e hai perso giá abbastanza tempo!- mi ripete abbassando la voce.
- Vorrei Amore, non una Missione, -mi sento mormorare mentre due stupide lacrime mi spuntano negli occhi.
Torta alla crema, non al limone! protesta la Bimba al bancone del Destino. Altre lacrime spuntano dal fondo marino del mio essere. Tiepide e salate.
Perché non riesco a cancellare con una spugna, come vorrei, dalla lavagna scarabocchiata della mia anima questo gomitolo arruffato a pesante di (una tonnellata di) venti anni di ricordi? Quante volte, di notte, guardo il cielo senza stelle di Lima, che la nebbia colora di un rosa giallognolo emanato dai fari di viali e fabbriche. Un triste cielo color Toyota.
E poi dormo facendo sogni piú intricati delle composizioni celesti della cappella Sistina. Tra le quattrocento figure di angeli e profeti muscolosi della cappella mi appare ossessiva la faccia di Markus, con indosso i pantaloni, ma a dorso nudo. Oppure al contrario, con giacca di smoking, cappello duro da finanziere, e giú, niente. O meglio, i suoi orgogliosi e apprezzatissimi attributi virili. Piú bello e seduttore che mai, ma con gli occhi rossi di un diavolo. In un sogno addirittura assume la faccia del dio severo che dá la mano ad Adamo, ma é lui stesso Adamo, un Adamo-Markus al quadrato, che dá la mano a stesso, creandosi e perdonandosi. Un mondo a misura d’uomo. E vedo Amadeus, in un angolo della scena, a suonare il flauto come un dio greco, regalando musica a questi maschi complicati.
Eva dov’é? In un sogno é sparita, ma in un altro eccola arrivare, con la mela e un serpente avvolto nel corpo, al lato di Judith che agita come una bandiera la testa di Oloferne. Arrivano anche la Vergine con una corona di stelle e una borsa per la spesa, Salomé che lascia cadere, danzando, un velo dopo l’altro; Sara e l’anziana Elizabeth che tengono per mano la piccola Anna, e la moglie di Seth, giá diventata una statua di sale, ma con un permesso speciale per le manifestazioni... e tutte gridano alzando le mani: IO SONO MIA! Come le femministe della Kaiserstrasse.
Peggio ancora se mi giungono da Berlino notizie che preferirei non avere. Come quella che adesso Markus sta vivendo con una donna che non conosco. Quando lo vengo a sapere, ho una reazione strana. Si alternano giorni di calma con altri in cui un missile nucleare sarebbe troppo poco per incendiare la casa dove l’ex uomo del mio Destino vive con la (momentanea?duratura? ) donna dei suoi sogni. Certo, siamo separati, é suo diritto, no? E a me che me ne viene, se alla fine, e alleluia, ci siamo separati? A me che m’importa se é finito con Marlene, o Gredna, o Francine? Per me é lo stesso. Lo stesso orrore. Anche se non gli sará facile trovare la donna perfetta per lui, come ha osservato il dottor Weber ... perché per vivere ha bisogno di una mescolanza di Marianna, con piattini deliziosi e fiori sul tavolo, piú Margrit (la tappabuchi-tuttofare), la amante liberale per definizione. Un’equazione impossibile fra profumo di fiori e crepes flambant, e vagine insaziabili. Un po’ di questo tipo:
Xy Marianna+ Margrit+ (Francine al quadrato-42 xy Flor)
Magnolia x 4
Vorrei cancellare tutto con un solo gesto, zac e zac, e dormire sonni limpidi, senza dei paranoici.
- Non ti spaventare…il tuo dramma si sta processando e diluendo. Avrai tutto l’amore di cui hai bisogno…- Sylvania adesso mi accarezza una mano, mentre il mio stomaco si rilassa in una sensazione magnifica di calore. Sí, sento che posso fidarmi di lei.
-Ma non sará quello di tuo marito. Lui continuerá irretito nelle sue storie... ha terrore a star solo. In questa situazione di debolezza, non sa distinguere chi lo puó amare o semplicemente ammaliare, anche se apparentemente é lui il conquistatore... Ho l’impressione che cadrá in mano a una donna astuta e... Non fare quella faccia, non voglio spaventarti. Beh, mi posso sbagliare, sai? Sará la vita a dirlo. Ma su di te non mi sbaglio, sono sicura! Tu hai una stella nel palmo della mano, negli occhi, nella fronte.
-Di che stella parli, benedetta donna?
-La tua missione. (E dagli con questa missione, non la voglio e non la voglio, avete capito? Scalcia la Bimba)
...La scoprirai un po’ per volta, giorno per giorno. E quando ti sembrerá di averla piú chiara, apri questo foglietto, e leggi quello che adesso ci scrivo, promesso? Non prima!
Foglietto chiuso fra i miei quaderni, con Missione Sconosciuta dentro. O Impossibile?
Dove sará finito questo foglietto? Naturalmente, lo persi subito. Se potessi stare con me, adesso, Sylvania, col tuo sguardo tranquillo, e quelle mani fresche e decise. Forse tu sapresti vedere al di lá di questi sguardi duri, che mi squadrano senza vedermi. Tu forse, sapresti vedere cosa mi aspetta.
Chiudo gli occhi di nuovo e mi perdo nella visione dei paesaggi immensi dell’altopiano di Puno. Navigo nella loro vastità, lasciando che la mia anima respiri e si plachi.
Ho terminato il corso di quechua a Lima, e mi sono trasferita a Puno, per iniziare a lavorare come formatrice nel progetto educativo diretto ai bambini quechua e aimara dell’altipiano. Lá dove volano i condor.
In questa piccola cittá dalle costruzioni anonime, appiccicate l’una all’altra come scatole di sardine, il lago e l’altopiano fanno da contrappeso ai limiti architettonici con la loro grandiosa bellezza. Non mi stanco mai di contemplare i paesaggi immensi di quelle altezze. Valli con grandi greggi di alpaca e lama, che si muovono leggeri sul duro velluto dell’icchu. E in fondo, in fondo, un pastorello che sembra scendere dalle nubi, in un’alba dalle dita di rosa. Saranno stati cosí gli inizi del mondo? Vengono a scuola i bambini dell’altopiano: sono allegri e vivaci, con le guance rosse, gli occhi neri brillanti, le labbra a volte screpolate dal freddo, i chullos colorati. Ma il metodo d’insegnamento che vi si applica tarpa poco a poco la loro creatività, rendendoli passivi e dipendenti.
Se il primo anno che entrano alla scuola, gli fai descrivere il loro ambiente, i bimbi fanno disegni pieni di dettagli come cagnetti che saltano, galline perseguitate dalla volpe, addirittura la tomba della nonna, sotto un immancabile sole pieno di raggi. Prova a fargli fare un disegno libero, dopo quattro anni di scuola, e la maggioranza disegnerá una bandiera o un mazzo di fiori, ugualmente scialbi. Che conoscano trenta colori di granoturco o sappiano orientarsi da soli, in mezzo a montagne imponenti, alla scuola non importa. Gli cancella il sapere tradizionale, senza peró sostituirlo con le conoscenze necessarie a farli sentire cittadini di una patria piú grande.
Mi vedo in decine di riunioni a vari livelli, col ministro e funzionari ministeriali, e poi con professori e genitori, per disegnare con loro un’educazione che si possa dir tale, e quindi non autoritaria, ripetitiva, noiosa, ma centrata sul bambino e sulla comunitá, aperta e creativa. É un’impresa titanica, come si puó immaginare, una vera rivoluzione educativa. I funzionari ministeriali e i professori, salvo eccezioni, ci guardano di traverso. Sono matti da legare, questi gringos, gli leggiamo negli occhi. Vengono con il denaro dei progetti, e credono di poterci comandare? E qualcuno sbotta: “Perché tanti soldi per educare quattro indios? Perché piuttosto, non usarli per cercare oro? Nel Madre de Dios ci sono certi angoli dove...”
Dobbiamo fare un passo indietro, allora. Ragioniamo un momento sui pregiudizi razziali.
-Da quando e perché gli indios sono stati considerati inferiori, per favorire chi?
-Chi, noi razzisti? Sono loro, primitivi.
-Che significa per voi, “primitivi”? Si sta parlando del piano emozionale, tecnologico, o sociale?
Continuiamo col ragionamento. Vengono turisti dall’Australia o dal Canadá, per visitare il Perú, che ha una varietá incredibile di paesaggi ed ecosistemi, tra i piú diversi del mondo. Una riserva di semi e genomi per tutto il pianeta. Chi ha raccolto, utilizzato, selezionato nei tempi dei tempi questi semi? Chi ha sperimentato con pazienza con loro, scoprendo le qualità curative o alimentari delle piante?
I 43 o 46 popoli nativi che sono sopravvissuti finora in Perú, mantenendo una lingua propria, hanno imparato a “addomesticare” non solo piante e animali, ma anche paesaggi scoscesi, costruendo ingegnose terrazze e sistemi di irrigazione nelle terre alte. In Amazzonia, sono riusciti a solcare fiumi limacciosi, a cacciare la scarsa selvaggina in modo da non decimarla, e piantare orti in terreni acidi, spostando le coltivazioni quando non producevano piú.
Gli andini hanno costruito un impero teocratico basato su classi differenziate, mentre fra gli amazzonici ha piú potere il saggio, o quello che sa donare. Questi ultimi hanno organizzato la loro vita in modo che nessuno soffra la fame, rispettando l’ambiente, e hanno utilizzato il superfluo per grandi feste dove si rafforza lo spirito di gruppo, senza necessitá di dover organizzarsi in uno stato.
Come ogni altro gruppo umano del pianeta, hanno elaborato miti e sistemi di credenze a volte molto complessi, per spiegare la vita e la morte, ma sono stati sistematicamente ignorati dai governi dei bianchi o meticci, che hanno preferito ridurli a “feroci selvaggi”, per usarli come bestie da soma.
Pensate che uno chiunque di noi, nato in cittá, saprebbe pascolare in queste montagne solitarie, animali cinque o dieci volte piú grandi di noi, come fanno a cinque anni i bambini dell’altipiano con le vacche e gli alpaca? Sapremmo destreggiarci fra i mulinelli, in una fragile canoa, come sanno fare i piccoli amazzonici? No, non ce la faremmo. Beh, allora perché non proviamo a scambiare con loro le diverse conoscenze e abilità, imparando dai popoli originari quello che hanno di piú valido nella loro maniera di utilizzare l’ambiente, mentre noi possiamo trasmettergli ció che possa essergli utile, fra i ritrovati scientifici e tecnologici della cultura occidentale, per arricchirci mutuamente?
Utopia? Puó darsi. So che per realizzarla non basteranno una, o due, o venti riunioni. I cambiamenti della mentalità collettiva richiedono anni, mi dico a volte per non abbattermi. O ere geologiche.
Ma almeno i genitori saranno contenti, si potrá pensare, che ci si sfianchi per i loro bambini. Macché.
Tutti questi giochini, e semini, e bastoncini, per imparare i numeri, non sono una perdita di tempo? I bambini devono imparare a scrivere e poi a lavorare, altro che balle. Con qualche bella frustata, se necessario. La letra con la sangre entra, giá.
Mi verrebbe voglia di alzarmi e dirgli : SVEGLIA!! Non vi rendete conto che per secoli vi hanno insegnato ad abbassare la testa (buenos dias papacito, buenos dias mamacita) per dominarvi meglio, fin dalla Colonia? E a ricevere bastonate, anche in una scuola che dovrá insegnarvi tutto meno che a pensare, e inventare qualcosa di diverso ... E poi, alla fine di una vita di miseria, ecco che vi sventolano davanti la promessa del paradiso: tanto. il cielo é gratis. Ma finché siete in terra, dannati siete e dannati resterete… (Amadeus, ricordi i nostri discorsi?).
Peró non devo scaldarmi, ovviamente, e subissare quei poveri genitori di idee sovversive.. Devo essere diplomatica e persuasiva.
Finché un giorno mi sveglio con due occhiaie profonde da far paura, e decido di gettare la spugna… Mi sto dissanguando io, a furia di spiegare che non si educa col sangue delle frustate. Mi dimetto e via. Fatto. Prendo la mia borsa e vado ad avvisarli che li lascerò al loro destino, quegli andini dalla testa dura. Ci provi qualcun altro, con loro. Ma mi aspetta una sorpresa. Mi accoglie con un sorriso fino alle orecchie la signora Ersilia, presidente del Club de Madres, che all’inizio mi guardava di traverso. Adesso invece mi viene incontro con una padella annerita... un uovo fritto! E dove ha trovato quest’uovo, con le galline decimate dalla volpe, e l’olio carissimo? Mi chiedo.
-Lei non si preoccupi, e mangi. L’ho vista un po’ giú, ultimamente.
Un uovo fritto in quest’altipiano spazzato dai venti! É come mangiare aragoste e champagne in Germania. Restituisco il tegame brillante, e abbraccio Ersilia. Coraggio e avanti, hasta siempre.
Sono libera come un fringuello. Per la prima volta nella mia vita, non ho nessuno che mi aspetti a tavola, o chi aspettare a tavola, o che si aspetti che gli prepari la tavola, o che mi prepari la tavola. Neanche uno Zambo che mi accolga scodinzolando. Sará bene o male? Non posso far altro che sperimentarlo, e giá che ci sono, approfittare dell’occasione. Per esempio, posso rendermi disponibile per i viaggi stronca-cavallo, rifiutati dai colleghi sposati, a visitare le comunitá piú sperdute della puna, per coinvolgerle nel progetto educativo. Sempre con quella pazza idea di dare un’educazione dignitosa agli ultimi degli ultimi. E se per strada ti trovi bloccata da un incidente, come un buon boccone per gli avvoltoi?
Ogni viaggio comincia caricando la mia Volswagen bianca con un sacchetto di carne secca e patate disidratate, piú una provvista di tonno in scatola e crakers, sempre apprezzati come leccornie dagli abitanti di questi paralleli sperduti. Ha bisogno di un nome, la mia preziosa Volkswagen, dato che passeremo moltissimo tempo insieme: la chiamerò Olivia von Batten, mi suona bene! La mantengo in condizioni perfette, sempre con l’olio, l’acqua, la pressione delle ruote, e i freni nel giusto punto. Olivia mi corrisponde con l’immediata accensione del motore, anche se piove o tuona, sta gelando o c´è siccità. Cosí va bene, Olivia, sempre avanti, mi raccomando, senza piantarmi in asso in mezzo all’estero, o in fondo al mondo, dove nascono le nubi.
A volte sola, a volte in compagnia di qualche taciturno maestro, m’immetto in una di queste strade polverose e infinite, che tagliano in due un altipiano schiacciato dal cielo. E poi costeggiano pascoli giallognoli di erba ruvida, lambendo lagune verdi, tra voli di anatre selvatiche, per arrivare lá in fondo, in fondo, dove comincia o termina l’orizzonte dell’altopiano, e si apre una corona di montagne possenti, dai ghiacciai scintillanti di neve.
Lá in alto, continuo a salire fino alla zona dove si allevano le alpache, a Macusani, a 4500 metri sul livello del mare. E ancora piú in alto, devo attraversare un passo a 5000 metri, col respiro piú corto, per poi cominciare finalmente la discesa verso la selva: la selva immensa del Madre de Dios, il fiume detto anche Amaru Mayo, (“Grande serpente” in quechua), dove Mayo é lo spirito del fiume. Terra di coca e oro, che ha alimentato per secoli il sogno del Paititi e l’Eldorado, Madre de Dios é finora, e per poco ancora, una delle regioni piú intatte del Perú, quasi spopolata, perché le terre coltivabili sono scarsissime.
L’oro che finisce nella rena di questi fiumi viene giú dalle cordigliere, trasformato in polvere, lamine o pepite da milioni di anni di erosione. Milioni di anni silenziosi, finché negli anni Settanta l’aumento del prezzo internazionale dell’oro ha richiamato da ogni dove gente fornita solo di un setaccio e una carretta o di potenti motopompe, intenzionata a estrarre dal fiume tutte le pepite che nasconde. Ma dove finiranno le grandi ricchezze provenienti dalla loro vendita? penso guardando sgomenta un accampamento montato alla bell’e meglio sulle rive, con quattro pali: un tavolato come pavimento, un tetto di foglie di palma e un telo di plastica azzurra in caso di piogge.
Vedo ragazze che preparano da mangiare, in grandi pentoloni, per i ragazzi che stanno lavando la rena con setacci artigianali. Spetta a loro raccogliere legna, lavare, e a volte badare ai bambini nati dalle precarie unioni che si consumano fra le canne, nel frinire dei grilli e il gracidare delle rane.
I ragazzi sono contrattati a Cuzco per lavorare nella stagione secca, come figliocci di padrini, familiari o conoscenti giá occupati nella ricerca dell’oro, secondo la tradizione andina. Sono arrivati dalla cittá in camion, (tre giorni di discesa) con viaggio pagato. Per caricare ed estrarre la polvere d’oro da cento carrettate quotidiane di rena, fra zanzare e sanguisughe, ricevono, se tutto va bene, il salario di un dollaro al giorno. Per diventare ricchi, c´é la domenica, (avanti signori!, oggi avete tutto il fiume per scovare per conto proprio la pepita del secolo!). E se li coglie la febbre tifoidea, il dengue emorragico, o li morde un serpente? Semplicemente, muoiono. E vengono sepolti in fretta in fosse comuni.
-Quanti morti? Macché, tutte invenzioni signora…-Il lavoro minorile é proibito? Certo, ma qui non ne abbiamo - mi sento rispondere dappertutto.
Nessuna impresa artigianale che lava poche carrettate di rena al giorno, segue la norma di registrare il terreno che sfrutta, meno che meno lo fanno le imprese grandi che sbancano fondali di chilometri e chilometri di fiume, senza pagare un centesimo di tasse, in questa terra de Dios che pare fuori dalle leggi degli uomini. Ogni tanto arrivano dei giornalisti, a fare un polverone sul caso delle fosse comuni dove vengono seppelliti i piú sfortunati ragazzini cercatori d’oro, ah, e anche sul tema del mercurio che viene utilizzato nell’estrazione del prezioso metallo, e finisce nel fiume, e quindi nei pesci, e quindi nella catena alimentare.... Com´è possibile permettere questa infamia? Sí sí, prenderemo provvedimenti, come no, rispondono le fantomatiche autoritá, e tutto resta uguale.
Un maestro della zona, Miguel, mi supplica di inserire quei ragazzi nel progetto, ma io posso solo promettere di cercare di trattare di provare a vedere se riesco a interessare le improbabili autoritá di Puno: quelle che se ci sono, nessuno le ha viste.
Me ne vado con una stretta al cuore.
-Ti hanno avvisato se possiamo andare a Boca Inambari?- chiedo a un certo punto a Hernán il motorista, un silenzioso arakmbut che conosce tutti i mulinelli della zona.
Il sole sta tramontando sul Madre de Dios, inondando il cielo di arancio e viola. Il vento fresco della sera mi accarezza le tempie. Dalla riva vedo alzarsi stridendo uno stormo di guacamayos. Eccoli, i principi del fiume, in uno sfoggio di colore e vita: i pappagalli sognati da mia nonna Elisa. Contemplo il loro volo come un regalo, sollevata. M’invitano di nuovo a guardare in alto. Perché gli uomini sono creature cosí pesanti da distruggere tutto dove passano, e trasformare i sogni in incubo? Si potrá, una buona volta, trasformare gli incubi in sogno?
Ci troviamo giusto nel territorio dei “sognatori”, quegli Arakmbut che avevo studiato sugli ordinati banchi di Berlino e che mi avevano affascinato con la loro storia peculiare. Muoio dalla voglia di conoscerli, anche se il mio piano di lavoro non lo prevede. E adesso sono cosí vicini, che posso immaginarli camminando dentro la linea scura della vegetazione costiera, mentre il disco del sole scende all’orizzonte, incendiando con la sua luce sovrana l’acqua del fiume.
-Sí, ci permettono di entrare, ma dobbiamo comprare la benzina…
Giorni fa, avevo chiesto il permesso alla comunitá indigena di Bocca Inambari, di sostare da loro, attraverso un tecnico forestale che andava da quelle parti, e me lo avevano concesso. E adesso, dovevo comprare due galloni di benzina piú uno di olio per motori, se volevamo arrivare fino a lá. Qui la benzina è piú cara che in cittá. Ho il denaro sufficiente per questo viaggio, dando anche un giusto compenso a Hernán, il motorista? Guardo nella borsetta di tela che porto nascosta alla cintura, con i biglietti di riserva per le possibili e frequentissime emergenze. Uno, due, tre, quattro. Mostro a Hernán i quattro biglietti ripiegati. Bastano?
-Appena appena, andando piano per non consumare troppa benzina. - E al ritorno, se succede qualcosa, arrangiati Marianna, mi dico. Vuoi rischiare lo stesso? Sí. Adesso non é il momento dei Ragionieri, ma dei Sognatori.
-Allora andiamo.
Hernán gira la barca verso il disco del sole, quasi scomparso dietro le nubi. Io chiudo gli occhi, per danzare felice sulla loro spuma.
-Dove passiamo la notte? No, qui meglio di no- mi avvisa Hernán, guardando le luci che tremolano nell’acqua scura del fiume.
Boca Colorado non é un posto per signore (dalla frangetta perfetta) mi spiega, misurandomi con un’occhiata. Ah giá. Mi rendo conto che questo villaggetto squallido costruito dai cercatori d’oro andini, con baracche di legno e bar chiassosi, dove corrono fiumi di birra e volano insulti e coltellate, non é il massimo per chi ha voglia di farsi una buona dormita. Meglio accampare su una spiaggia, per stare alla larga dai ladri e sperare in una notte tranquilla. E se comunque dovessero venire fino a qua... macché, perché poi dovrebbero venire fino a qua, a prendersi i nostri quattro biglietti stropicciati? E quindi coraggio, dobbiamo metter su la tenda su quella spiaggia senza luna, in una notte senza luna, e soprattutto, speriamo, senza intrusi.
Hernán spinge la barca in un pantano di canne, dove so che a quest’ora sonnecchiano i coccodrilli, e poi scende nell’acqua, trascinandosela a riva. Anch’io scendo dietro di lui, nell’acqua fangosa e tiepida.
-Shhh, passi di qua - mi dice facendomi strada fra le canne.
Io spero vivamente di non disturbare nessun abitante del fiume. Dormite bene, coccodrillini.
-Lei qui, non spengere fuoco -mi ordina nel suo linguaggio approssimativo, tradotto dalla lingua arakmbut, ordinandomi di tenere sempre acceso il fuoco, per tenere lontani gli animali. Soprattutto lo splendido otorongo, il giaguaro, che durante la stagione secca vaga di notte per le spiagge cercando le uova saporite della taricaya, la tartaruga del fiume.
-Vado a fare un giro- mi avvisa prendendo il suo machete. -Lei qui badare al fuoco, d’accordo?- mi ripete.
Ed io resto sola sotto quel tetto di stelle, in compagnia dei barbagli del fuoco. Fuoco, stelle, vento, terra. Vento, stelle, lampi. Occorrono altri rami per tener viva la fiamma. Devo andare in cerca di qualche arbusto. Cammino a piedi nudi sulla sabbia, sabbia, fresco, piedi, gioia. Nell’aria, arrivano da lontano frammenti di note, scollegate dalla loro armonia. Salsa, onde, canto, notte. Ancora lampi.
Faccio scorrere un momento un po’ di sabbia fra le dita. La sabbia di una terra indomita, definita dagli spagnoli “tomba degli esploratori”. E che, ancor prima di loro, aveva respinto gli Inca. Una nube di frecce aveva accolto diecimila soldati del Tahuantinsuyo, inviati nelle terre dei chunchos selvaggi, costringendoli a ritirarsi. Le piantagioni di coca e cacao poterono crescere piú in lá, ma il bacino del Madre de Dios rimase ai suoi fieri abitanti. Seguirono secoli di silenzio, finché qualcuno arrivó in quelle foreste, a sconvolgere la loro vita.
Mi stendo sulla rena pensando. Non è molto lontano da qui, Fitzcarrald. Un sentiero di pochi chilometri tra due fiumi, che lo stravagante barone del caucciú, famoso per navigare nei fiumi amazzonici ascoltando musica lirica nel suo moderno grammofono a tromba, si mise in testa di utilizzare per accorciare la lunga rotta fluviale che trasportava il caucciú fra Perú e Bolivia.
Immagino lo stupore degli indios a suo servizio, quando gli ordinò di trasportare
….i sacchi di latex in spalla? No! Stavolta dovete trasportare lungo il vado LA MOTONAVE, avete capito bene fannulloni? spingendo spingendo, ooooooooo-hhhhh, oooooooooooohhhhh, sudando, sudando. Carlos Fermín Fitzcarrald, quando vide la motonave toccare l’altra riva, si sentí forse in quel momento padrone del mondo. Ma qualcuna di quelle fastidiose tribú dalla pelle di bronzo che pullulavano in zona, (i Toyeri, della famiglia Harakmbut), si oppose al passaggio della modernitá sul suo suolo. E fu il massacro. Duemila corpi finirono a galleggiare sull’acqua, ondeggiando fra canne e ninfee. Il fiume divenne una cloaca pestilente, ricordano i viaggiatori dell’epoca. Dei duemila Toyeri rimasero solo due o tre famiglie. Per ricordare l’impresa, fu costruito un monumento a Porto Maldonado: dedicato a Fizcarrald, no ai Toyeri.
Adesso, negli anni settanta-ottanta, erano rimasti poco più di mille, milleduecento persone tra i vari popoli della famiglia linguistica Harakmbut, delle 14mila che la componevano all’inizio del secolo: i Sapiteri, dal monte Sapite, gli Huachipaeri, o costruttori di ponti sospesi, gli Amarakaeri o Arakmbut, “la vera gente”. Perché dopo, a metà del secolo, erano arrivati altri stranieri a sterminarli. Stavolta, con le migliori intenzioni.
In questo momento, tra meticci e indigeni, si contano poco più di sessantamila anime, a popolare l’immenso dipartimento. Lo stato peruviano è riuscito a porre la bandiera biancorossa a Porto Maldonado, un piccolo centro dalle case di legno al puro stile Far West, solo nei primi anni del ´900, per dare una qualche formalità allo sfruttamento del legname e della castagna. Gli emigranti andini che scendono dalle montagne a inventarsi la vita in queste terre solitarie e magiche, diboscano rive e pendici come cavallette impazzite, per piantare un po’ di riso e di granturco E i fiumi s’infuriano sempre piú, quando si gonfiano di piogge. Le notti stellate hanno cominciato a riempirsi di musica stridente. Ed io mi trovo adesso in questo fiume, a metà fra un passato di stelle e un presente di plastica.
Il vento mi trae, adesso, il rumore di un motore. Sembra che proceda lentamente, come per cercare di passare inosservato. La luce di una pila esplora fra le canne, avvicinandosi.
Hernán, Hernán! penso o grido, non so. Dove si è cacciato quel benedett’uomo?
SSshhh, mi sussurra materializzandosi al mio fianco, come dal nulla, mentre punta con decisione il fucile verso la barca che avanza nel canneto. Più vicina, ahii, sempre più vicina…
-Un bastone!- Mi ordina Hernán, a voce bassa. Dalla catasta di legna vicina al fuoco afferro un ramo, ma … con orrore sento che la mia mano non sta stringendo un legno…è qualcosa di piú ruvido e freddo: la pelle di un coccodrillooooo!!!! Soffocando un altro grido, mollo il coccodrillo, sotto lo sguardo leggermente beffardo di Héctor. L’animale è piccolo e inoffensivo, (non vedi?), l’ho stordito io con un colpo preciso.
-Il bastone, tenerlo così- mi consiglia indicandomi l’altezza giusta in cui lo devo brandire, e poi guarda tranquillo la barca che si avvicina. Al suo fianco, stringendo il bastone, Marianna Weiser guerriera della notte.
-Tutto bene signora? -mi grida uno dei tre uomini che scende dalla barca.
-Tutto bene, -confermo con la voce più tranquilla e decisa che posso, alzando il bastone. Il fucile di Héctor prende la mira.
-Ah, se però non è abbastanza comoda sulla spiaggia, può venire ad alloggiarsi a Boca Colorado: abbiamo i migliori hotel di tutto il fiume…
Ma guarda! Sono arrivati in tre, preoccupandosi della mia comodità, per augurarmi la buona notte? Sappi che ti teniamo d’occhio, gringa. Per adesso solo un’occhiata, visto che sei con uno di quei fottuti guerrieri. Ma se ti distrai un attimo… ci vedrai di nuovo, carina. E butta giù quel ridicolo bastone, vuoi farci ridere? Saresti davvero capace di darcelo in testa? Sento questo messaggio scivolare tra le parole.
Ah sì? Credi che l’abbia preso per fare ginnastica artistica? Sono capace eccome di dartelo in testa, a te e a quegli stronzi che hai vicino, sai. Di Marianne ce ne sono molte dentro di me, e non ti conviene provocare quella piú selvaggia: resteresti sorpreso, idiota, nel vedere come mi posso difendere, se lo voglio, con o senza Hernán. IO.
E intanto dico: Grazie, siamo qui solo di passaggio. Stiamo solo raccogliendo qualche uovo di tartaruga, e domani saremo a Bocca Inambari.
-Allora buona notte, alla prossima.
-Buona notte,- a non rivederci. La barca gira e il suo monotono tu tu tu del motore si allontana nel buio, scomparendo fra i lampi.
Ed eccoci finalmente a Boca Inambari, sotto un grande albero frondoso che da centinaia di anni guarda scorrere il fiume. Nel cielo stanno spuntando le prime stelle. Mi accoccolo sul prato, respirando la brezza della sera, ad ascoltare i racconti degli anziani. Ho mille domande da fargli. La prima: Cosa significa Arakmbut?
“Noi, gli esseri umani”, mi viene risposto. Ossia, i “veri Uomini e vere Donne”. Cosí si definiscono gli Arakmbut, come la maggioranza dei popoli indigeni originari dell’Amazzonia. Su ció che significa per loro questa espressione, gli antropologi si affannano e scrivere libri, sconcertati (gli antropologi e gli Arakmbut) sui cambiamenti che hanno coinvolti i “Veri Uomini” negli ultimi decenni, quando sono stati obbligati a percorrere a velocità supersonica il tunnel della modernità e trovarsi catapultati dall’infelice (o felice?) età della Pietra, alla felice (o infelice?) Era delle Comunicazioni. A partire dal giorno del Gran Gallinaccio.
Ho la fortuna di ascoltare dalla loro viva voce, in questa notte senza luna, cosa provarono Sueyo e Bayacope in quella giornata di sole di quarant’anni fa, quando videro nel loro cielo arrivare un gigantesco uccello sconosciuto. Erano due giovani cacciatori, dal corpo agile e muscoloso, completamente nudo com’era la loro usanza, ma decorato dalle pitture di caccia. I capelli lunghi e neri li portavano raccolti in una coda. Adesso sono due vigorosi anziani che indossano una maglietta con la scritta “Arizona” e “Università del Pacifico”.
Mi appoggio all’albero in una posizione comoda, per non perdermi una parola di questa storia affascinante. Perché non si sentono tutti i giorni, sotto le nostre stelle pallide, storie di “gente vera”. Ancor piú se uno di loro, Bayacope, per i suoi muscoli agili, viene chiamato ancora Tarzan. Il Tarzan di una selva esuberante e viva, non di cartone come nei set cinematografici.
Héctor, il figlio di Sueyo, fará da traduttore.
“Vivevamo su una grande collina, piena di scimmie, pernici, guacamayos, maiali selvatici, prima del giorno del Grande Gallinaccio”, comincia a raccontare Bayacope, alias “Tarzan”.
“Dicevano i nostri nonni che i popoli della famiglia Harakmbut discendono da un grande albero frondoso, il Huanamey. Sui suoi rami si rifugiarono uomini e animali quando, all’inizio del tempo, una tremenda pioggia di fuoco distrusse la terra. Huanamey significa per questo: “quello che salvò l’umanità”. Riapparirà, con i suoi magnifici rami, alla fine dei tempi. Questo é quel che crediamo.
Noi, gli Esseri Umani, gli Arakmbut, eravamo molti, almeno tremila persone, prima del giorno del Gran Gallinaccio. Adornavamo i nostri corpi nudi con tatuaggi e con l’oro del fiume Irishive: sulla testa portavamo, come re, le nostre corone di piume colorate di guacamayos. Aprivamo la selva piú dura con le nostre asce di pietra, e cacciavamo con le nostre frecce di canna, con punte di osso di scimmia. Vivevamo in grandi capanne collettive chiamate malocas, dove potevano stare anche quindici famiglie, ognuna delle quali aveva il suo tavolato e il suo focolare. Lo spazio comune era per ballare.
Non avevamo canoe. Quando dovevamo attraversare un fiume, lo facevamo a nuoto. Non eravamo taccagni. Se qualcuno catturava un animale, ne dava un po’ anche ai cacciatori meno fortunati, che ricambiavano quando lui stesso tornava a mani vuote, così nessuno restava mai a digiuno. La selvaggina la cucinavamo in grandi pentole di argilla che rendevano la carne molto tenera e saporita. E poi, fra il bosco e il campo (la chacra) tenuta dalle donne, avevamo alimenti in abbondanza, yuca, poroto, pijuayo, banane e altri frutti. Di tanto in tanto chiudevamo il braccio di un piccolo affluente e vi ponevamo le radici velenose del barbasco, per addormentare i pesci e catturarne grandi quantitá, in vista di qualche festa. Tutte le notti cantavamo, inventando canzoni di caccia o d’amore, rilassandoci e stimolandoci con tabacco e foglie di coca.
I sogni? Sí, sono sempre stati importanti per noi, e cercavamo di interpretarli, con l’aiuto di un saggio che appunto, chiamavamo il Sognatore, perché aveva imparato a decifrarne il linguaggio. Come poteva sapere se possedeva davvero questa facoltá? In genere, perché da piccolo aveva sentito che un animale selvatico lo seguiva, e con un linguaggio speciale lo istruiva perché un giorno potesse curare gli altri, o con l’aiuto delle visioni prodotte dal toè, (una pianta allucinogena), o soltanto con canti di cura. Ogni malattia può essere causata da spiriti diversi, ed esistono i canti giusti per curarli. Gli spiriti benevoli, come le anime degli antenati, ti possono consigliare in sogno dove é possibile trovare oro, o selvaggina, o dove é meglio aprire un orto. Gli spiriti maligni invece entrano in azione quando hai cacciato in eccesso, per esempio, o commesso un incesto, e ti fanno capovolgere la canoa, o mordere da un serpente. Le nostre regole sono chiare: condividere quello che abbiamo senza meschinitá, uccidere altri esseri umani solo per difesa, e gli animali solo il necessario per nutrirci.
Quali i nostri migliori ricordi? Senza dubbio, l’impressionante festa dell’iniziazione maschile, o Huambokerek, quando i ragazzi diventavano uomini e potevano dimostrare la loro abilitá nella caccia. La festa richiedeva giorni e giorni di preparazione, e l’ingestione di piante maestre, come il toé, che ti rafforzavano e chiarivano il tuo scopo nella vita. E finalmente il giorno in cui tutto era pronto, cominciava a riunirsi la gente, come oggi per un concerto, ma i protagonisti eravamo noi. Con il nostro spettacolo, cercavamo soprattutto di impressionare le belle donne che ci circondavano, con danze e canti che imitavano l’animale che cacciavamo con piú frequenza.
Il mio era il guacamayo. Per questo avevo indossato un ornamento di grandi piume di questo magnifico volatile, che andava dalla cintura alla spalla, come spettacolari ali d’angelo. Se fece effetto? Sí, una ragazza osservó ammirata la mia danza, e io a lei. Come le altre donne, mentre noi uomini portavamo i capelli lunghi, o legati in una coda, lei aveva invece i capelli corti e la frangetta. Sulle braccia e sui seni aveva tatuati bellissimi disegni tracciati con l’huito, (un seme che colora di nero), e portava una gonnella fatta di corteccia d’albero, pestata fino a diventare sottile come una tela (la llanchama). Mi parve speciale, quella ragazza, fin dalla prima occhiata. E quindi lavorai qualche tempo per i genitori, per dimostrarle che ero un uomo responsabile, finché potei sposarla. E come i guacamayos, siamo stati uniti fino alla sua morte.
Ragazzi e ragazze dovevano arrivare vergini al matrimonio. Le madri fasciavano i piccolissimi con grandi foglie di bijau, e li portavano sulla schiena in una culla, con una base rigida di legno, perché crescessero ben dritti. Adesso diciamo che quelli che sono cresciuti “dritti” ossia hanno passato del tempo in quelle rigide culle, sono piú forti e si sanno destreggiare meglio nella vita. Guarda per esempio Pembuyo, la madre del mio amico Sueyo, che continua a camminare e lavorare nell’orto, come se niente fosse.
Ogni tanto facevamo guerra con i vicini, sí, i Toyeri o gli Hauchipaeri che vivevano fuori del nostro territorio. Perché? Per qualche contrasto, per invidia, o per provare la nostra forza. Gli attacchi erano notturni: chi vinceva si portava via i bambini, che tutti lasciavano vivi.
Adesso non facciamo piú guerre a colpi di frecce, ma non abbiamo pace, per le continue invasioni di cercatori d’oro e di tagliatori di legname, che ci vogliono buttar fuori dal nostro territorio. Tutto é cambiato da quel giorno fatidico, il giorno del Gran Gallinaccio.
Ah, il Gran Gallinaccio! Un gruppo di bambini viene a sedersi sotto l’albero, per ascoltare il vecchio Tarzan e Sueyo che raccontano quella storia famosa. Forse la conoscono giá, ma ogni volta che viene revocata compaiono nuovi dettagli. Una bimba si arrampica agilmente tra un ramo e l’altro, col suo coltello alla cintura. Dal suo orto lontano qualche chilometro dalla comunitá, arriva anche la mamma di Sueyo, Pembuyo-Enriqueta, caricando yuca per gli ospiti, col suo inseparabile machete in mano. Ha una frangetta perfetta su un casco di giovanili capelli neri, e mi rivolge un sorriso allegro di ragazza, anche se i denti si sono persi nel cammino della vita. Un’insolita, deliziosa maniera di portare ottanta o novant’anni sulle spalle, osservo. Ma é cosí importante contare gli anni? No, si dicono gli Arakmbut, meglio andare per epoche: epoche di formazione (i giovani), epoche di realizzazione (gli adulti). E poi ci sono gli anziani, che meritano rispetto per la loro esperienza accumulata, che possono trasmettere ad altri.
E adesso eccoci tutti qua, bambini, adulti e anziani, sotto un albero frondoso, ad ascoltare nel vento della sera il racconto di quel giorno che cambió la loro storia.
Quel giorno, comincia Bayacope, eravamo nascosti in una zona acquitrinosa piena di palme di aguaje, aspettando da un momento all’altro di sentire lo scalpiccio furioso degli zoccoli delle huanganas, i maiali selvatici, che arrivano correndo in gruppi di cento individui, facendo tremare il suolo. Ci eravamo dipinti sul corpo con achiote, i disegni propiziatori della caccia, e portavamo i capelli raccolti in una coda. Ci sentivamo forti e ben addestrati, per una delle tante battute di caccia, che erano la nostra vita.
Ci rendemmo conto molto presto che non eravamo gli unici ad aspettare le fragorose huanganas. Alle nostre spalle, alcuni giaguari stavano in agguato, aspettando che entrassero nel loro campo visivo i piccoli del gruppo, che non riuscivano a seguire il ritmo della corsa e per questo potevano cadere facile preda dei loro denti affilati. Ma il rumore che sentimmo non aveva niente a che vedere con le huanganas. Anzi, non somigliava a nessuno dei suoni che conoscevamo.
-Ehi, viene dal cielo! Guarda che grande quel gallinaccio che ci sta volando sopra la testa, Sueyo! - Dissi al mio compagno.
Sí, assomigliava a un grande gallinaccio quello strano volatile, ma lo seguiva una lunga scia di fumo, e perché mai? Lo vedemmo lasciar cadere qualcosa e sparire all’orizzonte.
Facendo molta attenzione, ci avvicinammo per capire di che si trattava, e tirammo su con la punta della freccia dei pezzi di tela. Osservammo che erano cuciti in modo tale che in alcuni potessero entrarci le gambe, in altri le braccia, ma a cosa mai potevano servire? Se era freddo, bastava accendere il fuoco. E in piú, quella tela ci sembrava avesse cattivo odore. No, non ci piacque. Per cui, la allontanammo con la punta della freccia e la nascondemmo in un buco scavato nella terra, pestandoci sopra altra terra. E poi, vedemmo sparse qua e lá molte palline colorate, a cui demmo una rapida leccata…avevano un gusto dolce... ma se erano velenose? Via, ben dentro la terra anche quelle. C’erano invece altri due oggetti che non smettevamo mai di osservare, e rigirare, e provare, una, due, moltissime volte. Erano machetes cosí affilati che potevano tagliare con un solo colpo varie canne. Zas e zas. Ottimo! Quelli sí che ce li portammo alla maloca contenti, tagliando e caricando un grosso fascio di canne lungo il cammino.
Come ci ricevettero nelle malocas? Ovviamente molto contenti, per le canne e i machetes, ma restavano troppe domande senza risposta, ad aleggiare nelle nostre notti intorno al fuoco. Giorni dopo, uno dei nostri uomini stava pescando, quando apparve nel fiume un’imbarcazione guidata da un Huachipaeri, carica di uomini bianchi. Il loro capo pareva un anziano dalla lunga barba. Uno sparo, e il pescatore cadde pesantemente nell’acqua. I bianchi sembravano pentiti di averlo ferito (ma allora, perché avevano sparato?), e nelle malocas cresceva l’agitazione. Chi erano quegli intrusi? Si chiesero anche gli uomini di altri de nostri clan, che cominciarono ad affinare le frecce sui formicai, e a scendere dalle alture. La tensione cresceva. Anche in cielo si accumulavano nuvoloni, ricordo, e guizzavano lampi, ma non pioveva. Il giorno dopo, riuniti in un alto dirupo, noi Arakmbut vedemmo venire lentamente verso di noi l’anziano con la barba bianca che teneva alta, in mano, una croce. Era solo, e aveva lasciato indietro quelli che l’accompagnavano.
-Cosa sei venuto a fare, straniero?- chiese il nostro curaca, il capo della comunitá.
-A mangiare sardine con voi- rispose l’anziano, nella nostra lingua. Questo ci sorprese molto. Ovviamente. L’uomo sorrise vedendo i machetes che avevamo in mano noi due, Sueyo ed io.
-Ah, ce li avete portati voi? Avanti, allora, si serva- E il curaca invitó l’anziano a mangiare dei pesci freschissimi, appena cotti nelle foglie di banano, e poi gli offrí pezzi di canna da zucchero, fette di ananas e guayaba, mettendogli a disposizione l’abbondanza della selva. Ma noi uomini restammo in cerchio, con le frecce in mano, disposti a trafiggerlo in caso osservassimo un movimento ostile. Non lo facemmo.
-Vedo che siete in molti, e avete bisogno di altri machete. Ve li porterò.
Lo straniero ringrazió per l’ottimo cibo, e con un gesto di saluto giró le spalle e si allontanò. Come sapemmo poi, quell’ostinato frate (il domenicano spagnolo padre José Alvarez) aveva passato la notte pregando e, prima ancora, molto tempo studiando la nostra lingua, cercando in tutti i modi l’occasione e i mezzi per contattarci. Per anni e anni. Fino a quel fatidico giorno del 1950, quando un’avioneta pagata da una compagnia nordamericana, la Fondazione Wener Gren, poté trasportarlo a sorvolare il mare di verde dove serpeggiava lento e solitario il grande Amaru Mayo, ora Madre de Dios.
Un Huachipaeri gli riferí che aveva sognato che noi Arakmbut non l’avremmo ucciso. Superstizioni, rispose lui. Questo non voleva assolutamente dire che non si sarebbero stati gravi rischi nella sua dissennata impresa, pensava.
L’Amaru Mayo, il Madre de Dios, per noi ha uno spirito. Ce l’hanno anche le collpas, gli strapiombi di argilla dove i guacamayos arrivavano con strepito alle prime luci dell’alba. Ce l’hanno le lagune, che riflettono nelle loro acque immobili una corona di alberi verdi.
Cosa pensarono gli spiriti della selva quando questo rumoroso apparato ruppe per la prima volta il silenzio dei fiumi, le lagune, gli alberi? Non lo sappiamo. Forse, piansero.
Arrivarono altri machetes e, con loro, altre morti. La prima fu quella del pescatore ferito dai bianchi della barca, poi quella di sua moglie e dei suoi figlioletti. I parenti bruciavano le cose dei defunti e li seppellivano, piangendo. Chi era quello stregone cosí potente che aveva potuto provocare tante morti? Stava succedendo qualcosa di strano, che non sapevamo spiegarci. Era febbre gialla, venimmo a sapere tempo dopo. Un giorno apparve di nuovo la canoa dei vicini Huachipaeri, a portarci un messaggio dell’anziano dalla barba bianca: “Ho la medicina giusta per curarvi. Seguitemi e vi salveró”.
Giorni dopo, abbandonammo il nostro territorio, che conoscevamo palmo a palmo, in marcia verso lo sconosciuto e minaccioso mondo dei bianchi. Non avevamo alternative.
Dal fiume Huandandakhue, camminammo nel folto della foresta, aprendoci sentieri col machete, ed arrivammo alcuni giorni dopo alla missione di Shintuya.
La missione crebbe di giorno in giorno, arrivando ad ospitare 500-600 persone fra Toyeri, Huachipaeri, Sapiteri, tutti insieme, senza distinzione di lingue o clan. Mentre la compagnia americana Andean Petroleum costruiva una strada che tagliava la foresta, il padre Alvarez cominció a organizzare la vita di noi indigeni, impiantando coltivazioni di caffé e cacao. La giornata cominciava prestissimo con la messa, e poi, a lavorare nelle piantagioni. Chi non lavorava, non mangiava. In casi ostinati, i padri arrivavano a darci punizioni corporali. Ai suoi occhi eravamo capre testarde, ma lui lo era piú di noi, mi sembrava. Ogni giorno si accendevano liti fra gente di differenti popoli, obbligati a stare addossati l’uno all’altro, quando fino allora avevano avuto a disposizione gli spazi immensi della selva. Ci accusavamo reciprocamente di stregoneria, perché le malattie continuavano a decimarci, e nessuno sapeva né da cosa erano causate, né come curarle. Nemmeno le potenti medicine del padre Alvarez pareva servissero a qualcosa. L’anziano padre era molto affettuoso con noi, e a volte ci abbracciava. Noi restavamo sorpresi, perché noi non ci esprimiamo cosí.
Peró, tra risse e malattie, quella non si poteva dire vita. E in una notte piena di lampi (nel 1969) Kentepo, Irey, io Bayacope, Sueyo e molte altre famiglie, decidemmo di lasciare dietro di noi meschinitá e limitazioni. La missione restó quasi deserta. Dicono che il vecchio padre s’inginocchió davanti alla croce e pregó cosí:
“Cosa vogliono da me, Signore, questi Harakmbut? Gli ho dato ambulatorio medico, vestiti, segheria, allevamento di polli. Che altro vogliono?”
Il Signore non rispose in quel momento, o almeno, nessuno lo sentí. Se ce l’avesse chiesto a noi, invece, gli avremmo risposto:
“Perché obbligarci a vivere appiccicati come in scatole di sardine, quando fuori c’é una selva immensa? Perché tutto questo lavorare dall’alba al tramonto, per poi mangiare peggio di prima?
Ma i tempi erano cambiati, purtroppo. Quando finalmente ci levammo di dosso quei fastidiosi vestiti da “civilizzati”, che ci riempivano la pelle di bolle e irritazioni, ed arrivammo, adorni solo dei nostri tatuaggi, nelle strade di Porto Maldonado, la gente ci rise dietro. Capimmo allora che se volevamo trattare con la gente della cittá, dovevamo mascherarci come loro.
Da qualche anno, c’é di nuovo la febbre dell’oro nel Madre de Dios. Si é arricchita soprattutto la gente di fuori, che fa lavorare peones e ragazzini, a volte in condizioni infami. Quando anche qualcuno di noi si é trovato con un bel pacchetto di denaro in mano, per mancanza di esperienza l’ha perso in poco tempo: tra furti, inganni, acquisti inutili. Abbiamo constatato a nostre spese come il denaro arriva a cambiare le persone, e la nostra vita in genere. I giovani non sono piú interessati a vivere nella selva, e vogliono andare tutti a Porto Maldonado, magari lavorando in un negozio, e farsi giri in moto avanti e indietro. Nella cittá i giovani imparano che esistono furti, abusi, ubriacature. Manca una vera educazione che aiuti a orientarsi in mezzo a tanti eccessi.
Sapete cosa penso io, Bayacope-Tarzan? io che sono della stirpe della Vera Gente, e un vero Tarzan di una selva vera, come dite voi: Il denaro a noi non serve. Se ci deve togliere quello che vale veramente la pena: vivere in pace con la famiglia, con il fiume e la foresta-.
Ringrazio Bayacope e Sueyo per questa impressionante testimonianza, e ritorno pensosa a Puerto Maldonado, dove cerco di interessare le autorità alla tremenda situazione dei ragazzi, appena adolescenti, che lavorano nella ricerca dell’oro.
-Ma no, impossibile, è un’esagerazione. E´ sicura, signora, di aver visto questi ragazzi?
E´chiaro che la loro esistenza è ostinatamente e coscientemente ignorata dalle burocrazie locali, a cui sfugge l’esuberante informalitá della vita.
Data la situazione, le loro condizioni di vita e lavoro resteranno penose, fino a quando cambieranno le leggi. Ma, prima delle leggi, cambia la tecnologia.
Adesso sono enormi bulldozer a sbancare rive e fondali, per estrarne la polvere d’oro del Madre de Dios, nella zona di Huepetue, concentrando in poche macchine il lavoro di centinaia di braccia, distruggendo la vegetazione, gettando mercurio nel fiume. E una luna desolata si alza sulla terra ora nuda e violata, arida come un deserto, dove prima palpitava un universo di vita.
Anni dopo quel fatidico giorno del Grande Gallinaccio, dalla Spagna, dove sta morendo il vecchio missionario padre Alvarez, arriva ai frati domenicani il suo ultimo messaggio:
-Proteggete i miei figli, gli Harakmbut.
Mi duole la schiena. Mi bruciano gli occhi. La luce del giorno si sta facendo eccessiva. E mi viene il ricordo di quei dolori acuti che mi facevano piegare in due, di tanto in tanto, mentre servivo succo d’arancia tra le vacche selezionate di Berlino, e si ripetono a Puno.
-Oggi non posso lavorare con te- dico a Sara, una mia giovane collega che si sta specializzando in medicina tradizionale andina. Siamo a casa mia. Ogni tanto mi sento trafiggere da un dolore che mi lascia senza respiro. Sara mi aiuta a stendermi sul letto, preoccupata.
-Cosa ti senti, esattamente, Marianna?- mi chiede.
- Non so piú a che santo pregare, Sara mia. In Germania ho fatto tutte le analisi possibili, visitato ginecologi ed endocrinologi, ingurgitato pastiglie di tutti i colori, e niente. Per un bel po’ mi sentii bene, ma da qualche tempo, qui a Puno, sono tornati piú forti di prima. Si tratta dell’utero e delle ovaie. Mi sembra di avere qualcosa che mi tritura dentro, ma gli analgesici servono a poco, e non voglio diventarne dipendente. Conosci per caso qualche infusione d’erbe che mi possa alleviare il dolore?
Sara è una ragazza dai capelli scuri raccolti in una crocchia, che sembra piú interessata agli studi che agli amori: forse anche troppo seria, penso qualche volta. Si concentra un attimo prima di rispondermi.
-A questo punto, perché non vai direttamente dal mio amico curandero Feliciano Quispe, per una diagnosi e una cura piú precisa? È un tipo onesto- mi assicura.
-Perché non ho la più pallida idea di cosa possa farmi…Non mi passerà un cuy, il coniglietto delle Indie sul corpo? Non lo sopporterei proprio, ti avviso!
Mi giro inquieta nel letto, e cerco di alzarmi. Una fitta terribile mi fa desistere. No, non ce la faccio.
- Se vuoi, ti spiego qualcosa, warmi.- Sara mi accarezza con un sorriso la fronte sudata. Mi sento piú sollevata.
- Come sai, dai tempi dei tempi si pratica in Perù una mescolanza di atti curativi e religiosi, per curare i malati. Forse hai già provato i bagni di fiori o di vapore, o la diagnosi di una malattia attraverso il cuy. (Sí, il coniglietto d’India, che viene sacrificato per vedere se hai i reni o lo stomaco infiammato). Adesso in certi casi i malati vengono curati con farmaci o piante, mentre in epoca precolombiana, si sanava solo con orazioni e piante.
-Con che risultati? –chiedo debolmente.
- Le piante, per esempio, erano largamente sperimentate prima di essere applicate per curare, per cui riuscivano ad essere efficaci. Le orazioni creavano un’atmosfera mistica e non sappiamo fino a che punto i guaritori vi ricorressero come un semplice espediente per captare la fiducia dei pazienti, e poi applicare cure effettive, come quelle con le piante. Peró nessuno dubita, dai tempi di Galeno, come la fiducia fra medico, curandero o paziente sia importantissima nel processo di guarigione.
-Eppure questo tipo di medicina tradizionale è sempre stata considerata folklorica dai medici in camice bianco…cioè non garantisce un risultato al cento per cento…-insisto.
-Se per questo, nessun tipo di medicina lo garantisce, Marianna. Piuttosto, c’è da dire che questa nostra medicina non è stata codificata secondo criteri scientifici occidentali, in collegi medici e biblioteche, ma si tramanda empiricamente, con rituali quasi segreti, per cui non ha avuto un riconoscimento ufficiale. Ma se i guaritori non riuscivano a rimettere in piedi i loro pazienti, poveri loro! Fra i Mochica potevano essere sepolti vivi! I precolombiani non sopportavano i ciarlatani… E ricordi la storia di quel povero spagnolo, fra’ Diego de Ortiz, che non riuscì a curare l’inca Tito Cusi, discendente di Atahualpa… e per questo fu fatto morire dissanguato. Insomma, per amore o per forza i guaritori cercavano di mettercela tutta!
Mentre parla, Sara mi massaggia delicatamente le tempie. Cerco di rilassarmi. Mi sento leggermente meglio. Solo un po’. Ma apprezzo il suo sforzo.
-Non lo dubito, cara. Mi sembra molto interessante quanto dici, ma ripeto che non voglio che mi passino sul corpo un coniglietto delle Indie, neanche se fosse stato l’animale preferito di Atahualpa.
Sara ride, prendendomi una mano.
-Tranquilla, non si tratta di un cuy, o coniglietto che dir si voglia: Alberto diagnostica le malattie con un uovo.
-Un uovo?
-Sí, un comunissimo uovo di una comunissima gallina. Lo vedrai. In quanto al cuy, si tratta di una tradizione cosí antica che anche i Romani ne facevano uso (ancora!). Come e perché funzioni, non si sa, ma funziona. Comunque, adesso basta con le chiacchiere. Pensaci. Se i tuoi scrupolosi medici tedeschi non hanno saputo dirti esattamente cosa ti faceva star male, nonostante tante analisi e cure, perché non provi con Alberto? Peggio di cosí non puoi stare …, ma comunque, decidi tu!
E Sara se ne va con un sorriso fino alle orecchie.
-Venga con un uovo fresco, e lo tenga in mano per un po’- mi raccomanda quest’uomo di mezza età, dagli zigomi pronunciati e la capigliatura nera e folta, tipica della gente andina.- Alberto Quispe, sono qui per servirti.
Lo saluto cercando di nascondere la mia sfiducia e tradurla in un neutro “vediamo”. E intanto osservo che nella sala d’attesa si ammucchia una ventina di persone, pronte invece a mettere una mano sul fuoco sulla sua capacità come curandero, perché il fegato di un cugino o i reni di un cognato o il cuore della nonna sono stati rimessi a posto da quel brav’uomo, e adesso sono come cera nelle sue mani. Alberto comincia con l’ordinarmi un bagno di fiori, per ripulirmi della negatività che tengo accumulata addosso (dice) e farmi sentire di nuovo vitale. Quando torno da lui con l’uovo piú fresco che trovo, me lo passa a qualche centimetro dal corpo, avanti e indietro, sul tronco, il bacino, le gambe, la testa. E alla fine, lo rompe. Non posso credere ai miei occhi. L’uovo è pieno di una materia sanguinolenta. Accidenti!
-E’ danno- sentenzia.
-Danno, in che senso?
-Beh, danno. C’è bisogno di spiegartelo? Non hai nessuna rivale che ti abbia potuto fare un maleficio?
Rivali di sicuro ne ho, o meglio, ne avevo in abbondanza. Ma non m’immaginavo la brillante biologa Susan preparandomi nei suoi alambicchi una pozione pestifera, o la tappabuchi Margrit, la donna per tutte le stagioni, mettersi durante la luna piena a fare rituali contro la malefica Marianna, a meno che…Sybil? E´una stravagante artista d’avanguardia, con cui Markus ha tenuto una breve avventura, e più che camminare, sembra avanzare fra le masse anonime portando la sua vagina in processione. Si dice che sia una fedele seguace di certi sciamani che fanno rima con ciarlatani... (fatti suoi, basta che non venga a rompere le scatole a me). Ma pensiamoci un attimo: credo davvero che Sybil si sia messa a trafiggere con degli spilloni una bamboletta che mi rappresentava, per regalarmi con un po’ di fortuna, un incidente aereo o un biglietto per un camion che finisce in fondo al burrone? No, non ci credo. E non perché magari non lo abbia potuto desiderare in qualche momento, ma perché io sono a seimila km di distanza, fuori servizio, fuori luogo, out, capito Sybil?, e il signor Markus è solo l’Ex-Uomo della mia vita, che più ex non si può. E poi, qualsiasi cosa abbia escogitato Sybil, é riuscita ad ammaliare Markus solo per un soffio. Dove sará il trucco?
Ogni due giorni torno da Alberto a vedere come vanno i miei organi un po’ malconci. I dolori stanno diminuendo, il tuorlo d’uovo è più chiaro. Ogni volta, osservo con grande attenzione se fa qualche gesto strano. Non lo vedo, o non riesco a vederlo. Tant’è. Dopo un mese mi sento perfettamente a posto, e l’interno dell’uovo è normale. Pago per il lavoro di Alberto una cifra modesta, e lo saluto con più rispetto di quando sono entrata. Devo avvisare Sara di questi risultati, ne sará contenta. Infatti, mi accoglie con un abbraccio caloroso.
- Ma…tutta questa storia dell’uovo non sarà frutto di suggestione? – le chiedo sedendomi alla sua tavola, dove si allineano mucchietti ordinati di piante medicinali.
-Mi pare che non sei andata da lui piena di fiducia, vero? Al contrario. Probabilmente l’uovo, come le viscere del cuy, il volo degli uccelli eccetera, funzionano come un rivelatore, un indicatore. Tu avevi un male probabilmente di natura psicosomatica, (guarda caso gli organi della femminilità che hai vissuto drammaticamente), ma di questo non hai parlato coi tuoi medici tedeschi.
-Nemmeno col curandero, per la verità.
Sara mi prepara un tè di coca, disponendosi ad avere un altro po’ di pazienza con me.
-Ma in questo caso non è necessario, Marianna, perché lui usa strumenti differenti per diagnosticare. Non bisturi, ma simboli. Succhiare una ferita provocata dal morso di un serpente per togliere il veleno é normale, no? Per associazione, se il curandero succhia una parte del corpo malata, il paziente pensa che gli si stia estraendo l’origine del male. Che sia vero o no, l’importante é che lo creda. Questa é la parte magico-religiosa del sistema. In questo caso, l’uovo é rivelatore dei processi interiori. Poi, ovviamente, c´é l’uso delle piante, le diete, eccetera, che sono la parte curativa piú vicina alla medicina occidentale. Mi guardo allo specchio, pensierosa. I miei occhi scuri brillano sotto la frangetta perfetta. Mi rendo conto che tutte le Sybyl del mondo sono fantasmi. È stata la mia propria sofferenza ad ammalarmi, devo concludere, anche se mi costa ammetterlo. C´era tanto in gioco che valesse la pena? La risposta é superflua. Comunque sia, lí c´é Marianna, esemplare unico al mondo, col suo corpo sinuoso, e il suo pensiero che a volte vola oltre le nubi, piú in lá dell’orizzonte, cercando l’infinito. Nessun altro puó e sa prendersi cura di me, se io stessa non mi apprezzo.
Lavoro duramente, e la sera vorrei tornare in una vera casa. Una via di mezzo fra la villa dai pavimenti lucidi di dove provengo, e gli anonimi parallepipedi con tetto di alluminio che fanno di Puno poco piú che un accampamento di minatori: sará possibile trovarla proprio qui? Aspiro a una dimora essenziale e gradevole, con gerani alle finestre e tende colorate, secondo il mio gusto europeo, posso dirlo? Cerca di qui e cerca di lá, finalmente trovo nei dintorni di Puno una casetta di dove si gode uno splendido panorama di laghi e montagne. Ma senz’acqua né luce, ci dispiace signora, domani sicuramente lo sistemeremo, mi dice l’idraulico.
Tiro avanti parecchi domani con secchi d’acqua e candele, fino a quando possiamo dare finalmente il benvenuto alla luce, che rende piú vivibile la notte. Viene a vivere con me, per qualche mese, una pedagoga di Arequipa, Esther, di trentacinque anni, capelli nerissimi e un sorriso raggiante. Con lei diamo gli ultimi ritocchi alla casa, annaffiamo e concimiamo dei gracili gerani, tingiamo dei vecchi mobili, e alla fine mettiamo su delle allegre tende rosse di tela bayeta. La compro al mercato da una mamita abbigliata secondo l’usanza andina con una quantità di gonne colorate sovrapposte una all’altra, un grembiule pieno di tasche segrete che la fa assomigliare a una grossa cipolla, e una bombetta con tanto di fiocco nero sulle trecce lunghissime. Mi piace negoziare, e chiedo uno sconto, mil gracias! La signora me lo fa se compro anche i tradizionali torelli di ceramica, da mettere sui tetti di casa, come simbolo di fertilitá e abbondanza. D’accordo, prendo anche i torelli e torno a casa contenta.
Anche Esther ama andare a far compere peró qualche giorno dopo, la vedo tornare sconvolta dal mercato delle verdure.
-Cos´ho fatto perché mi trattino tutti come una…puttana?- si chiede fra i singhiozzi.
- Cosa ti è successo, stella? Perché non hai preso un taxi?-le chiedo.
-Infatti l’ho preso…ma quello svergognato di un tassista mi ha chiesto quando prendevo per fargli un buon pompino. Poco prima, un verduraio mi aveva palpato il sedere, e il macellaio, in un momento in cui non c’era nessuno nel negozio, mi ha proposto di fare un sandwich speciale, “Io fra te e la gringa, che dici?”
Resto un attimo perplessa, e poi… ah, giá, le tende rosse! Evidentemente la luce che filtra da quelle insolite tende sta lanciando imprevisti segnali erotici ai passanti. Dovró aggiungerne un altro paio di piú scure, da usare la notte. A pensarci bene, che due donne vivano sole é considerata una stramberia, in questi paraggi. Se non sono monache, sicuramente sono prostitute. Ma com’é oscillante la vox populi! Poco tempo dopo, senza che siano cambiate di una virgola le nostre abitudini sessuali, nel paese si commenta che in quella casa lá fuori, con le tende rosse, vivono delle suore, e c’é una gringa tedesca che fa da badessa.
Risolto questo problema d’immagine, la vita in casa va a meraviglia. Fuori, un po’ meno. La tensione nell’altipiano sta crescendo. Dalla sierra di Ayacucho, i seguaci di Abimael Guzman hanno ampliato il loro raggio d’azione, facendo saltare posti di polizia nella sierra. A me cominciano a succedere cose strane, una dietro l’altra.
Come quel giorno della dinamite, che non dimenticheró mai.
Scendo in cittá con la mia Volskswagen, per dare un corso di formazione a dei maestri. Illusa. Oggi i miei maestri hanno ben altro da fare. Sono tutti in strada, con altri centinaia di docenti venuti da tutto il dipartimento, e fra slogans e bandiere stanno dandosele di santa ragione con la polizia. Bastonate da una parte, lanci di pietre dall’altra. Le bandiere dei sindacati vengono abbattute, ma qualcuno le risolleva in mezzo alle grida. NO AI SALARI DA FAME! Ancora una volta sento risuonare nei vicoli di Puno questo slogan che ho sentito altre dieci, mille volte, nelle strade e piazze del Perú. Con risultati praticamente nulli. Anzi, immagino giá cosa seguirá, secondo un ben noto copione. Dopo l’aperitivo di bastonate e sassaiole, alla polizia cominceranno a girare le scatole davvero e procederanno al lancio di gas lacrimogeni, accompagnato da qualche sparo, sporadico sí, ma sufficiente a lasciare in mezzo alla strada un corpo o due senza vita.
Visto che la mia presenza in mezzo al tafferuglio non aiuterebbe in nessuno modo a pacificare gli animi, faccio un giro piú largo per evitare le strade piú congestionate dove potrei restare intrappolata, e cerco di parcheggiare la macchina in una piazza piú tranquilla.
Crasso errore, anche questo. Tranquilla? Un’improvvisa detonazione mi fa sobbalzare al volante, spaventa uno stormo di gallinacci che vola via stridendo, fa tremare i vetri delle case vicine e …poco piú in lá, sta riducendo in un ammasso di rottami fumanti una camionetta della polizia stazionata sul marciapiede. Accidenti! penso, con lo stomaco svuotato dall’ansia…bastava facessi qualche metro in piú e anch’io finivo come una torcia umana nei rottami fumanti della mia Olivia… Resto un attimo a guardare intontita l’ammasso di ferraglie, indecisa sul tragitto da fare per allontanarmi di lí prima possibile, quando mi sento afferrare da due, anzi quattro braccia durissime.
-Ehi, come vi permettete?-tento di difendermi.
-È lei che ha messo la bomba, vero? - mi gridano due sconosciuti agenti di polizia, trascinandomi a spintoni verso il piú vicino commissariato.
-Questa gringa che va in pantaloni, e guida da sola per le montagne... è da un po’ che la teniamo d’occhio, di certo ha a che fare coi senderisti...
-Appunto! Sono i gringos che hanno portato da noi il terrorismo, l’ha detto anche il presidente Bealunde…- sento che un agente sta dicendo all’altro. -E lei cammini, avanti! Non siamo qui per cogliere fiori…- mi riprende uno strattonandomi. Ci crede davvero, questo qua, o lo dice solo per impressionarmi?
-Ma siete m...? Voglio dire, come facevo a mettere la bomba se mezz’ora fa ero al mercato (chiedete pure!), e adesso, per poco non salta in aria anche la mia macchina?- cerco di spiegare. Ma é come parlare al vento. Nessuno dei due mi ascolta. Devo cercare qualche altro testimonio, penso freneticamente mentre quelle braccia odiose continuano a mantenermi nella loro morsa. I maestri no, chiedergli di testimoniare a mio favore in questo momento sarebbe una pessima idea…allora chi diavolo? Vediamo…
Un altro centinaio di metri ed eccoci davanti a un edificio basso e grigio, con lo stemma della repubblica del Perú, e una fila di sacchi di sabbia fuori della porta. Li devo seguire per un corridoio cupo, dietro uno sbattere di tacchi, un cancelletto di ferro che si apre, il rumore di grosse chiavi che lo richiude, lo sbattere di un’altra porta, ed eccomi in una stanzuccia, dove mi accoglie una zaffata di…aff, non vale la pena decifrare questo miasma di cattivi odori. Nella penombra intravedo macchie di umiditá e scritte oscene alle pareti. Proprio una bella idea è stata parcheggiare in quella piazza, mi dico. Una risata sguaiata si leva da un fagotto umano buttato lí in un angolo, e dopo la risata sento una voce roca che mi saluta con un “Finalmente ci arriva una bella femmina tettona, giusto quello che mi ci voleva, perché è un bel po’ che non scopo! … sono tutto suo signora, benvenuta all’inferno!” Altre sghignazzate gli rispondono dagli angoli. Sono due, no, anzi tre i fagotti umani buttati lí su due materassi grigiastri. Ubriachi fradici, sbattuti in carcere dopo una rissa, evidentemente. “Scelga me per stanotte…” “No, a me!” “Allora tutti e tre!” Voci, tosse e risate si sovrappongono in un crescendo. Questa sí che é una scena da film, penso. Anzi, un filmaccio dei peggiori, girato fra taverne medievali, navi di bucanieri, soldatacci di ventura. Cerco di non farmi prendere dal panico. COME USCIRE DA QUI, MALEDIZIONE. Marianna, stai calma, concentrati.
Adesso vedo una seggiola di metallo al lato di un materasso. Bene. E anche un finestrino, lá in alto, con un vetro cosi sporco che fa pochissima luce. Eppure fuori c’é un sole che spacca le pietre.
Prendo la seggiola e la piazzo sotto il finestrino. Ci salgo sopra e tiro un calcio alla mano che cerca di afferrarmi la caviglia.
- Sono disposta a stritolarla, quella mano, se qualcuno si azzarda a riprovarci, vi avviso!- minaccio. I compagni di cella mi rispondono con altre risate, ma giá un po’ meno strafottenti, mi par di capire.
- Ehi stai attento Efisio, che la signora morde! – Li lascio lí alle loro battute idiote, tanto, sono cosí sbronzi che non si reggono neanche in piedi…pulisco un po’ il finestrino con una manica, giusto a tempo per vedere, dall’altra parte del marciapiede, vari passanti scendere giú correndo per allontanarsi dalla zona dei disordini.
- Ehi, signori!- Mi metto a gridare con quanto fiato ho in gola. Due o tre di loro alzano gli occhi per vedere chi si sta sbracciando al finestrino… del commissariato di polizia? Via, alla larga! Chi camminava di fretta si mette a correre, chi stava giá correndo se la dá a gambe levate. Passa una buona mezz’ora, e nessuno si degna di dare ascolto ai miei richiami.
Comincio a scoraggiarmi. Ma ecco che vedo scendere giú proprio dal marciapiede piú vicino una signora con una gonna pesante di lana verde, e la solita bombetta in equilibrio sulle trecce, che cammina in fretta ma non sembra cosí nervosa come gli altri. È lei, mi dico, la mia salvezza. Cerco di impressionarla con un “MAMITA PER FAVORE!”, gridato a pieni polmoni. Anzi, agito pure il lembo di una sciarpa che riesco a far uscire dal finestrino, schiacciandomi un dito. Lei continua per la sua strada…no, sta rallentando,… si sta fermando, la bella signora andina con la sua meravigliosa bombetta su quelle splendide trecce. È ferma. Si è fermata! E adesso si gira! Sí, sta guardando in alto chiedendosi di chi è quella sciarpa che si agita, e quella voce che rompe i timpani…
-Mamita, per favore signora, é urgente! - le grido appena incontro il suo sguardo.
-Avvisi la signora Esther, la conosce, no? che avvisi il direttore Mamani, che avvisi l’ambasciatore tedesco! Che mi portino via di qua, che non ho fatto niente!!
-Che???- La mamita continua a studiarmi stralunata, con la sua bombetta in diagonale sulle trecce. Daiiiii, svegliaaaa!
-Ah...- dice finalmente dopo dieci lunghissimi secondi, (tic tic tic tic...) in cui deve aver frugato nei suoi cassetti mentali per trovare qualche traccia della mia fisionomia.- Ah, lei é la gringa tedesca, no? Sisí, andró ad avvisare la signora Esther!- E la vedo affrettare il suo passo dondolante, con la sua bombetta in bilico, che non perde gradi del suo angolo acuto neanche nel saltellare dei passetti che girano l’angolo.
Di sicuro va ad avvisarla appena puó, la buona signora dalla bombetta equilibrista, ma non riesce ad evitarmi il regalo di un paio di notti, passate seduta sulla sedia con gli occhi sbarrati e pronti a fulminare chi mi si avvicini a una distanza inferiore al metro, tra i miei ineffabili compagni di cella, ma loro per fortuna, dopo aver cantato un paio di canzonacce, ruttato e sgracchiato a loro piacere, cominciano a ronfare come trattori in salita su un campo di sassi e carciofi spinosi.
Due giorni dopo, alle undici in punto, arrivano finalmente i colleghi, i documenti, le credenziali, le assicurazioni dell’ambasciata tedesca, a testimoniare che mai e poi mai la signora Weiser potrebbe avere contatti con gruppi terroristi..., (vogliamo scherzare?) e anche quelle del ministero peruviano, (dichiariamo solennemente che la signora Marianna Weiser collabora con il Ministero della Pubblica Istruzione in qualitá di esperta in educazione bilingue, svolgendo un lavoro ineccepibile, eccetera eccetera), insomma si puó scrivere la parola FINE su questo pessimo film di bucanieri e taverne.
Riprendo la mia borsa, e con un sospiro di sollievo faccio per scapparmene via il piú velocemente possibile. Ho due tremende occhiaie scure, e un leggero tremolio alle mani, per le due notti passate senza chiudere occhio. Non vedo l’ora di un buon bagno e poi dormire fino al giorno dopo. Me ne vado senza neanche un cenno di saluto. Eppure il commissario mi lancia un ultimo avviso. È libera ma schedata, e la terremo sott´occhio, ci siamo spiegati?
Rispondo alzando gli occhi al cielo ed esco in strada. Esther mi sta aspettando lá fuori da almeno un’ora, e mi viene incontro con un abbraccio. Passa qualche minuto prima che mi si calmi il tremito alle mani e mi senta di accendere il motore della mia Volskswagen. Dopo un po’, la mia casetta panoramica dalle tende rosse e la porta verde mi appare in fondo alla strada polverosa, come una fonte d’acqua gorgogliante in mezzo al deserto. Finalmente.
Tutto continua uguale, osservo, come se non fosse successo nulla, tra i miei gerani con qualche foglia secca, una tazza di caffè dimenticata sul tavolo, una coperta caduta dal divano. Esther, appena avvisata, era corsa via facendo miracoli tra i suoi contatti per raccogliere i documenti che mi avrebbero liberato.
Faccio per distendermi sul letto esausta, quando sento che qualcuno sta battendo leggermente alla finestra. Potró starmene un po’ in pace una buona volta? Mi dico.
-Ha bisogno di qualcosa?- sento chiedermi da una voce conosciuta.
É donna Amelia, una vicina assolutamente gentile, (e straordinariamente) discreta.
- Grazie, veramente ho solo bisogno di riposare un po’.
Ma lei non si muove. Qualche attimo d’incertezza e poi mi dice.
-Beh, era un po’ che volevo dirglielo, Marianna. Non ha ancora fatto quello che doveva?
-Dovevo cosa? A chi? Per favore, si spieghi meglio perché non so di che parla.
-L’offerta alla Pachamama, no? La madre Terra. Non ricorda che le ho detto che questa casa é stata costruita sul terreno di antiche chullpas, o tombe di nobili, e chi viene a vivere qua deve chiedere il permesso alla Pachamama perché ci consenta di vivere in questo luogo speciale?
-Davvero? No, non me ne ricordo, ho avuto tanto da fare... Ho visto solo il bel panorama, ma non conosco la storia di questo luogo.
-Come no, se ha una storia!- ripete misteriosamente donna Amelia.- E le dó un consiglio, poi veda lei.
Ovviamente seguo il suo consiglio, non si sa mai, perché so che ha buone intenzioni. Anche se, come col curandero Alberto, navigo in acque sconosciute, e io devo lasciare (con gli occhi ben aperti!) che altri agiscano, con altri codici. E vado a trovare un anziano aimara, don Manuel, esperto in cerimonie come l’ offerta alla Pachamama, secondo la regola ancestrale della reciprocitá. Tu le offri qualcosa, e lei ti ricompensa con buoni frutti, e un senso di pienezza e di pace nella tua vita. Perché la Madre Terra, come le montagne e le lagune, é fonte di vita e merita rispetto, doña Marianna, mi spiega. Fin qui, sono d’accordo. Anzi, d’accordissimo.
-Cosa devo portare per fare l’offerta?
- Compri al mercato delle streghe questa lista di oggetti.
E mi passa un foglietto dove ha annotato, a quanto ricordo: alcune candele, un fazzoletto pieno di petali di garofano, un mucchietto di foglie di coca, un feto di lama…Ah, e anche una buona quantitá di bosta. So giá come usare lo sterco di vacca, preziosissimo in quest’altipiano senza alberi. Ma non ho idea di come potrá servire nell’offerta alla Pachamama.
-Venga venerdí notte. Da sola, con le sue candele- mi dice don Manuel, che di giorno lavora come spazzino. Bisogna fare una cerimonia per tre notti, per tre settimane.
Arriva il venerdí notte, con la luna alta nel cielo. Il freddo è pungente: Don Manuel indossa un poncho di lana spessa, a strisce rosse e marroni, sull’abito liso di tutti i giorni, e ha un chullo che gli copre la testa. Io sono protetta da un buon giaccone di piume nordiche, ho con me una coperta d’alpaca per avvolgermi durante la cerimonia notturna, e sono piena di curiositá.
Dopo un breve saluto, don Manuel mi avvisa di seguirlo in silenzio fino a uno spiazzo lá in alto, dove i venti frustano l’erba dura. Il grandioso paesaggio montano è immerso nel silenzio. Anche il vento tace, e tutto sembra sospeso nell’attesa di qualcosa di sacro. Una volta arrivati allo spiazzo, don Manuel pone con cura per terra la sua manta. Poi con gesti precisi tira fuori da una piccola borsa di tela delle foglie di coca, e comincia a lanciarle lentamente nell’aria. Come fará a cogliere il loro misterioso messaggio? Mi chiedo osservando i loro volteggi. L’anziano mormora di tanto in tanto qualche parola, e continua a lanciare in aria le foglie, una dopo l’altra. Lo seguo assorta nei suoi gesti silenziosi. Trascorre lentamente la notte. Finalmente, poco prima dell’alba, don Manuel mi fa cenno con la testa di seguirlo fin sulla cima della montagna. Cammino ansimando un po’ dietro al suo passo agile, per un lungo, lunghissimo tratto in ripida salita, con la fatica di chi é nato in altri paralleli. E finalmente raggiungiamo la vetta, un breve spazio sassoso in mezzo a rocce giganti.
La notte é ancora vestita del suo mantello nero, ma in fondo al cielo le stelle cominciano a impallidire, inseguite dalle linee arancioni che fendono l’orizzonte.
Quando le linee si congiungono in una splendida luce giallo-rosa, don Manuel accende un fuoco con la bosta. Mentre brucia tabacco, semi e fiori, invoca apus e santi, rivolto ai quattro punti cardinali. Durante le orazioni, io non devo guardare indietro. Ubbidisco e ripeto mentalmente le preghiere, senza farmi domande. L’aria si sta facendo piú tiepida, il cielo piú rosa. Finalmente, si alza un sole trionfante, a scaldare il pianeta. Il grandioso Inti degli Incas. La cerimonia è terminata.
Il ritorno lo facciamo quasi di corsa, zigzagando fra i sassi, nonostante la stanchezza. E adesso devo riposare un po’, grazie don Manuel, spero che la Pachamama sia contenta. Passano otto ore, e sto ancora dormendo. Esther mi chiama per la cena, due o tre volte, ma la porta della mia stanza resta chiusa. La mattina dopo, Esther va a lavorare, lasciandomi immersa in un sonno profondo.
Finalmente, che ora sará? Le tre del pomeriggio! Accidenti…apro gli occhi. Poso i miei piedi nudi sul tappeto di pelliccia bianca di pecora che copre il pavimento di legno, e apro le finestre. Accarezzo le foglie dei miei gerani, respiro con gratitudine. E mi sento in perfetta armonia, in perfetta pace, come non mi sentivo da secoli. E non so ancora il perché.
Quante volte la mia vita è rimasta appesa a un filo, arruffato da un imbroglio improvviso? Come quella volta che viaggiai da Lima a Puno in bus, fra sierra e deserti, per gustare piú lentamente la bellezza di questi paesaggi esagerati.
Giá sulle pendici delle Ande, il bus arranca nella notte, oscillando nella salita cinquanta fagotti umani addormentati. Il motore é mantenuto ancora in prima, per un lungo tratto in salita, che affronta ruggendo e gemendo.
Accidenti, che freddo! Sento la testa pesarmi per la mancanza di ossigeno, ma per prudenza cerco di non perdere di vista l’autista, un uomo grassotto, avvolto da una sciarpa fatta a mano, che guida ingabbiato al volante. Con questa nebbia che cancella la strada, speriamo che riesca a capire se la curva va a destra o sinistra, mi dico. Non c´’è ombra di segnali, figuriamoci.
Finalmente, l’altipiano emerge maestoso da un mare di nubi, col suo orizzonte nitido di picchi appuntiti, illuminati dalla luna. Adesso il bus va in terza, lasciandosi dietro una fumata nerastra. Dietro ogni curva, il panorama continua a ad ampliarsi intorno al bus, che al confronto si fa sempre piú piccolo, un rospetto- un grillo- una formica- un moscerino... di fronte ai profili giganteschi delle rocce, interrotti dalle macchie stellate di neve. Con il vento che grida nel silenzio sibili spaventati...
Questi picchi gelati ti osservano sotto le stelle, dall’alto del loro silenzio senza testimoni, tra lotte solitarie di condor. Una stalattita di gelo si rompe nell’aria rarefatta dei seimila metri, con il nevischio che mulinella sui licheni e le pozze di smeraldo delle lagune. La natura pare seguire indifferente la sua vita millenaria, senza il fastidio degli omuncoli che pestino le sue nevi vergini. Anni e anni di silenzio, scavando e seccando lagune, con il vento a scolpire lentamente le rocce. E le rocce a disgregarsi, senza rumore, e le pietre piú piccole a rotolare giú anno dopo anno, di secoli di vento e silenzio...
Lá in fondo, un deserto lungo migliaia di km, accecato dal sole, incontra le onde fragorose dell’oceano, lontano da queste vette coperte di nubi. Ogni tanto, una scossa piú forte. E allora non sono pietre a rotolare saltando, ma blocchi pesanti di fango che si abbattono cancellando geografie, e seppellendo laghi, popoli e cittá, se li incontra sul suo devastante cammino. I condor volano spaventati, forse, e poi tornano a volteggiare sugli abissi.
Quelle montagne esistevano prima che comparissero gli “uomini della Luna”, l’affascinante regno del Gran Chimú, che aveva riempito le valli del deserto a nord del Perú, di piramidi e palazzi con disegni policromi di pesci e giaguari. In quel tempo i signori mantenevano un’intera corte di artigiani, gioiellieri, tintori, suonatori di conchiglie e maestri di piumaggi. Corti di api regine. Intanto i contadini brulicavano come formiche intorno ai fiumi che scendevano impetuosi dalle Ande, per imbrigliare l’acqua in lunghissimi canali che correvano gorgogliando fino alle oasi del deserto.
Mi par di vederle quelle formichine Mochica, con il viso dipinto di rosso e nero e i ponchos disegnati a quadri e stelle, ponendo uno sopra l’altro, nel giro di qualche secolo, 25 milioni di mattoni di adobe, per innalzare al Sole la sua Piramide. O pascolando i loro greggi di lama sulle pendici verdi delle oasi, e cantando ubriachi di chicha nelle feste rituali. Como sará stata la vita di una di queste piccole donne che si pettinavano le trecce di fronte a uno specchio di ossidiana e turchese, prima di mettersi a tessere i fili sottilissimi di vigogna o le trame impalpabili di vestiti di piume?
Me le immagino sedute al lato del fuoco alimentato da sterco di lama, mentre raccontano la loro vita nelle ceramiche che paiono animarsi sotto le loro piccole mani scurite dal sole, tutto ció che un’occhiata puó cogliere... Le danze rituali degli uomini vestiti da uccello, i supplizi dei rei sepolti vivi nel deserto, o spinti al mare dagli abissi costieri, le mani dei curanderos sui corpi degli infermi, i dolori pieni di gioia del parto. E i giochi allucinati dell’amore, in tutte le sue varianti e posizioni.... Questo mentre in Europa, negli stessi tempi, nei manuali per confessori si affermava che si poteva toccare la sposa solo per procreare, possibilmente piangendo di vergogna. Chissá quando avevamo cominciato a perdere la festa dei sensi per incorsettarla in santi ingessati?
Con la morte, i signori del Gran Chimú entravano in un regno ancora piú grande, a cui solo loro avevano accesso, portandosi dietro spose e servi preferiti, e cibo e gioielli.
Le donne Mochica continuarono a dipingere le loro vite dominate dalla luce misteriosa della luna, fino a quando le truppe scelte dell’Impero del Sole scesero dalle Ande, per vincere i loro uomini in battaglia, vicino al Palazzo dei sette muri di Paramonga. Lo stesso palazzo che contemplarono ammirati, un secolo dopo, i barbuti cavalieri di Pizarro, arrivati dal nord, attraverso la strada principale tracciata per i monti e valli del continente, per unire popoli e genti sotto il dominio dell’Inca, il figlio del Sole. Il Camino Real avanzava come un serpente di pietra, per migliaia di chilometri nel deserto, fra dune e boschi di carrube, ombreggiato a volte da alberi dove gridavano i pappagalli, e fiancheggiato da un muro che lo proteggeva dal vento. Duemilacinquecento chilometri di sole e luna.
Sí, quelle Ande imponenti che nascevano dalle colline grigie del deserto e che adesso il bus sembrava guardare intimorito percorrendo l’altipiano, esistevano anche prima che lá sotto apparissero i popoli della Luna e del Sole, coi loro fagotti di piume, sale, e sogni tenaci. I venti del deserto avevano fatto volare poco a poco le loro pietre ostinate, ma quelle montagne rimarranno lá invitte, forse anche dopo che gli ultimi uomini della terra avranno annientato l’un l’altro, con futuribili armi supersoniche, i loro sogni malati.
I miei pensieri svolazzano inquieti oltre il finestrino, perdendosi nella nebbia.
Il bus ha cominciato una discesa rapidissima, ma non si sa verso dove. Accidenti, che succede? In pochi secondi salto al lato dell’autista che, adesso mi rendo conto, ha abbassato la testa sul volante, e lo scuoto per le spalle.
-Ehi! Che...? cazzo!... L’uomo apre gli occhi stravolto, e gira bruscamente il volante, rimettendo il bus in carreggiata, invece di proseguire dritto verso l’abisso che fiancheggia la strada. Qualche passeggero si é alzato dal sedile stropicciandosi gli occhi, mentre altri seguono incoscienti i loro sogni oscillanti.
-Senta, lo pagano per guidare, no?- gli grido.-Lo denunceró alla polizia per la sua guida irresponsabile! Si rende conto che per pochi secondi in piú, potevamo finire nel burrone ridotti in poltiglia?- Ho bisogno di gridare per dimenticare il tremito delle gambe. E il suo aiutante dov’é finito? L’ho visto scendere in un paesino, e chi s’é visto s’é visto, mentre invece doveva... doveva...
-No! Tutto meno la polizia! Si calmi signora! - mi supplica l’autista.- Ma lei di dove viene? scusi se mi permetto, dalla Germania? Ah, capisco, lá é un’altra cosa. Se sapesse cosa mi ha fatto la polizia, non me la nominerebbe di certo...- mi avvisa abbassando la voce. – È proprio grazie a quei fottuti poliziotti che mi tocca guidare questo rottame di bus coi freni scassati... Neanche all’impresa di trasporto gli interessa la nostra vita, a quegli stronzi! Domani, domani, ci rispondono sempre quelli degli Angelitos Negros quando li avvisiamo che questi freni devono essere cambiati. Io li riparo come posso, chiaro ci tengo alla mia vita... un giorno o l’altro possono saltare, e finiamo tutti come piatto forte per gli avvoltoi... Beh, sto scherzando, adesso non la voglio spaventare. Piuttosto, signora, non avrá un po’ di caffé?
Sí, per fortuna ne ho un po’ nel thermos. E anche due mandarini spiaccicati, in fondo allo zaino. E al diavolo gli avvoltoi, adesso! Lá in fondo vedo un cartello che attrae la mia attenzione. “Al Condor de Oro”, é l’orgogliosa insegna di un ristorantino sgangherato, in mezzo al niente. Ci fermiamo. Il menú é di quelli che ti lanciano bombe nello stomaco, caricate di peperoncino. L’autista mi si avvicina, perché lo onori con la mia compagnia al suo tavolo, scusandosi.
-Pancho Samaná, a suo servizio, - si presenta dandomi la mano, e sfoggiando un sorriso con due denti d’oro in primo piano. Perché un giorno era stato re, Pancho Samaná.
-E adesso, da re a schiavo del volante...- comincia a raccontare attaccando un piatto di fagioli con uovo fritto, e un porcellino d’India anch’esso fritto, tutto rannicchiato con le sue zampette, che va tagliato ferocemente, come una violazione, prima di potersi dedicare a mangiarlo.
-Non sa com’era bello il mio camion, signora...tutto dipinto di giallo, coi bordi rossi. Anni e anni di lavoro, per pagarlo! “Tigre di Andahuaylas”, si chiamava, perché vi avevo applicato il gran muso di una tigre con le fauci aperte e un motto scritto con le mie mani:
“L’O FATTO COL MIO SFORZO MUOIANO gliINVIDIOSI”. Altri ci scrivono, sul camion: “Curve e buchi mi consumano...”, o “La gelosia ti distrugge, figliola”. “Se vuoi scopare la polvere, seguimi”.... Io no, non avevo tempo per le donne, solo una birretta fra uomini di tanto in tanto, dopo aver pagato un’altra rata del mutuo. Il mio Tigre non aveva misteri per me, e non rida, signora?... Marianna. Mia moglie si accorge da una tossetta o un sospiro se i figli si stanno ammalando, io sentivo dal rumore del motore se c’era qualche ingranaggio che non faceva il suo dovere. Allora scendevo coi miei ferri, lo sistemavo, e dopo proseguivamo contenti. Fino a quel maledetto giorno...
-Insomma, che successe quel giorno? Mi dá un po’ di fagioli a cambio di questo cuy, poveretto?
-Va bene, adesso le racconto.
-Quel giorno ci fu una perdita nel deposito di carburante, la riparammo come meglio potemmo ma, per continuare, bisognava cercare benzina... E cammina cammina in una pampa a 3800 metri di altezza, io e il mio aiutante facemmo una ventina di chilometri con il nevischio in faccia, fino al paesino seguente, dove conoscevo un compare che ha sempre un po’ di riserva. Ma non lo trovammo, e la cugina di sua zia lo mandó a cercare. Insomma, alla fine, e dai e dai, e questo e quello, per favore cognato, ritorniamo con un bidone, inseriamo la chiave, e con tutto il carico di tonno e burro da consegnare lo stesso giorno, una fretta terribile, fu lì che apparvero i poliziotti, questi figli di p.. scusi signora, in Germania come si dirá? Ah. Arshloch. “Le fatture stanno qui, é tutto in ordine, ecco qua anche quelle del tonno, del sapone e del burro”. Per cui non capisco perché quei fottuti ci bendarono e ci buttarono al lato della strda col culo del fucile... Certo, un machete lo tenevamo sempre nella cabina del camion, non si sa mai, ma come darlo in testa ai tutori dell’ordine, armati di tutto punto e con carnet d’identitá in ordine? Adesso lo so, siamo stati scemi, non abbiamo avuto fegato... e cosí il mio Tigre sparí in mezzo al nevischio, e noi buttati nell’erba, legati come salsicce. Dopo, chissá fu l’anima santa di mia madre che venne ad aiutarci, e potemmo liberarci delle bende con i denti...
La nevicata aveva smesso, ma nessuno dei veicoli che passava si fermava... Chi si arrischiava a raccoglierci, se potevamo essere terroristi che cercavano di far pagare una taglia? Una collaborazione per la rivoluzione, compare! Ci dicono quando abbiamo la sfiga di incocciarli in qualche carretera sperduta. Di fronte a una mitragliatrice tu glieli dai quei sudici biglietti, come no! con tutto il cuore, basta che ti lascino in pace e non ti prendano il camion per fare gli attentati grossi: quelli con trecento o cinquecento chili di dinamite, sa?, quelli che per esempio hanno fatto saltare a Lima i vetri del banco Sudameris, o il Continental, e fanno un buco di sei metri in strada. E gli edifici restano con gli occhi vuoti, i ferri contorti all’aria, che tristezza, l’ho visto piú di una volta...
Sí, che tristezza. Come adesso. Un orrore infinito.
-Ma, in generale i terrucos preferiscono le camionette per fare gli attentati normali, quelli a un posto di polizia, un canale di televisione, un’ambasciata. Deve sapere signora, che bisogna fare molta attenzione per strada. Se non ti attaccano terrucos veri, possono farlo delinquenti mascherati da terrucos, con una mitragliatrice e un passamontagna, e via, oppure poliziotti che si comportano da delinquenti, o delinquenti mascherati da poliziotti, insomma ce n’è da scegliere... Ovviamente sí, la facemmo la denuncia al commissariato, non siamo cosí scemi, no? “Investigheremo”, ci risposero, “state tranquilli”. Il camion lo trovarono giorni dopo, ma squartato come un agnello, il mio Tigre: senza carico, senza motore, senza ruote, senza tutti i pezzi che potevano essere venduti nel mercato informale di Arequipa o Puno, o addirittura a Lima. Restava solo la scritta: L´O FATTO COL MIO SFORZO. Eppure, se sono sopravvissuto alla gringa col machete, significa che gli invidiosi hanno ancora da invidiarmi, e non sanno chi é Pancho Samaná!
Ricompare un attimo la sua risata dai denti d’oro, mentre sorbiamo un brodino marrone annacquato che chiamano caffé. Allora, mentre gli altri 48 passeggeri fanno la coda di fronte alla stanzina con due miracolosi bidoni d’acqua e un buco nel pavimento, chiamato BAGNO, perché non mi racconta della gringa col machete? E me la immagino come una scena da film, che Pancho Samaná commenta ispirato.
-Successe lá, nel deserto infinito che costeggia il mare. Ore e ore di solitudine, con l’aiutante salito in cima ai sacchi di farina, piú un po’ di farina che usciva dalla scucitura di qualche sacco, insomma alla fine del viaggio il Negrito sembrava un Babbo Natale. E la salsa martellava alla radio: Divorami ancora, divorami ancora...
“Una radio con ritmo sexy”, si definisce, ma questa volta era un martirio, funzionava male ed emetteva via via dei sibili che mi trapanavano gli orecchi... lei crede negli ufo, signora Marianna? Non li ha mai visti? Mi hanno detto che in certi punti del deserto la gente va a aspettarli. Come diavolo sará questa storia? E le linee di Nazca..?- Ventitré persone nella coda.
-Mi chiedo a volte come poterono farle, quelle grandi linee, gli abitanti del deserto, se non avevano un disco volante, o qualche aggeggio che volasse, per vedere dall’alto se i disegni venivano bene... Io passo spesso per questa zona, e una volta la conobbi quella famosa gringa matematica, la Marianna Reiche, immagino che abbia letto i suoi libri. E´una tedesca come lei, (ah lei non é tedesca? vabbé, comunque gringa), piú vecchia certo, adesso quasi cieca, si sa che passó la vita spazzando ogni giorno le linee di Nazca, perché la polvere non le sommergesse facendole sparire. La pioggia no, non c’é pericolo perché lá non piove mai. Me l’immagino quando arrivó al porto del Callao molti anni fa, una signorina tedesca dagli occhi chiari, e una valigia di cuoio piena di libri di matematica, perché andava a fare da istitutrice ai figli di un ambasciatore... Una pazzia, per quell’epoca, una donna che viaggiava sola per gli oceani, e sapeva tutta la matematica, quando a me fanno sudare i conti della benzina e le fatture del tonno... E in quella casa piena di porcellane sentí parlare delle linee di Nazca e si mise a pensare come diavolo facevano le mummie a calcolare tutte queste linee che si incrociavano. Le mummie, voglio dire, prima che diventassero mummie si chiamavano Paracas o qualcosa di simile, lei che ha studiato lo saprá meglio di me, ed erano gente fuori serie, se sapevano fare nel deserto disegni lunghi chilometri e chilometri. Se ne vedono ancora, rannicchiate nei loro cuscini funerari, in mezzo alla sabbia, tutte scurite dal sole, ma ancora coi capelli neri come se fossero morte ieri. Ci sono intere pampe che nascondono tombe e i tombaroli continuano a trovarne, avvolte nei loro mantelli ben ricamati.
Mi hanno detto che la gringa matematica un giorno lasció la casa lussuosa dell’ambasciatore e se ne andó a dormire in una capanna di contadini in una hacienda vicina alla pampa di Nazca, pur di poter camminarci sopra avanti e indietro per fare i suoi calcoli, tanti chilometri e anni e anni di polvere, accidenti, spazzando le linee e scrivendo numeri su numeri, calcolando in quali giorni i raggi del sole si alzavano su quali linee, e dove tramontavano le Pleiadi... C’era chi la chiedeva in matrimonio, a questa gringa bionda dagli occhi azzurri, grossi terratenientes e colonnelli, ma lei rispondeva che preferiva spazzare il deserto al lavare i calzini di un uomo che l’avrebbe chiusa in casa, meno male che la mia Rosita me li lava... Altri pensavano, magari, che era una strega... ma adesso vengono da tutto il mondo a visitare la signora Maria Reiche. Mi pare che alle gringhe come voi bisogna rispettarle, o tenerle alla larga, non si sa mai che non ti prendano a schiaffi...
Ancora dieci persone nella coda. Sí, ma... e la gringa del machete?
Questa fu peggio, molto peggio, signora...
Stavo guidando, come sempre, per questa Panamericana interminabile con i suoi buchi improvvisi e il mare al fondo dell’abisso, senza muro di contenzione,... e magari di notte ti trovi davanti all’improvviso un idiota che ha fermato il camion quasi in mezzo alla strada, senza luci, e se non sei piú che veloce ti trovi spiaccicato sul vetro, ciaaá!, come un uccello distratto. No, questa volta era di giorno, il Negrito come sempre stava sui sacchi, il deserto tremava di calore... giá avevamo passato la parte con i cactus bassi, dopo quella delle pietre grigie come la luna, per chilometri e chilometri. Dopo, c´é un’altra parte come onde di sabbia che sembrano il fondo del mare, tutte ondine piccole e parallele, come se tremassero di paura. Ah, se il mare un giorno si sbaglia di misura e viene il tsunami, a mangiarsi il burrone costiero e tutti i camionisti con il loro carico di sardine!... come quella volta che arrivó con le sue ondacce maledette fino al quinto piano delle case del Callao...
Sette persone nella coda...
-Stavo dicendo che quel giorno passai la curva dove molti la vedono, la gringa bionda che fa autostop, meno male stavolta non c’era, ma quando mi girai un attimo, mi si geló il sangue.
Lei era al mio fianco, seduta sulla coperta di alpaca che mi porto sempre dietro in viaggio, tutta vestita di nero, quella strega, con quegli occhi azzurri immensi... e io non dovevo cadere nel fascino di quegli occhi, come era successo a tanti di noi. Perché quelli che si lasciano incantare dalla sua bellezza, vedendola al lato della strada, e la fanno salire sul camion,... da un momento all’altro, zas!, il camion finisce laggiú in fondo, schiantato sugli scogli. Sa chi ricordano quelle croci che si vedono piantate nella rena, giusto sulla curva? i camionisti ammaliati e fatti fuori dalla gringa...! Solo uno, che io sappia, riuscí a salvarsi. Me lo raccontó lui stesso ancora coi brividi addosso, il mio compare Pepito Rios, dev’essere che non era ancora il suo momento.
L’aveva visto all’improvviso, attaccata al vetro come un ragno gigantesco che le copriva la visuale della strada, mentre dall’altro lato stava arrivando un bus a gran velocitá, questi della Cruz del Sur che nei momenti pericolosi ti schiacciano senza pietá piuttosto che frenare... Ma lui sí, per fortuna riuscí a frenare il camion con la forza della disperazione, mentre gli occhi gli si stavano annebbiando.
Sono le anime dannate, signora, quelle che restano inquiete fino a che non ti vedono anche a te precipitare nell’inferno!... Perché mi guarda cosí doña Marianna?, noi camionisti lo sappiamo, le anime ti ipnotizzano se ti fermi a guardarle, e allora sei fregato hermano...
Sentivo giá la sua faccia gelata avvicinarsi alla mia, ma io volevo vivere, stracazzo, e quindi afferrai il machete come un fulmine e brandii un colpo tremendo senza guardare... e poi riaprii gli occhi, sollevato dal fatto che ero ancora vivo. Il camion aveva cominciato ad affrontare la salita, per questo riuscii a mantenere la direzione, ma non avevo il coraggio di guardare a lato... Alla fine mi girai... La maledetta non c’era piú. Sparita nel nulla. C’era solo una macchia di sangue che si allargava nel sedile.
Silenzio. Solo una persona nella coda. Guardo Pancho Samaná, anch’io con occhi straniti. I miei (brillanti) occhi color nocciola, non azzurri.
-Ma come, la macchia di sangue l’ha vista davvero allargarsi? Non era notte?
-Piú o meno, ma che importanza ha...? Perché mi guarda cosí, signora, con quegli occhi accesi come due lampadine? È che... qui non siamo in Germania... non se lo scordi.